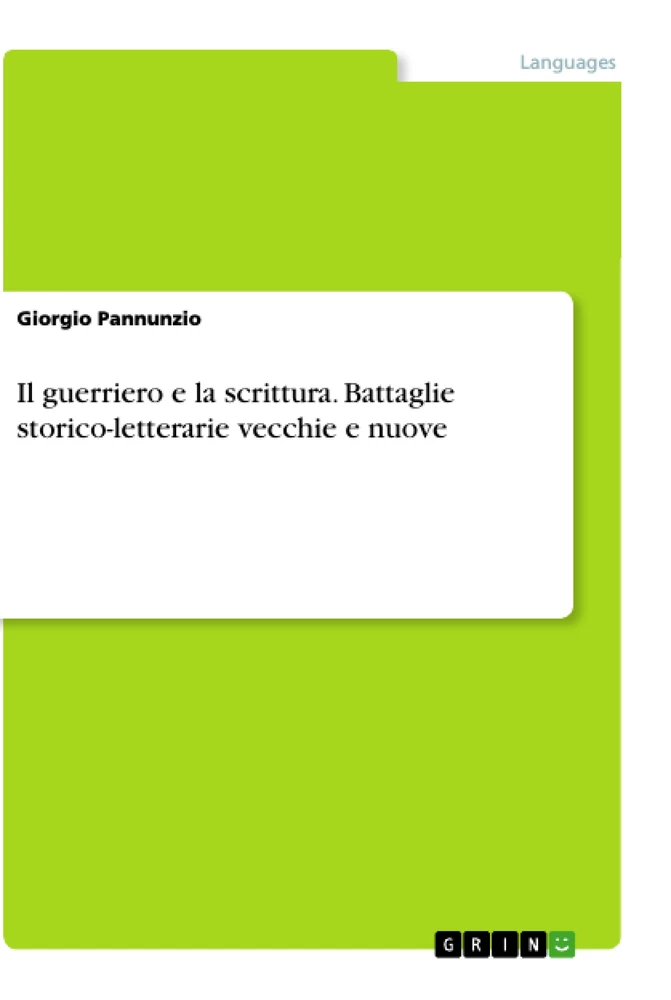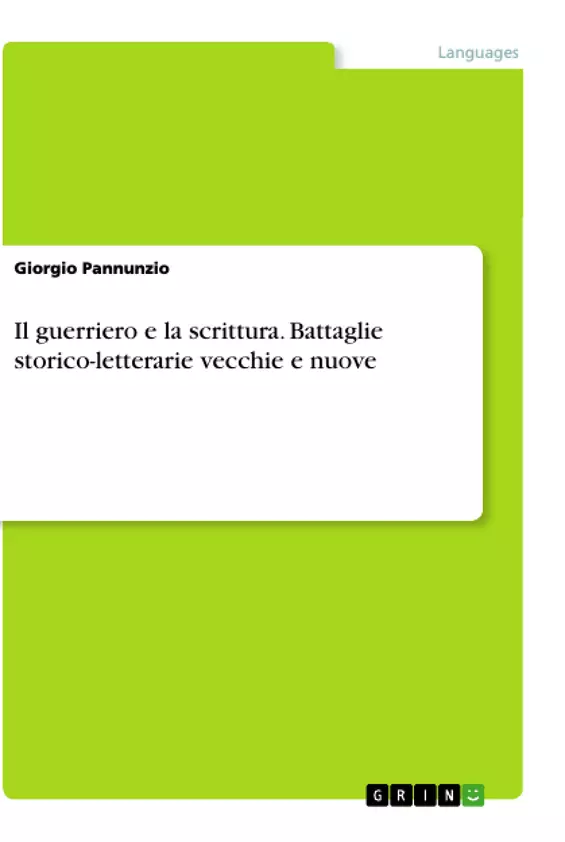I saggi qui raccolti, sostanzialmente omogenei dal punto di vista cronologico, hanno un unico comun denominatore: la ricerca semasiologica e semantemantica come grimaldello per scardinare il complesso sistema di rimandi e di provenienze di cui si nutrono gli autori studiati. Diseguali, essi hanno però l’obiettivo di chiarire, a partire dal dato lessematico e sintagmatico, come l’intersecarsi dei piani compositivi risponda a precise pulsioni personali, legate da un lato al dato della formazione primaria (autori prediletti, correnti letterarie di partenza, impianto antropologico, etc.), dall’altro alle necessità interpretative di chi fruisce il testo. I punti di partenza, nella critica semantematica delle fonti, non sono mai univoci, dipendendo essi da una risultanza diasistematica di più modelli.
Compito del semasiologo dei contenuti letterari è giustificare la presenza dell’elemento linguistico all’interno di una multiforme chiostra di paragrammi originari come qualcosa di precisato e voluto, anche palesando che l’evoluzione dei significati di una certa terminologia non è mai casuale, ma volontariamente determinata dagli eventi creativi posti in essere dal singolo scrittore. Sicché, dunque, parafrasando “au contraire” il Vernant, la scommessa in favore della diacronia dei significati (e al contempo della sincronia lessicologica) può essere vinta soltanto quando i due livelli vengano accostati strettamente, come in un unico ganglio vitale. Questi confini metodologici sono la causa per cui vengono conglomerati in un unico volume i vari testi ed è ad essi che si atterranno le analisi che seguono.
Inhaltsverzeichnis
- A PROPOSITO D'EPICA MEDIEVALE: IL CANTARE DI GIUSTO PALADINO EDITO DA VINCENZO CASSÌ
- Le paredre culte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Band versammelt verschiedene essays, die sich mit der semasiologischen und semantematischen Analyse von literarischen Texten befassen. Durch die Untersuchung des Wortschatzes und der Sprachstruktur der Werke möchte der Autor ein tieferes Verständnis der intertextuellen Bezüge, der individuellen stilistischen Prägung und der interpretativen Herausforderungen gewinnen. Die essays konzentrieren sich auf das Verständnis, wie literarische Texte aus ihren verschiedenen Bestandteilen (Wortschatz, Syntax, Komposition etc.) entstehen und auf die Rezeption des Lesers wirken.
- Die Bedeutung von semasiologischer und semantematischer Analyse in der literarischen Forschung
- Die Rolle der literarischen Tradition und der persönlichen Einflüsse auf die Werke der Autoren
- Die Beziehung zwischen Text und Leser und die Herausforderungen der Interpretation
- Die Evolution des Wortschatzes und der Bedeutung von Begriffen in literarischen Texten
- Der Vergleich zwischen synchroner und diachroner Analyse in der literarischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel „Le paredre culte“ befasst sich mit dem mittelalterlichen Epos in der italienischen Renaissance. Der Autor analysiert die intertextuellen Bezüge, die zwischen verschiedenen Autoren wie Ariosto, Boiardo und anderen bestehen, und untersucht die Entstehung des epischen Genres in der Stadt Ferrara.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Buches sind: Semasiologie, Semantik, intertextuelle Bezüge, literarische Tradition, episches Genre, Renaissance, Ferrara, Ariosto, Boiardo, Wortschatz, Syntax, Komposition, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der semasiologischen Analyse in diesem Buch?
Das Ziel ist es, den Wortschatz und die Sprachstruktur literarischer Texte zu untersuchen, um intertextuelle Bezüge und die individuellen Absichten der Autoren besser zu verstehen.
Welche literarische Epoche wird im Kapitel über Ferrara untersucht?
Das Buch befasst sich im ersten Kapitel mit dem mittelalterlichen Epos während der italienischen Renaissance in der Stadt Ferrara.
Welche Autoren stehen im Fokus der Untersuchung zum epischen Genre?
Es werden intertextuelle Bezüge zwischen bedeutenden Autoren wie Ariosto und Boiardo analysiert.
Was versteht der Autor unter „semantematischer Kritik“?
Es handelt sich um eine Methode, die den Ursprung und die Entwicklung von Wortbedeutungen als bewusst gewählte kreative Akte des Schriftstellers interpretiert.
Warum werden synchrone und diachrone Analysen kombiniert?
Nur durch die Verbindung der zeitgenössischen Wortverwendung (Synchronie) mit der historischen Bedeutungsentwicklung (Diachronie) lässt sich die volle Tiefe literarischer Inhalte erschließen.
Welche Rolle spielt die Rezeption des Lesers in der Arbeit?
Die Analyse untersucht, wie die sprachliche Komposition eines Textes auf die Interpretationsbedürfnisse des Lesers wirkt.
- Quote paper
- Giorgio Pannunzio (Author), 2021, Il guerriero e la scrittura. Battaglie storico-letterarie vecchie e nuove, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161015