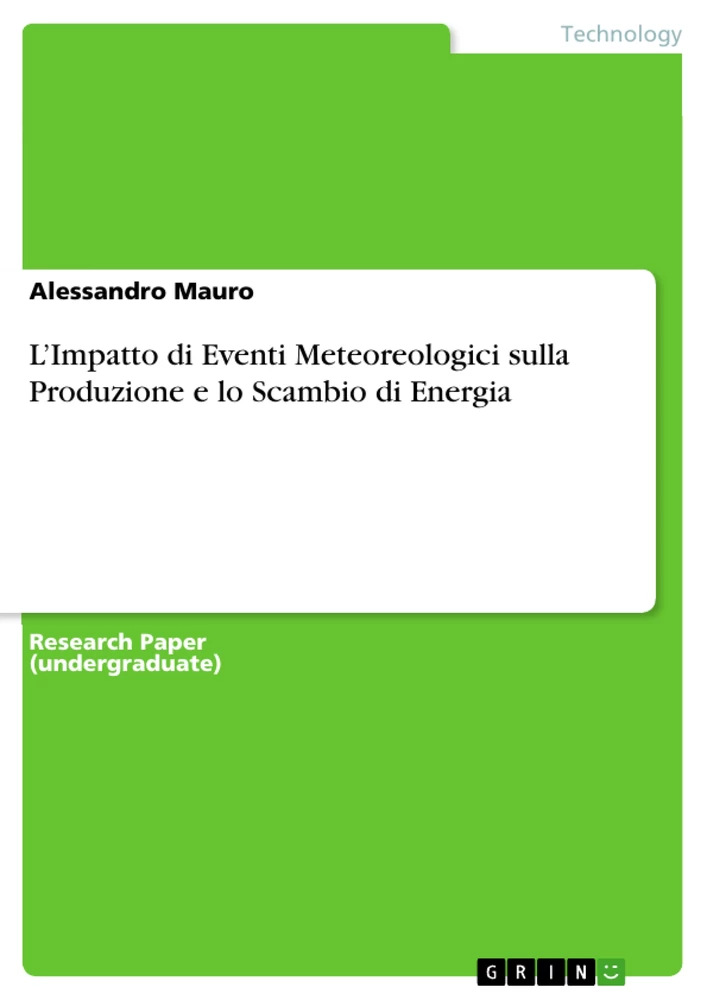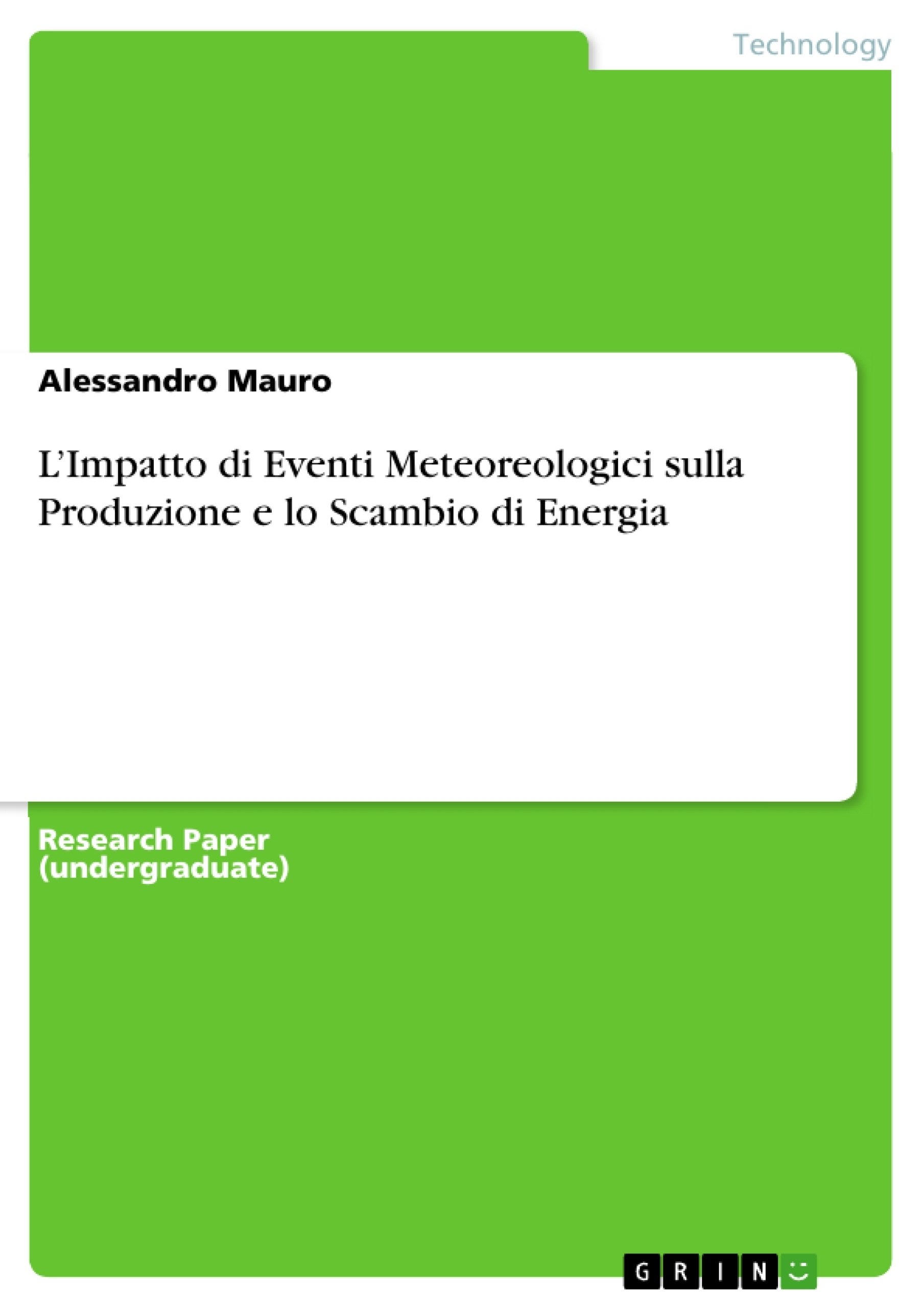Numerosi sono i fenomeni che si manifestano nell’atmosfera terrestre, in particolare nella parte più bassa chiamata Troposfera. Tra i più importanti ricordiamo il vento, le precipitazioni, l’insolazione e la nuvolosità, la nebbia, etc. Numerose sono anche le variabili atmosferiche quali la temperatura, l’umidità, la velocità del vento, la pressione barometrica, etc.
Solitamente queste variabili sono suscettibili di misurazione, rispetto ad un luogo ed un intervallo temporale specificati. Per le precipitazioni, è possibile misurare il livello della pioggia o della neve caduta in una località in una giornata. Nei fiumi e nei bacini è misurabile il livello o la velocità dell’acqua. Per il vento è rilevabile la velocità e la direzione. Per l’insolazione esiste una scala di misura della luminosità del giorno.
Gli eventi meteorologici che determinano le suddette variabili sono molto dissimili tra loro. Per esempio, alcuni fenomeni sono molto localizzati, in quanto vi è scarsa similitudine nel valore della misurazione per località geograficamente anche poco distanti. Inoltre solo quando si è in possesso di misure si può investigare il rapporto tra variabile meteorologica e rischio volumetrico.
Tutte le variabili meteorologiche sopra elencate hanno, come vedremo in questo libro, un impatto sull’industria e sul mercato dell’energia. Nell’analisi poniamo al centro dell’attenzione i mercati energetici, evidenziando in tale ambito quali siano i rischi meteorologici che determinano rischio volumetrico. Ciò permette di studiare fenomeni e variabili atmosferiche.
Oggetto di trattazione sono il mercato degli idrocarburi,la produzione e la domanda di energia elettrica, la produzione di energia elettrica dall'acqua e dal vento, l'emission trading.
Il libro contiene 19 figure. Una copiosa bibliografia riporta numerosi testi di riferimento per l'analisi del rapporto tra eventi meteoreologici e mercati dell'energia.
Il libro e' stato incluso per alcuni anni nel materiale del Master in Energy Finance (MEF) del MIP (Politecnico di Milano)
Inhaltsverzeichnis (Indice)
:- Introduzione
- Il mercato degli idrocarburi e l'utilizzo di stoccaggi.
- La domanda e la produzione di energia elettrica
- La produzione di energia elettrica dal vento....
- La produzione di energia elettrica dall'acqua.
- Eventi meteorologici ed emission trading…...\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Obiettivi e Temi Principali)
:Il testo analizza l'impatto degli eventi meteorologici sulla produzione e lo scambio di energia, focalizzandosi sui mercati energetici e sui rischi meteorologici che determinano rischio volumetrico.
- Impatto degli eventi meteorologici sul mercato degli idrocarburi
- Analisi della produzione di energia elettrica
- Influenza degli eventi meteorologici sulle fonti rinnovabili
- Rischio meteorologico ed emission trading
Zusammenfassung der Kapitel (Riepilogo dei Capitoli)
:- Introduzione: Il testo presenta un'introduzione al tema dell'impatto degli eventi meteorologici sui mercati energetici, descrivendo le principali variabili atmosferiche e il loro ruolo nell'influenzare la produzione e lo scambio di energia.
- Il mercato degli idrocarburi e l'utilizzo di stoccaggi.: Questo capitolo si focalizza sul mercato degli idrocarburi, analizzando l'estrazione, il trasporto e lo stoccaggio di fonti fossili come petrolio e gas naturale. Vengono esaminati gli effetti degli eventi meteorologici sulla produzione, con particolare attenzione a casi reali come il rigido inverno del 2005-2006 e gli uragani Katrina e Rita.
- La domanda e la produzione di energia elettrica: Questo capitolo esamina la domanda e la produzione di energia elettrica, analizzando l'influenza degli eventi meteorologici sulle centrali termoelettriche e sui sistemi di distribuzione.
Schlüsselwörter (Parole chiave)
:Il testo affronta tematiche come l'impatto dei fenomeni meteorologici sui mercati energetici, il rischio volumetrico, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi, la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, l'emission trading e l'analisi di casi reali.
Domande frequenti
Qual è l'obiettivo principale del libro?
Il testo analizza l'impatto degli eventi meteorologici sulla produzione e lo scambio di energia, focalizzandosi sui rischi volumetrici nei mercati energetici.
Quali variabili atmosferiche vengono considerate nell'analisi?
Vengono esaminate variabili come il vento, le precipitazioni, l'insolazione, la nuvolosità, la temperatura e la pressione barometrica.
In che modo il meteo influenza il mercato degli idrocarburi?
Gli eventi meteorologici influenzano l'estrazione, il trasporto e lo stoccaggio, come dimostrato dai casi degli uragani Katrina e Rita o del rigido inverno 2005-2006.
Il libro tratta anche di energie rinnovabili?
Sì, viene analizzata specificamente la produzione di energia elettrica derivante dall'acqua (idroelettrico) e dal vento (eolico).
Cosa si intende per "rischio volumetrico" in questo contesto?
Si riferisce al rischio legato alla variazione delle quantità prodotte o domandate di energia a causa di fattori esterni come i fenomeni atmosferici.
Il testo è stato utilizzato in contesti accademici?
Sì, è stato incluso per anni nel materiale del Master in Energy Finance (MEF) del Politecnico di Milano.
- Quote paper
- Alessandro Mauro (Author), 2007, L’Impatto di Eventi Meteoreologici sulla Produzione e lo Scambio di Energia, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195614