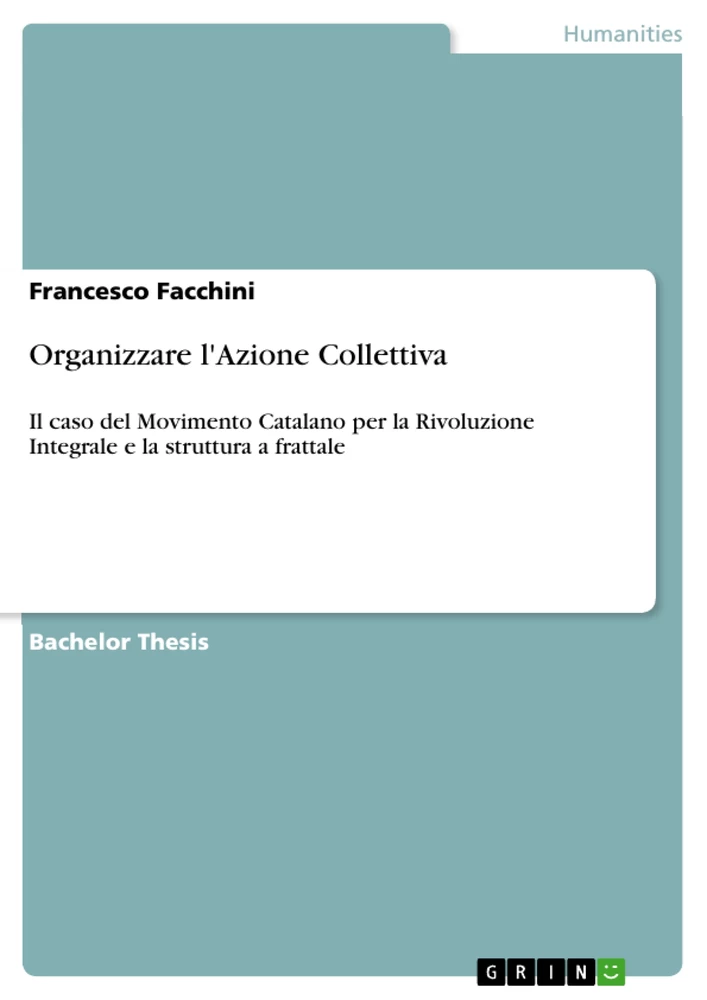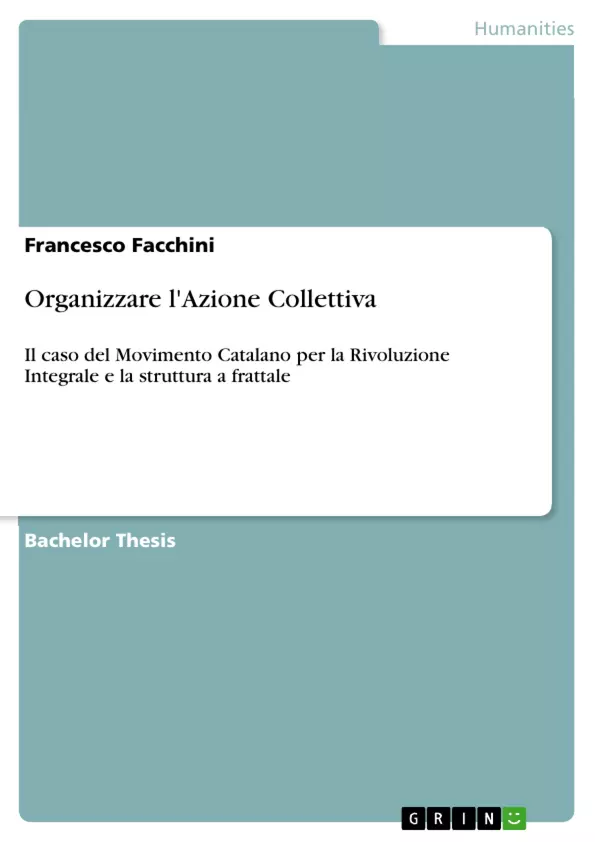All'interno del seguente elaborato si andrà ad analizzare un tipo di forma organizzativa - ovvero la struttura a frattale - dei movimenti sociali. In particolare, si è deciso di adottare la metodologia dello studio di caso al fine di arrivare ad una comprensione più profonda a livello qualitativo della dimensione organizzativa del Movimento per la Rivoluzione Integrale (MRI) in Catalogna.
Partiremo quindi da un preambolo per presentare brevemente la storia delle mobilitazioni a favore della Rivoluzione Integrale ed i suoi principi (Cap. 3), passando in seguito alla spiegazione del perché esse possano essere considerate un movimento sociale (Cap. 4). Nel Cap. 5 svolgeremo invece uno studio comparativo volto all'individuazione di analogie e contrasti con tre tipologie di movimenti in espansione nella società contemporanea (Movimento Cooperativista, Movimenti Urbani e Movimento di Transizione).
Dopo aver delineato in questo modo le caratteristiche principali del movimento dedicheremo il Cap. 6.1. all'approfondimento del suo fattore organizzativo, basandoci sui materiali da esso forniti. Esso, come vedremo, è formato da un insieme di progetti pubblici ed autonomi (Progetti di Servizi Comuni, Progetti Autonomi d'Iniziativa Collettivizzata e Progetti Autonomi) che si integrano e fanno parte di processi collettivi (Cooperativa Integrale, EcoReti, Nuclei d'Autogestione Locale), componendo ciò che il MRI definisce Rete Territoriale (RT). L'organizzazione del movimento si caratterizza in questo modo per una struttura a frattale, per la quale la forma è invariante al cambiamento della scala. Ovvero, ogni componente della RT presenta gli stessi caratteri - derivanti dai principi della Rivoluzione Integrale - conservando la propria autonomia e libertà in una relazione orizzontale con le altre.
INDICE:
1. INTRODUZIONE
2. METODOLOGIA
3. PREAMBOLO: BREVE STORIA DELLA RIVOLUZIONE INTEGRALE
4. LA RIVOLUZIONE INTEGRALE COME MOVIMENTO SOCIALE
5. STUDIO COMPARATIVO DEL MOVIMENTO:
5.1. MRI e Movimento Cooperativista
5.2. MRI e Movimenti Urbani
5.3. MRI e Movimento di Transizione;
6. LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DEL MRI
6.1. FORMA ORGANIZZATIVA: LA RETE TERRITORIALE
6.1.1. Processi collettivi;
6.1.2. Processi pubblici ed autonomi;
6.1.3. La struttura a frattale;
6.2. SPIEGAZIONI TEORICHE
6.2.1. Il “come” del fattore organizzativo nel MRI e le sue conseguenze:
6.2.1.1. MRI e Teoria della Mobilitazione delle Risorse (TMR);
6.2.1.2. Il modello di Kriesi: la traiettoria dell'Organizzazione del Movimento Sociale (OMS);
6.2.1.3. L'OMS come struttura delle opportunità emozionali;
6.2.2. Il “perchè” del fattore organizzativo nel MRI:
6.2.2.1. MRI e Teoria dei Nuovi Movimenti Sociali;
7. CONSIDERAZIONI FINALI
8. CONCLUSIONI
9. APPENDICE: ALLEGATI
10. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
1. INTRODUZIONE
All'interno del seguente elaborato si andrà ad analizzare un tipo di forma organizzativa - ovvero la struttura a frattale - dei movimenti sociali. In particolare, si è deciso di adottare la metodologia dello studio di caso al fine di arrivare ad una comprensione più profonda a livello qualitativo della dimensione organizzativa del Movimento per la Rivoluzione Integrale (MRI) in Catalogna.
Partiremo quindi da un preambolo per presentare brevemente la storia delle mobilitazioni a favore della Rivoluzione Integrale ed i suoi principi (Cap. 3), passando in seguito alla spiegazione del perché esse possano essere considerate un movimento sociale (Cap. 4). Nel Cap. 5 svolgeremo invece uno studio comparativo volto all'individuazione di analogie e contrasti con tre tipologie di movimenti in espansione nella società contemporanea (Movimento Cooperativista, Movimenti Urbani e Movimento di Transizione).
Dopo aver delineato in questo modo le caratteristiche principali del movimento dedicheremo il Cap. 6.1. all'approfondimento del suo fattore organizzativo, basandoci sui materiali da esso forniti. Esso, come vedremo, è formato da un insieme di progetti pubblici ed autonomi (Progetti di Servizi Comuni, Progetti Autonomi d'Iniziativa Collettivizzata e Progetti Autonomi) che si integrano e fanno parte di processi collettivi (Cooperativa Integrale, EcoReti, Nuclei d'Autogestione Locale), componendo ciò che il MRI definisce Rete Territoriale (RT). L'organizzazione del movimento si caratterizza in questo modo per una struttura a frattale, per la quale la forma è invariante al cambiamento della scala. Ovvero, ogni componente della RT presenta gli stessi caratteri - derivanti dai principi della Rivoluzione Integrale - conservando la propria autonomia e libertà in una relazione orizzontale con le altre.
Di seguito, nel Cap. 6.2. tenteremo di spiegare l'infrastruttura del MRI a partire da teorie sui movimenti sociali a nostro avviso particolarmente pertinenti. In particolare, analizzeremo il “come” della organizzazione del movimento - ovvero la spiegazione delle modalità in cui esso riesce in maniera più o meno efficace a mobilitare le risorse disponibili - alla luce dei contributi della Teoria della Mobilitazione delle Risorse (TMR). All'interno di questo filone di studi ci concentreremo sulla prospettiva organizzativa, analizzando l'interazione tra le Organizzazioni dei Movimenti Sociali (OMS), il ruolo delle tecnologie nell'elaborazione di tattiche e la differenziazione tra OMS formale e reale della componente maggiormente strutturata del movimento: la Cooperativa Integrale Catalana (CIC). Attraverso il modello elaborato da H. Kriesi delineremo la traiettoria che questa OMS ha compiuto durante la sua evoluzione, sottolineandone gli effetti sulla sua natura e le forme di partecipazione. Le contribuzioni della prospettiva culturalista e costruttivista sul ruolo delle emozioni all'interno dei movimenti sociali ci serviranno invece per delineare le differenti strutture delle opportunità emozionali date dalle OMS del MRI.
Nel Cap. 6.2.2.1. cercheremo di adattare al nostro caso di studio la Teoria dei Nuovi Movimenti Sociali (TNMS), individuando quali delle sue spiegazioni sul “perché” della formazione di movimenti sociali in un determinato contesto storico e sociale si possano applicare. Più in particolare, ci soffermeremo su come l'emergere di una data struttura organizzativa sia condizionato in maniera intrinseca dall'ideologia del movimento (“profezia organizzativa”).
Alla luce della commercializzazione e burocratizzazione riguardante l'organizzazione più strutturata all'interno della Rete Territoriale del movimento - la Cooperativa Integrale - individuate durante la nostra analisi ed accompagnate da repertori emozionali formali, concluderemo sottolineando che il conflitto di questi processi con l'ideologia del movimento potrà essere tradotto, a nostro avviso, in termini positivi.
2. METODOLOGIA
Le domande di ricerca a cui si tenterà di rispondere all'interno di questo elaborato nascono dalla volontà di comprendere ed analizzare il fattore organizzativo del Movimento per la Rivoluzione Integrale (MRI). In particolare, i nostri interrogativi saranno:
- Il MRI è un movimento sociale?
- Quali sono le sue caratteristiche in comparazione con altri movimenti?
- Come si è data la struttura organizzativa del MRI?
- Quali conseguenze ha il fattore organizzativo sul MRI?
- Perchè si è data la struttura organizzativa del MRI?
Per rispondere a queste domande di ricerca, è stata scelta la strategia del caso di studio, ossia, secondo la definizione di D. A. Snow e D. Trom, una:
“Strategia di ricerca che mira a generare una dettagliata, profonda ed olistica elaborazione e comprensione di esempi di varianti di fenomeni sociali collegati tra loro, tramite la triangolazione di metodi che includono, ma non sono limitati, a procedure qualitative”1
La variabile a cui siamo interessati, ossia il fattore organizzativo, sarà quindi analizzata utilizzando l'esempio del MRI a livello Catalano tramite l'utilizzo di più tecniche (in particolare: analisi di materiali del movimento e osservazione partecipante), con il fine di arrivare ad una sua maggiore comprensione.
La decisione a favore di questa metodologia proviene dalla convinzione che l'analisi di una contingenza del MRI possa produrre risultati qualitativamente più utili rispetto ad un tentativo di studiare il movimento nella sua totalità. In aggiunta, pensiamo che il fattore organizzativo possa essere più facilmente osservabile, in particolare nella sua relazione con le pratiche reali, utilizzando una prospettiva analitica limitata a un caso. Realizzare uno studio sull'intero MRI avrebbe comportato infatti non solo uno sforzo investigativo maggiore, ma anche il pericolo di rimanere ad un livello analitico troppo generale, distanziandosi dalla dimensione reale dell'azione collettiva. Infine, il caso che si andrà ad analizzare, ossia il MRI all'interno della Catalogna2, è stato scelto in quanto costituisce l'esempio più esteso e sviluppato della pratica trasformativa del movimento dalla sua nascita.
3. PREAMBOLO: BREVE STORIA DELLA RIVOLUZIONE INTEGRALE
Il contesto della crisi tanto economica quanto di legittimità istituzionale e sistemica che ha investito i paesi occidentali, specialmente del Meridione Europeo, a partire dal 2008 ha visto il fiorire di migliaia di risposte differenti a livello di mobilitazione sociale. In Spagna, il movimento 15M e dei cosiddetti “indignados” si è contrapposto alle politiche di austerità e di salvataggio delle banche adottate dal governo tramite una serie di rivendicazioni, a partire dallo slogan: Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Costatando l'inutilità di proteste e domande di cambiamento alle istituzioni rappresentative - intrinsecamente collegate alle strutture economico-finanziarie - il movimento si è ben presto sviluppato in azioni locali basate sulla partecipazione attiva volta alla creazione di alternative sociali. La rivendicazione ha lasciato così posto all'ideazione di nuovi modelli economici, politici e sociali basati sull'orizzontalità, il consenso e l'autogestione, con l'obbiettivo di creare e ricreare spazi pubblici in una dimensione comunitaria e non statale. Si inizia dunque a pensare a quali possano essere le strutture economiche adatte a permettere lo sviluppo di un'organizzazione sociale differente, autonoma e indipendente dallo Stato e dalle Banche. Nell'ambito della Catalogna, nasce nel gennaio 2009 la prima rete di scambio chiamata “EcoXarxa del Montseny”: si tratta di un sistema monetario basato sulla solidarietà, la cooperazione e la sovranità bio-regionale, ispirato ai valori dell'economia sociale e costituito da cittadini che creano una moneta alternativa. Il 17 marzo 2009 troviamo il primo riferimento all'idea di Cooperativa Integrale nella rivista “PODEM viure sense capitalisme”, prodotta dal “Col·lectiu Crisi”. “Cooperativa” in quanto si dota di questo statuto legale e pratica l'autogestione economica e politica tramite la partecipazione egualitaria, “Integrale” perché affronta ogni aspetto dell'attività economica (produzione, consumo, credito e moneta) ed integra i servizi necessari alla sopravvivenza (casa, educazione, salute, trasporto ed alimentazione). Nel 2010 viene finalmente creata la Cooperativa Integrale Catalana (CIC), con l'obbiettivo di creare una connessione tra le EcoReti, i produttori ed i consumatori tramite un'organizzazione con una struttura legale che ne permetta l'interazione e lo sviluppo in maniera protetta dall'intromissione statale. Tra gli impulsori del progetto troviamo Enric Duran, conosciuto per la sua denuncia della speculazione finanziaria e la crisi tramite un'espropriazione bancaria a vari istituti di credito per un importo di 500 000 euro, nel 2008. Oltre che costituirsi in quanto strumento di coordinazione e difesa legale, la CIC nasce per coprire necessità basiche ed offrire servizi a chi voglia vivere in maniera alternativa al modello sociale egemonico. Questa funzione viene svolta dal Sistema Pubblico Cooperativo tramite le commissioni di salute, educazione, alloggio, trasporto e distribuzione. Dall'altro lato, il concetto di auto- occupazione viene creato per fornire opportunità lavorative alternative all'interno della rete territoriale composta da CIC, EcoReti e Nuclei di Autogestione Locale. Il Socio Auto-occupato ha la facoltà di condurre un'attività economica di qualsiasi tipo utilizzando la copertura legale della Cooperativa; esso non lavorerà per la CIC, ma svolgerà un'attività volontaria volta alla realizzazione dei fini sociali della Cooperativa. In pratica, pur potendo guadagnare (in euro così come in moneta sociale) per coprire le proprie necessità, il socio auto-occupato svolgerà un'attività intrinsecamente sociale e trasformativa in quanto basata sui principi radicali del MRI. Tra di essi troviamo: a livello di organizzazione politica la democrazia diretta, l'assemblearismo (con presa di decisioni per consenso), l'autogestione e la decentralizzazione; a livello ambientale l'ecologismo, la permacultura, la sostenibilità e la decrescita; a livello economico coprire le necessità di tutti tramite l'apporto di ciascuno secondo le sue possibilità, l'economia solidaria e comunitaria, fatta di baratto e moneta sociale; a livello sociale l'equità e la giustizia, l'uguaglianza nella diversità, l'auto-realizzazione e il supporto mutuo, l'autovalutazione e la condivisione delle pratiche con tutta la società; a livello di trasformazione sociale, infine, la CIC aspira al bene comune, alla relazione diretta tra pratica e teoria, ad un processo di cambiamento basato sulla cooperazione e la solidarietà giorno per giorno, alla liberazione dal materialismo e all'inclusività e apertura verso la società intera.3 I principi della CIC provengono dal marco ideologico della Rivoluzione Integrale (RI), intesa come “processo di significato storico per la costruzione di una nuova società autogestita, basata nell'autonomia e l'abolizione delle forme di dominazione vigenti: lo Stato, il capitalismo e tutto ciò che affetta le relazioni umane e la relazione con la natura”4. La RI si realizza dunque tramite le Cooperative Integrali, così come le altre componenti di una rete territoriale volta alla formazione di una “società parallela” che permetta un'organizzazione sociale autonoma -basata su principi prettamente libertari- ai margini del sistema egemonico.
4. LA RIVOLUZIONE INTEGRALE COME MOVIMENTO SOCIALE
Prima di approfondirne le caratteristiche e la dimensione organizzativa, ci chiederemo se le mobilitazioni sociali per la Rivoluzione Integrale possano essere effettivamente considerate un movimento sociale. L'azione collettiva, secondo E. Neveu, rimanda fondamentalmente a due criteri: da un lato, si tratta di un'attuazione congiunta intenzionale caratterizzata per un progetto esplicito dei suoi protagonisti; dall'altro; questa mobilizzazione concertata si sviluppa all'interno di una logica rivendicativa, per la quale si difende una “causa” o un interesse materiale.5 Utilizzando un'espressione di H. Blumer, quest'azione si manifesta in “imprese collettive che hanno come obbiettivo l'affermazione di un nuovo ordine di vita”6. L'ordine di vita di cui parla l'autore può delineare cambiamenti radicali così come una resistenza ad essi, può aspirare tanto ad una rivoluzione quanto riguardare questioni in una dimensione locale. Le forme di azione collettiva concertata in favore di una causa vengono definite tramite il termine “Movimenti Sociali”(MS) per facilitare l'individuazione di questa classe di fenomeni e sottolinearne la componente politica. Le mobilitazioni per la Rivoluzione Integrale possono essere dunque considerate a tutte gli effetti forme di azione collettiva, in quanto rispettano entrambi i criteri precedentemente delineati. I protagonisti, provenienti per lo più dalle contestazioni del 15M dopo la crisi del 2008, hanno agito in maniera congiunta ed intenzionale per l'affermazione di un progetto esplicito seguendo una logica rivendicativa. L'ordine di vita a cui il movimento aspira si caratterizza per una forte radicalità, basata su principi libertari e anelante un'organizzazione socio-politica orizzontale in contrapposizione alle istituzioni egemoniche.
Dopo aver brevemente spiegato come il MRI possa rientrare nella definizione sociologica di Movimento Sociale, tenteremo nella prossima parte di delinearne in maniera più dettagliata le caratteristiche tramite una comparazione con altri tipi di MS.
5. STUDIO COMPARATO DEL MOVIMENTO
5.1. MRI E MOVIMENTO COOPERATIVISTA
Il cooperativismo -nel contesto storico moderno ed occidentale- nasce alla fine del XVIII secolo in Inghilterra tramite l'azione spontanea di operai ed artigiani volta all'organizzazione del consumo e della produzione di fronte alle dure condizioni che il giovane capitalismo inizia ad imporre su di essi. Anche se già negli anni 20 e 30 del XIX esistevano in Inghilterra circa 300 cooperative, il 1844 viene considerato l'anno di nascita del movimento in quanto è in questa data che la Rochedale Equitable Pioneers Society viene fondata da un gruppo di operai licenziati dall'industria tessile nel Lancaster. La cooperativa di consumo, basata sul supporto mutuo e l'eliminazione degli intermediari, passa alla storia in quanto dura nel tempo e delinea i 7 principi fondamentali della corrente maggioritaria del movimento cooperativista fino alla contemporaneità (assunti ad esempio dall'Alleanza Cooperativa Internazionale fondata nel 1895). Questi principi includono: la libera adesione ed uscita dei soci; il principio democratico (1 socio, 1 voto, indipendentemente dall'apporto di lavoro o capitale); la partecipazione economica secondo una distribuzione degli eccedenti e l'obbligatorietà di una riserva di capitale inalienabile; la libertà / neutralità politica e religiosa; la vendita di prodotti di qualità, naturali, con pesi e misure giuste; lo sviluppo dell'educazione e della formazione dei soci; infine, il principio di “cooperazione tra cooperative”. Questi criteri caratterizzeranno la corrente riformista del movimento, ispirata in origine al socialismo utopico, all'anticapitalismo ricardiano e alle teorie di Owen, per le quali il capitalismo può essere cambiato dall'interno tramite un processo graduale ed interclassista (includente i proprietari dei mezzi di produzione). Accanto al filone più moderato, spesso fomentato dalle classi borghesi e dalla Chiesa cattolica (in particolare a partire dall'enciclica Rerum Novarum del 1891) in quanto misura palliativa per aumentare l'impressione di partecipazione economica ed equità dei lavoratori di fronte agli effetti negativi del capitalismo, si sviluppa dal 1868 una corrente rivoluzionaria del movimento. Avvicinandosi, in particolare in Francia, al movimento operaio, il modello cooperativista viene dunque concepito come lo strumento per sostituire il capitalismo con un sistema basato sulla cooperazione e l'assemblearismo. Questa interpretazione del cooperativismo necessita intrinsecamente di essere associata ad un'azione di lotta politica volta al recupero dei mezzi di produzione da parte della classe lavoratrice - in linea con il pensiero marxista e bakuniano - nonché di integrare consumo e produzione in una stessa struttura cooperativa per troncare la logica dell'accumulazione capitalista nella sua totalità.
In Spagna, le cooperative nascono nell'ambito maggiormente industrializzato della Catalogna a partire dal 1837 e vivono in maniera alternata periodi di repressione e di tolleranza da parte delle autorità pubbliche. Il filone rivoluzionario del cooperativismo vede il suo momento di massima espansione durante la Guerra Civile - in particolare tra 1936 e 1938 - nella zona repubblicana del paese, dove il 54% delle terre erano legalmente collettivizzate e gestite in maniera assembleare. Oltre alla campagna, le collettivizzazioni riguardavano anche industrie piccole e grandi, creando un'utopia cooperativista e collettivista la cui espansione verrà ostacolata dall'esercito repubblicano così come dalle organizzazioni cooperativiste più conservatrici.7
Il MRI condivide con il cooperativismo la fede nell'economia sociale, dimostrando affinità in particolare con il filone più radicale di questo movimento. Infatti, il MRI non rispetta il principio di neutralità politica (la differenza principale tra la corrente riformista e quella rivoluzionaria), lottando consapevolmente per un modello alternativo a quello capitalista e cercando inoltre di occuparsi di tutte le componenti del processo economico (produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi). A livello di presa di decisioni il principio democratico viene sostituito da quello del consenso, per il quale un protocollo può essere adottato solo in mancanza di un'opposizione dichiarata (veto) di uno dei soci. D'altra parte, le EcoReti possono essere considerate un'evoluzione del principio tradizionale di “cooperazione tra cooperative”, andando a formare una rete tra progetti sociali differenti e permettendo lo scambio di beni e saperi tra di loro. La moneta sociale non costituisce di per sé una novità, in quanto ripetuti tentativi di costituirla da parte dei socialisti utopici non mancano nella storia, così come abbondano esperienze di questo tipo nel mondo occidentale degli ultimi cent'anni (in particolare in Svizzera e Canada). Tuttavia, le possibilità offerte da internet e dai progressi informatici in generale costituiscono indubbiamente un'opportunità per il consolidamento dell'uso di questo strumento. Per concludere, l'innovazione forse più importante del MRI rispetto alla tradizione cooperativista è la ricerca continua di vuoti legali per espandere le proprie possibilità sovversive.
5.2. MRI E MOVIMENTI URBANI
Il concetto di Movimento Sociale Urbano (MSU) viene presentato per la prima volta da Manuel Castells ne “La questione urbana” (1977) nel contesto delle mobilitazioni che facilitarono l'ascesa di Allende in Chile, e perfezionato in seguito ne “La città e le masse” (1986) ispirandosi al modello dei movimenti di quartiere di Madrid. In quest'ultimo libro l'autore definisce i MSU come: “azioni collettive coscientemente dirette a trasformare gli interessi ed i valori sociali di una città storicamente determinata”8, basandosi fondamentalmente sull'idea di città come prodotto sociale dato da interessi e valori in conflitto. Per rientrare nella definizione di MSU, l'azione collettiva deve rispettare alcune caratteristiche: autoproclamarsi urbana, cittadina o relazionata con la città; basarsi nell'azione locale ed essere territorialmente definita; essere mobilitata intorno a tre obbiettivi, ossia il consumo collettivo e la città come valore d'uso di fronte alla mercantilizzazione della vita e dei servizi, la ricerca dell'identità collettiva e l'autonomia culturale ed infine l'autogestione politica basata nel territorio ed il governo locale. Con il trascorrere del tempo ed i relativi mutamenti sociali, M. Martì i Costa e J. Bonet i Martì9 propongono una revisione delle caratteristiche dei MSU di Castells per l'analisi dei movimenti contemporanei. In particolare, mentre il primo aspetto, ossia della connessione con la dimensione urbana, si mantiene maggiormente, il carattere territorialmente determinato andrebbe ridefinito alla luce delle trasformazioni date dal fenomeno della globalizzazione a livello urbano. Localizzandosi nelle grandi città i processi globali di accumulazione capitalistica, aumentando il ruolo di forme di governo sovranazionali così come subnazionali e l'interazione tra movimenti urbani e cosiddetti “no-global”, gli autori sostengono che i MSU si profilano per una relazione a più scale con il territorio (per la quale l'azione locale è diretta ad un cambiamento globale: “glocale”). Per quanto riguarda l'ultima caratteristica, la principale trasformazione rispetto al passato riguarderebbe i contenuti degli obbiettivi dei MSU: anche se il valore d'uso della città rimane una tematica trasversale, nuovi temi come la sostenibilità, l'immigrazione, il consumo alternativo e la critica alla globalizzazione neo-liberale vengono inclusi nell'agenda dei movimenti urbani; a livello culturale le rivendicazioni per la difesa del territorio vengono portate avanti anche da attori che non condividono la stessa identità territoriale, grazie all'accelerazione del movimento di informazioni, beni e persone derivata dalle nuove tecnologie; infine, più che parlare di autogestione basata nel territorio gli autori individuano rivendicazioni di radicalizzazione della democrazia nell'ambito urbano nei suoi aspetti politici, economici ed ambientali.
La prima cosa di cui ci accorgiamo se compariamo i caratteri dei MSU con quelli del MRI è che all'interno di quest'ultimo viene a mancare il primo e più importante requisito: l'autoproclamarsi come azione collettiva urbana. Il criterio di organizzazione dello spazio politico della RI è la bio-regione in quanto unità territoriale con caratteristiche fisiche ed ecologiche omogenee. Questa concezione del territorio, mutuata dall'ecologismo, prescinde dalla connessione con la dimensione urbana. D'altra parte, è possibile individuare un nesso con la città se ci si sofferma maggiormente sulla parte di azione collettiva relazionata con l'offerta di servizi e la coordinazione dei vari processi che insieme vanno a formare il movimento, ossia la funzione svolta dalla CIC. Se da un lato i Nuclei Locali e le EcoReti attuano in maniera sparsa per il territorio e interagiscono a livello bioregionale, la CIC e le sue commissioni lavorano fondamentalmente a Barcellona, in particolare nel centro “Aureasocial”. Possiamo dunque sostenere che la CIC in quanto cooperativa di beni e servizi è inevitabilmente collegata alla dimensione urbana in quanto agisce all'interno di essa affrontandone i problemi quotidiani e collaborando con altri MSU (per esempio nella creazione di realtà abitative alternative)10. Per quanto riguarda il secondo aspetto, MSU e MRI appaiono simili nell'avere una relazione a più scale con il territorio. La Rete Territoriale in cui si organizza il movimento prevede un insieme di processi eterogenei per il loro campo d'azione nello spazio (come vedremo più specificatamente nell'approfondimento sull'organizzazione), volti alla trasformazione a scala locale, bio-regionale e catalana ed accompagnati dalla speranza di un più ampio cambiamento sociale. Anche gli obbiettivi presentano tratti comuni, in particolare nel rifiuto della mercantilizzazione della vita, nel sostenere il valore d'uso della città, nella ricerca di una democrazia economica radicale così come nell'includere temi che trascendono la realtà urbana: la sostenibilità ambientale, il consumo alternativo e la critica al neoliberalismo. Per concludere, abbiamo notato che il MRI presenta similitudini con i MSU solo negli ultimi due aspetti caratterizzanti questo tipo di movimenti sociali, ossia quelli che, nella revisione di Marti e Bonet, deriverebbero in buona misura dai recenti mutamenti sociali provocati dalla globalizzazione. Questo, insieme alla mancanza di un'azione collettiva dichiaratamente urbana (nonostante l'inevitabile relazione con la città), ci porta a sostenere che il MRI può rientrare solo parzialmente nella tipologia di MSU (nella versione revisionata), e che più in particolare ne condivide i tratti che i movimenti sociali in generale hanno mutato a causa delle ultime trasformazioni socioeconomiche a livello globale.
5.3. MRI E MOVIMENTO DI TRANSIZIONE
Continuando con la sezione comparativa di questo studio, profileremo in questa parte la storia ed il modello del Movimento di Transizione basandoci sulla recente teorizzazione di Juan Del Rìo11 (la prima in Spagna su questo tema), per poi individuarne le principali similitudini e differenze con il MRI. Il concetto di Transizione emerge per la prima volta nella città di Kinksale (Irlanda) durante un corso di Permacultura impartito da Rob Hopkins. E' in questi incontri che nasce l'idea di creare uno studio di come la città possa ridurre la sua dipendenza dal petrolio, progetto che ben presto si trasforma in un vero e proprio piano (Energy Descent Action Plan) appoggiato dalla comunità e l'amministrazione locali. In seguito, il movimento prende forma attraverso l'iniziativa “Transition Towns” e si estende tramite il “Transition Network”, una cosiddetta “rivoluzione silenziosa” le cui motivazioni nascono fondamentalmente dalla constatazione dell'insostenibilità del modello socioeconomico attuale, rappresentata in particolare dalla crisi economica ed il picco del petrolio12. Il modello del movimento, oltre che rimandare ai valori della permacultura, si caratterizza, secondo Del Rìo, per otto principi: una visione positiva del futuro, che vede la crisi come un'opportunità di cambiamento globale a partire dalla dimensione locale comunitaria; Inclusività ed apertura verso tutte le componenti sociali; opera di sensibilizzazione riguardo ai temi della transizione; costruzione di resilienza comunitaria (capacità della popolazione di adattarsi e riorganizzarsi di fronte ai cambiamenti dati dalla mancanza di combustibili fossili e cibo, lo stress sociale, la disoccupazione, etc13 ); processo di transizione esterna ed interna (sia a livello delle pratiche socioeconomiche e culturali che della filosofia individuale); centralità delle manifestazioni pratiche (proporre alternative adattate a ogni contesto, agire a scala locale fornendo un esempio per il resto della società); condividere e creare reti (tra le iniziative di transizione così come con i progetti affini); modello virale (auto-replicabile, decentralizzato, flessibile ad adattarsi ad ogni contesto e ad ogni necessità in quanto basato sull'autogestione e l'”empowerment” comunitario)14. Per riassumere: “In definitiva, il movimento di transizione è un esperimento inclusivo, fresco e innovatore, che cerca una trasformazione sociale tramite la ricostruzione di resilienza comunitaria e la rilocalizzazione dell'economia. Una proposta che ci invita a lasciare le differenze da parte per passare insieme dall'idea all'azione”15. La nostra analisi riguardante la relazione tra Movimento di Transizione e Movimento per la Rivoluzione Integrale in Catalogna coincide in larga misura all'individuazione di quest'ultimo quale progetto affine al “Transition Network” da parte di Del Rìo16. Comparando le caratteristiche dei due movimenti, ci accorgiamo infatti che anche il MRI vede la crisi come un'opportunità per il cambiamento sociale, ricerca la resilienza comunitaria (cercando di creare un'organizzazione che vada a coprire le necessità locali di fronte alle mancanze e agli attacchi del sistema egemonico) e una transizione sia esterna che interna (la struttura a frattale prevede, come vedremo, un attività trasformativa collettiva tanto quanto individuale); si basa inoltre sull'azione pratica (proponendo l'azione diretta a scala locale come unica via accettabile per il cambiamento, in contrasto con il metodo rappresentativo), la sensibilizzazione (offrendo incontri informativi ogni settimana e partecipando a fiere ed eventi di ecologia ed economia solidaria), la rete ed il modello virale (rispecchiati nella struttura decentralizzata, a frattale e basata su assemblearismo ed autonomia, per la quale ogni suo componente è indipendente a livello decisionale e si adatta in maniera differente a seconda del contesto e delle necessità, pur condividendo gli stessi principi). Al di là di queste affinità, possiamo però individuare alcune differenze nel livello di apertura dei due movimenti: il MRI si dichiara infatti inclusivo e tenta di coinvolgere il più possibile di persone ed attività anche in casi in cui non condividano completamente i suoi principi (v. più in dettaglio nell'approfondimento sui Progetti Autonomi), tuttavia esclude - a differenza del movimento di transizione - ogni collaborazione con le istituzioni politiche, anche a livello locale17. Ciò è dovuto fondamentalmente all'ideologia libertaria che la caratterizza, tradotta in un tipo di azione diretta che cerca di evitare l'illegalità (se non nel principio di disobbedienza economica) e adotta lo statuto di cooperativa mista semplicemente per garantire la propria sopravvivenza. Al contrario, il “Transition Network” si fonda sull'evitare distinzioni “noi-voi”18, cercando fin dal suo inizio di creare una trasformazione sociale sostenuta da una base più ampia possibile, sebbene a livello locale, coinvolgendo anche istituzioni politiche, scientifiche e culturali. Per quanto riguarda le forme di partecipazione all'interno dei due movimenti, possiamo delineare una prevalenza di elementi politico-economici nel MRI, rispetto ad una relativa predominanza di attività culturali e sociali del movimento di transizione. Pur includendo nei loro obbiettivi il supporto a progetti di impresa sociale e cooperativismo, le iniziative di transizione operano per lo più per la sensibilizzazione e la creazione di un senso d'appartenenza comunitario (tuttavia avendo spesso un ruolo nell'implementazione di monete locali).
Per concludere, possiamo quindi sostenere che MRI e movimento di transizione possono considerarsi fondamentalmente affini, che la principale differenza tra i due sta nell'atteggiamento per lo più ostile del MRI verso gli enti istituzionali e nel prevalere di componenti politico-economiche. Più in generale, individuiamo una maggiore radicalità a livello ideologico per quanto riguarda il MRI, con un minor grado di apertura verso l'esterno come conseguenza.
6. LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DEL MRI
Nella seguente parte si andrà ad esplorare la forma organizzativa del MRI, per passare nel prossimo capitolo ad un'analisi della stessa partendo dalle spiegazioni delle principali teorie sui movimenti sociali. In particolare, vedremo come si tratti di un'organizzazione basata su di una rete territoriale in cui processi collettivi, autonomi e pubblici interagiscono tra loro. Il fatto che questi processi risulteranno avere le stesse caratteristiche organizzative nonostante la loro diversità tanto di scala (dal livello globale a quello locale) che di funzione (gestionale, economica, etc), ci porterà a parlare di una struttura organizzativa a frattale. I contenuti di questo capitolo sono derivati da: materiali informativi che la Cooperativa Integrale Catalana rende disponibili sulla sua piattaforma web19, il frutto del “Curs de Capacitació Primavera 2014”20 pubblicato su Wiki CIC ed altri documenti forniti su richiesta dal Nodo Informazione della Cooperativa.
6.1. FORMA ORGANIZZATIVA: LA RETE TERRITORIALE
La forma organizzativa prescelta dal MRI è quella di una rete territoriale (“Xarxa Territorial”) che connetta progetti altamente eterogenei ed allo stesso tempo affini ideologicamente. In particolare, possiamo distinguere tra due tipi di processi all'interno della rete: da una parte i processi collettivi radicati e diffusi sul territorio, che comprendono Cooperative Integrali, EcoReti (ER) e Nuclei di Autogestione Locale (NAL), dall'altra i processi autonomi o pubblici, come i Progetti di Servizi Comuni, i Progetti Autonomi d'Iniziativa Collettivizzata e i Progetti Autonomi, che si integrano o fanno parte dei processi collettivi attivi sul territorio. La natura intrinsecamente decentralizzata della rete permette ai vari progetti di sostenersi a vicenda, assicurando allo stesso tempo la sopravvivenza dell'insieme in caso uno di essi fallisca a causa di pressioni interne o esterne.
6.1.1. PROCESSI COLLETTIVI
Le Cooperative Integrali sono una proposta sistemica volta alla soddisfazione delle necessità basiche al margine del sistema egemonico. Legate a uno spazio solitamente più esteso rispetto agli altri processi, si dotano di strutture giuridiche che permettano una relazione collettiva con lo Stato. Tra le loro funzioni (riassunte nel diagramma 2) troviamo quindi principalmente quella di intermediazione tra persone e Stato, di creazione di strumenti di “empowerment” collettivo (garantire un sistema pubblico cooperativo integrale), chiamati “mezzi di costruzione massiva”, ed infine di promozione e dinamizzazione dei progetti locali sul territorio. Per svolgere queste attività, la Cooperativa Integrale Catalana si sviluppa in diversi nodi (v. diagramma 3), a loro volta differenziati per commissioni ed uffici. In particolare, troviamo il Nodo Informazione (commissioni di accoglienza, comunicazione e diffusione, estensione della Rivoluzione Integrale, rete territoriale), il Nodo Gestionale (commissioni di gestione economica, giuridica, coordinazione burocratica), il Nodo Organizzativo (commissioni di coordinazione e dinamizzazione degli spazi comuni), il Nodo Sistema Economico (commissioni di scambi e monete locali, progetti produttivi, finanziamento) ed infine il Nodo Sistema Pubblico Cooperativo (Centrale di Fornitura Catalana21, uffici di: scienza, tecnica e tecnologia22 ; informatica e telecomunicazioni; trasporto; abitazioni; cultura; educazione; salute; supporto umano). L'organo di governo fondamentale è l'Assemblea Permanente, riunita ogni quindici giorni (alternando il luogo una volta a Barcellona presso AureaSocial e una volta in maniera itinerante, di tre giorni, ed accompagnata da corsi monografici) e le cui decisioni vengono prese per consenso. A livello di statuto legale, la CIC si costituisce in quanto società cooperativa limitata (XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES SCCL), ossia cooperativa mista di consumatori, utenti e servizi soggetta alla legge catalana sulle cooperative 18/2002. Secondo gli articoli 128 e 129 della stessa legge, essa rappresenta una cooperativa d'iniziativa sociale e senza scopo di lucro. Le EcoReti (ER) sono reti di autogestione bio-regionale con obbiettivo la promozione di scambi, siano essi con moneta sociale o con altre forme non monetarie, per la formazione di un mercato sociale che aiuti lo sviluppo di progetti autogestiti. La moneta sociale è uno strumento di scambio di beni, servizi e conoscenze con l'obbiettivo di costruire un sistema di relazioni economiche al margine del capitalismo. Le ER fomentano un tipo di economia sociale, basata sulle relazioni umane e la dimensione locale, sul soddisfacimento delle necessità basiche senza dover utilizzare l'Euro e sull'acquisizione di abilità che vadano al di là di quelle meramente professionali; incentivano infine il passaggio delle persone che le compongono a un ruolo attivo di “prosumatori” (consumatori e produttori allo stesso tempo). Possiamo dunque riassumere le attività delle ER in: gestione della moneta locale, dinamizzazione dei processi locali ed organizzazione di mercati di scambio a livello bio-regionale. Nella Mappa 1 vengono rappresentate le ER attualmente attive in Catalogna.
I Nuclei d'Autogestione Locale (NAL) sono spazi d'interazione basati nella prossimità, nei quali iniziative collettive e progetti autonomi interagiscono con un alto livello di fiducia. A livello territoriale possono essere costituiti da un quartiere, una cittadina o un insieme di piccoli paesi. Possono essere dotati di uno spazio fisico vero e proprio (un centro sociale, una sala per riunioni etc) e solitamente utilizzano la moneta locale di una EcoRete. Nel lungo periodo ogni NAL potrebbe potenzialmente diventare una Cooperativa Integrale, in quanto ne condivide le funzioni, ossia serve ad accelerare e facilitare gli scambi economici in una bio- regione così come a promuovere altri tipi di attività di coesione sociale. Possiamo riassumere le attività di un NAL in: spazio di incontro a livello locale; gestione di un “rebost”23 ; organizzazione cicli di dibattiti, proiezioni, conferenze, festival; gruppi di apprendimento collettivo; orti comunitari; punti verdi (riciclaggio); “botiga gratis”24 ; nodi locali di qualche ufficio o commissione.
6.1.2. PROCESSI AUTONOMI E PUBBLICI
I Progetti di Servizi Comuni sono iniziative strategiche per garantire il soddisfacimento delle necessità che il sistema vuole coprire. Normalmente si tratta di progetti complessi che sono difficilmente sviluppabili in maniera autonoma, per cui la loro esecuzione dipende da un gruppo di lavoro che esegue gli accordi presi nell'Assemblea Permanente della CIC. Le persone coinvolte ottengono delle compensazioni economiche a seconda delle loro necessità per coprire i loro bisogni vitali, in quanto in caso di produzione di benefici le entrate andranno al fondo comune della CIC trattandosi di servizi pubblici (per lo stesso motivo questi progetti non pagano ne IVA ne quote alla Cooperativa). I Servizi Comuni, per quanto sviluppati a scala estesa (forniti dalla CIC in generale), si configurano come potenziali strumenti di “empowerment” e autonomia replicabili a livello locale (in un NAL o una ER). Alcuni esempi di Progetti di Servizi Comuni sono i “rebostos”, la gestione dei Soci Autonomi, il Mercato Virtuale, la CAC, gli uffici di Salute, Educazione, Trasporto ed Energia, etc.
I Progetti Autonomi d'Iniziativa Collettivizzata (PAIC) sono iniziative che devono, per poter iniziare le loro attività, far richiesta all'Assemblea Permanente della CIC, con cui si fissano i relativi criteri di gestione e di reciprocità. Di fatto i PAIC, seppure governati da una propria assemblea sovrana, devono riflettere nel proprio funzionamento i principi della CIC e garantire momenti in cui si possano incorporare nuovi membri (progetti aperti). Normalmente iniziano grazie all'uso di un bene ottenuto a condizioni vantaggiose o ad un finanziamento della CIC (in quanto progetti collettivizzati, la proprietà collettiva dei beni sarà garantita da forme giuridiche cooperative). In ogni caso, si tratta di iniziative autonome nella gestione delle proprie risorse e interamente responsabili del proprio avanzamento e successo. Al loro interno si possono attivare diversi progetti produttivi che, in caso di fatturazione, pagheranno quote ed IVA alla CIC (verranno definiti quindi soci autonomi). Alcuni esempi di PAIC sono comunità (Calafou, Can Calçada, SOM Comunitat, Roig21), altri sono AureaSocial25 o L'art du Soleil26.
I Progetti Autonomi (anche detti Progetti Produttivi o Progetti d'Iniziativa Produttiva) sono progetti d'iniziativa individuale o collettiva che realizzano un'attività economica di carattere cooperativo, la quale dipende dall'utilizzo di servizi comuni della CIC per esercitare e/o fatturare. Si tratta di un'alternativa all'interazione individuale con lo Stato, grazie alla quale un produttore può ridurre al minimo la sua relazione con quest'ultimo, senza preoccuparsi di temi gestionali e burocratici. Possono dunque costituire un'opzione cooperativa per un imprenditore in proprio, così come offrire alternative di auto-occupazione27 per chi non avrebbe la possibilità di iniziare un'attività economica, a causa del peso delle tasse e dei procedimenti burocratici. I Progetti Autonomi (PA) non dipendono da un accordo con l'Assemblea Permanente della CIC, possono formarsi riempiendo un formulario e dimostrando di rispettare alcuni criteri positivi (principi politici, sostenibilità ecologica, giustizia sociale) così come negativi (ad esempio non accettare un minimo del 10% di moneta sociale nei pagamenti, importare od esportare al di fuori della Catalogna, lavorare con multinazionali, etc). Così come per i PAIC, l'avanzamento e il successo del progetto dipendono unicamente dall'individuo o collettivo che ne gestisce autonomamente le risorse (in caso di fatturazione legale, devono pagare quote ed IVA alla CIC). I PA prendono forme diverse a secondo della loro natura, ed in particolare possiamo distinguere i Soci Autonomi (che necessitano di fatturazione legale), i Prosumatori (se l'attività è diretta unicamente a soci della CIC, solitamente con livelli di produzione più bassi) ed i Soci di Servizi (che sono entità giuridiche a sé stanti, la cui attività è solo in parte rivolta all'interno della CIC). I PA non sempre rispettano al 100% i principi della CIC, in questi casi si parla di “progetti in transizione”, in quanto l'obbiettivo è comunque quello di una conversione politica nel lungo termine.
6.1.3 LA STRUTTURA A FRATTALE
Riprendendo ciò che è stato detto all'inizio del capitolo, i processi autonomi e pubblici integrano o fanno parte dei processi collettivi, andando a formare nell'insieme una configurazione frattale. Termine coniato nel 1975 dal matematico francese B. Mandelbrot, un frattale indica secondo la definizione di Treccani “un particolare ente geometrico la cui forma è invariante nel cambiamento della scala delle lunghezze: successivi ingrandimenti di piccole regioni dell’oggetto mostrano sempre la stessa struttura, spesso assai complessa”.28 Dunque, i processi costituenti la Rete Territoriale assumeranno, al di là delle proprie funzioni specifiche, una forma condivisa direttamente derivante dai principi della Rivoluzione Integrale: l'organizzazione assembleare, la presa di decisioni per consenso, la democrazia diretta, l'ecologismo, la semplicità volontaria, l'uguaglianza nella diversità, il supporto mutuo, l'auto-realizzazione umana, il cooperativismo, etc.
Nella seguente parte andremo quindi a presentare un'analisi svolta dalla CIC stessa,29 incentrata sull'interazione tra i vari processi in un'ottica multilivello che vada dall'ambito personale a quello globale, notando come i fattori organizzativi si ripetano nonostante il cambio di scala.
LIVELLO CATALANO: A questa scala troviamo la Cooperativa Integrale Catalana. Basandoci sul diagramma 4, notiamo, nella parte interna, le commissioni, che si occupano dell'implementazione dei compiti per lo sviluppo della CIC. Al loro interno, ma anche svincolati da esse, troviamo gruppi di lavoro, solitamente per tema. Sempre nella parte interna della CIC vediamo gli uffici, i quali si occupano del Sistema Pubblico Cooperativo e possono comprendere altri gruppi di lavoro o nodi. Al margine della CIC notiamo le EcoReti; esse non sono all'interno in quanto non si dedicano direttamente allo sviluppo della Cooperativa, ma agli scambi economici a livello bio-regionale; tuttavia, molto spesso utilizzano le risorse comuni della CIC ed in ogni caso si relazionano con essa. In una posizione relativamente esterna troviamo anche i progetti produttivi, in quanto autonomi ed autogestiti, ma allo stesso tempo condizionati in diversa misura dai principi della CIC. All'interno notiamo invece la presenza dei Progetti di Servizi Comuni, che si occupano di fornire servizi alla collettività. I progetti affini, pur non utilizzando le risorse della CIC, possono comunque contribuire all'espansione della Rivoluzione Integrale, condividendone i principi e/o interagendo con i processi della Cooperativa.
LIVELLO BIO-REGIONALE: Guardando al diagramma 5, notiamo che la struttura organizzativa si ripete in maniera quasi identica a livello bio-regionale (solitamente corrispondente a una delle “Comarche” della Catalogna) tramite le EcoReti (ER). Come le ER si posizionavano al margine della CIC, i Nuclei di Autogestione Locale (NAL) lavorano al margine delle ER, utilizzandone la moneta sociale e interagendo in maniera più diretta tra loro. Come nell'ambito catalano, possiamo trovare differenti commissioni, nate a partire da necessità o priorità particolari dei membri dell'ER. In realtà, un NAL non sempre interagisce solo con l'ER: l'importanza dei valori di autonomia ed affinità caratterizzante l'intero sistema permette relazioni libere tra ogni nucleo (seppur appartenente a un livello differente), per cui un NAL può avere legami più forti con l'ER locale, o direttamente con la CIC. Anche i Progetti Produttivi costituiscono un fattore organizzativo che si ripete, nonostante il livello territoriale sia più “basso”, per cui un'ER può includere o relazionarsi con essi e a sua volta creare Progetti di Servizi Comuni per il supporto della collettività.
LIVELLO LOCALE: Scendendo ad una prospettiva ancora più locale vediamo, nei NAL, (diagramma 6) la stessa struttura formata da commissioni, gruppi di lavoro, progetti produttivi e uffici che costituiscono nodi del Sistema Pubblico Cooperativo.
LIVELLO PERSONALE: Ad una scala prettamente individuale (diagramma7) la struttura a frattale si ripete nell'organizzazione della propria vita ed azione a partire dai principi della Rivoluzione Integrale (comuni ad ogni altro livello). Le persone sono la base della Rete Territoriale e sono coloro che agiscono, dentro e fuori di essa, per la sua realizzazione ed estensione.
LIVELLO GLOBALE: Le strutture organizzative, dall'ambito più locale a quello più globale, si estendono al di là della Catalogna in una rete formata dalle altre Cooperative Integrali nazionali e degli altri paesi (diagramma 8). Anche in questi casi si ripeteranno i principi della Rivoluzione Integrale, le commissioni, i nodi del Sistema Pubblico Cooperativo e gli altri elementi in una rete con le altre Cooperative Integrali, con i progetti locali e le iniziative affini.
Come dimostra l'analisi appena conclusa, i livelli in cui il diagramma1 divide la Rivoluzione Integrale non sono ordinati gerarchicamente, ma territorialmente e spazialmente. Si tratta di una struttura orizzontale frattale in cui ogni nucleo condivide le stesse forme organizzative ed interagisce liberamente con i suoi corrispettivi territoriali, così come con i nodi più o meno estesi spazialmente. Il diagramma 3, mostrando un focus sulla CIC, mostra come la stessa struttura valga a livello funzionale: ogni nodo, che si occupi di comunicazione, economia o gestione, interagisce su di un livello orizzontale coi propri corrispettivi. La ripetizione nelle forme non impedisce dunque la diversità tra i processi che, grazie ai principi di libertà ed affinità, possono decidere autonomamente quali strategie sia più utile adottare e con quali altri nodi interagire più intensamente.
6.2. SPIEGAZIONI TEORICHE
In questo capitolo tenteremo di spiegare come, con quali conseguenze e perché il MRI e più in particolare la sua componente organizzativa abbiano assunto le forme e le caratteristiche analizzate fino a questo punto.
6.2.1. IL “COME” DEL FATTORE ORGANIZZATIVO NEL MRI E LE SUE CONSEGUENZE
6.2.1.1. MRI E TEORIA DELLA MOBILITAZIONE DELLE RISORSE (TMR)
Gli anni Sessanta vedranno sorgere negli Stati Uniti una nuova corrente di studiosi dei movimenti sociali che rifiuteranno “l'immaginazione vulcanica”30 degli approcci precedenti (“collective behaviour”, privazione relativa), caratterizzati da spiegazioni dell'insorgere dei movimenti sociali a partire da tensioni strutturali date da un cambiamento sociale troppo rapido. Jesús Caquette, riassumendo i caratteri del pensiero classico sull'azione collettiva, sottolinea come queste tensioni si manifesterebbero in situazioni psicologiche individuali di privazione relativa ed anomia, sfocianti a loro volta in comportamenti esplosivi ed irrazionali relativamente infrequenti e transitori, chiaramente distinti dalle forme di azione politica istituzionali.31 Nel contesto politico dell'irruzione del “Movement” nella storia (movimenti ecologisti, femministi, pacifisti, agitazioni studentesche negli USA degli anni Sessanta), spiegazioni che sottolineavano l'irrazionalità e la natura quasi patologica di questi fenomeni si dimostrano di scarsa utilità per chi partecipa nei movimenti sociali, così come per chi cerca di studiarli. A livello accademico avviene dunque un rinnovamento ed un cambiamento delle domande di ricerca - negli anni Ottanta costituirà già una corrente maggioritaria - condotto in particolare da autori come Oberschall, Gamson, Tilly, McCarthy e Zald32, che - in controtendenza con la tradizione precedente - enfatizza “le continuità tra movimenti e azioni istituzionalizzate, la razionalità degli attori dei movimenti, i problemi strategici con cui si confrontano i movimenti e il ruolo di essi in quanto agenzie per il cambiamento sociale”33. Secondo Melucci, uno dei teorici più importanti dei movimenti sociali, si tratta di prospettive che preferiscono concentrarsi più sul “come” un movimento sociale riesce in maniera più o meno efficace a mobilitare le risorse disponibili per una causa, piuttosto che sullo spiegare il “perché” della sua nascita.34 Ciò che si propone è un modello multifattoriale della formazione dei movimenti che sottolinea la disponibilità di risorse, l'organizzazione e le opportunità politiche. Autori di questa corrente si soffermano dunque su come, grazie all'acquisizione di nuove risorse (materiali o simboliche) o al miglioramento di quelle disponibili, gruppi in una situazione di ingiustizia sociale riescano a mobilizzarsi, introdurre le proprie richieste nella società e, di conseguenza, attuare politicamente. Tra le risorse fondamentali nel determinare il successo nella formazione e consolidamento dei movimenti sociali troviamo legittimità, denaro, lavoro ed infrastruttura. Queste, sottolineano McCarthy e Zald, provengono fondamentalmente dai militanti (individui o organizzazioni), detti membri attivi o constituents, tramite l'apporto di donazioni o lavoro, e dipendono quindi dalla ricchezza sociale del movimento.35 I constituents vanno distinti dagli aderenti, ossia chi semplicemente simpatizza e condivide gli obbiettivi del movimento. Nel caso del MRI non si può non sottolineare la crucialità dell'investimento iniziale di Enric Duran grazie alla sua campagna contro le banche, così come altre donazioni di attivisti e simpatizzanti nel primo stadio, più informale, del progetto. Il consolidamento economico e politico dell'iniziativa è invece dipeso maggiormente dall'apporto di lavoro dell'insieme di partecipanti all'interno dei vari processi, sia collettivi che autonomi, durante i successivi cinque anni. A livello di legittimità e risorse simboliche il MRI ha di certo beneficiato della crisi del 2008 che, al di là delle sue conseguenze economiche, ha ridotto in molti casi la fiducia verso le istituzioni rappresentative così come finanziarie aprendo la strada a modelli alternativi. I principi della Rivoluzione Integrale si prestano inoltre ad essere condivisi da fasce ampie del settore antagonista catalano, caratterizzato in buona parte da una cultura politica con componenti libertarie ed ecologiste. Infine, la forma di Cooperativa mista gode di una legittimità in buona misura diffusa socialmente, grazie alla notevole tradizione cooperativista della Catalogna.36
A questo punto, ci sembra utile sottolineare un bivio teorico del quale seguiremo, per necessità, una sola strada. All'interno della TMR possiamo distinguere infatti tra autori che si soffermano maggiormente sul ruolo dell'organizzazione nella mobilizzazione delle risorse ed autori che si concentrano sul ruolo della struttura delle opportunità politiche (o processo politico) caratterizzante il contesto in cui il movimento agisce.37 Essendo questo studio incentrato sui caratteri organizzativi del MRI, prediligeremo la prospettiva organizzativa all'interno della TMR. Inoltre, la struttura delle opportunità politiche ci sembra in questo caso di minore valore esplicativo, in quanto si tratta di un movimento sociale fondato su di un ideologia fondamentalmente anarchico-libertaria che tende a minimizzare le relazioni con le istituzioni politiche rappresentative.
LA PROSPETTIVA ORGANIZZATIVA
Una riflessione come quella che si sta realizzando in questo studio non sarebbe probabilmente stata realizzabile senza le contribuzioni di McCarthy e Zald sull'organizzazione dei movimenti sociali. Questi autori hanno posto per la prima volta al centro delle spiegazioni sociologiche sui movimenti il ruolo dell'organizzazione, sia analizzando come l'infrastruttura scelta da un movimento possa essere determinante nella sua capacità di mobilizzazione, sia soffermandosi sull'interazione tra organizzazione del movimento ed altre entità sociali (altri movimenti, contromovimenti ed autorità).38 Partendo da una concezione di movimento come “insieme di opinioni e credenze in una popolazione che rappresenta preferenze di cambiamento di alcuni elementi della struttura sociale e/o della distribuzione delle ricompense in una società”39, i due autori definiscono un'organizzazione del movimento sociale (OMS) “un'organizzazione formale e complessa che identifica i suoi obbiettivi con le preferenze di un movimento sociale e cerca di farli diventare realtà”.40 Oltre a questa categoria, McCarthy e Zald individuano come industrie dei movimenti sociali (IMS) l'insieme delle OMS che hanno per obbiettivo la realizzazione delle preferenze di un movimento sociale; infine, i settori dei movimenti sociali (SMS) sono composti da tutte le IMS che operano in una società al di là del movimento che appoggiano. Gli autori si soffermano quindi sull'interazione tra differenti OMS ed IMS che competono in una data società, sul ruolo delle tecnologie nell'elaborazione di tattiche, così come sulle multiple funzioni che le OMS svolgono nell'attrarre attivisti ed elaborare strategie.41
Nel nostro caso di studio, la Cooperativa Integrale Catalana costituirebbe un' OMS, parte di una più ampia IMS volta alla realizzazione dei principi della Rivoluzione Integrale (ossia il MRI, che comprende anche ER, NAL e relativi processi). In quanto la CIC costituisce l'elemento organizzativo più formale e strutturato all'interno del MRI, concentreremo la nostra analisi su di essa.
A livello di interazioni con altre OMS ed entità sociali, la tattica scelta dalla CIC è fondamentalmente quella di “exit” in caso esse non siano affini ai propri principi (costituitasi in quanto Cooperativa, la contestazione o azione rivendicativa diretta verso l'esterno lascia per lo più parte all'azione proattiva all'interno, volta all'autoaffermazione), mentre in caso si tratti di OMS potenzialmente affini la CIC si propone in termini cooperativi, più che competitivi (ad esempio, altre iniziative di economia solidaria, così come l'azione politica dei Centri Sociali Autogestiti e dei Movimenti Urbani vengono promosse politicamente dalla CIC tramite i suoi mezzi di informazione). La struttura di cui si dota - basata sulla rete territoriale e sul cooperativismo - spinge di per sé ad una progressiva inclusione di progetti che rispecchino i valori della Rivoluzione Integrale (anche parzialmente) al di sotto del suo “ombrello” giuridico, o per lo meno ad una cooperazione con essi (nella struttura a frattale i progetti affini vengono rappresentati, per di più allo stesso livello della CIC e dei processi relativi)42. Come già detto, l'interazione con lo Stato o altri organi istituzionalizzati è invece ridotta al minimo se non addirittura potenzialmente conflittuale. Essa è costituita fondamentalmente dallo statuto formale di Cooperativa mista (legge catalana sulle cooperative 18/2002) e dalla scelta di disobbedienza fiscale. La CIC si dota di un Nodo Gestionale in cui gruppi di persone con formazione giuridica o economica lavorano in continuazione per gestire queste relazioni delicate con le istituzioni governative, cercando soluzioni che vadano al limite tra l'illegalità e la legalità in maniera da garantire allo stesso tempo i principi di disobbedienza economica ed autogoverno della RI e la sopravvivenza della Cooperativa.
A livello di fattori tecnologici, non possiamo non sottolineare l'importanza che l'innovazione delle piattaforme online ha costituito per la CIC come per qualsiasi altra OMS contemporanea. I “mezzi di costruzione massiva”, per esempio il Sistema Pubblico Cooperativo o la CAC, così come la comunicazione tra gli attivisti (per il dibattito o per l'organizzazione di eventi) si basano e dipendono da strumenti informatici - come la piattaforma “cooperativa.ecoxarxes.cat” - sviluppati per lo più dagli uffici del CTiT (Ciència, Tècnica i Tecnologia).
Infine, per quanto riguarda la relazione tra OMS, tattiche e strategie, possiamo sostenere che essa si sia rivelata una risorsa fondamentale nello sviluppo del MRI. Distinguiamo però tra OMS “formale”, ossia la forma prevista dallo statuto legale di Cooperativa mista (SCCL), ed OMS reale, ossia le pratiche adottate dalla CIC nelle sue attività in concreto. La OMS formale è considerata fondamentalmente come un'innovazione strategica ed una risorsa dal movimento, non come una vera e propria infrastruttura organizzativa. In particolare, si sostiene che essa sia stata adottata per proteggere le attività economiche e di trasformazione sociale del movimento dagli attacchi dello Stato, andando a costituire una risorsa giuridica di difesa di fronte alle pressioni esterne. Oltre che per proteggersi, la forma di SCCL è stata scelta perché limita la responsabilità al Consiglio rettore e al capitale sociale (mai al patrimonio individuale dei soci), riduce le obbligazioni burocratiche per i soci, aumenta la complessità di un intervento statale e permette infine lo svolgimento di attività economiche all'interno del proprio sistema (senza doverle dichiarare allo Stato). Lo statuto legale rispecchia quindi in maniera parziale la realtà organizzativa della CIC, in particolare: le decisioni vengono prese dall'Assemblea Permanente e mai dal Consiglio rettore, in quanto “La CIC es un movimiento asambleario con herramientas cooperativas, no es una cooperativa”43 ; non si parla di imposte ma di contribuzioni al comune (non possono esserci imposizioni ai membri); i soci autonomi non lavorano, compiono volontariamente i fini sociali della CIC; in generale si traducono dinamiche impresariali di una cooperativa in dinamiche per il bene comune (ad esempio, un progetto che promuove maggiormente i valori dell'economia del bene comune deve meno contribuzioni alla cooperativa); le categorie di servizi previste dallo statuto non corrispondono esattamente a quelle utilizzate; infine, l'insolvenza non è vista necessariamente come negativa (disobbedienza economica).
Nonostante queste differenze e l'intenzione di dotarsi di uno statuto legale per rispondere a necessità strategiche e configurarlo in quanto risorsa giuridica, il frutto dell'osservazione partecipante e delle interviste informali svolte durante le Giornate Assemblearie della CIC ci ha portato ad individuare un importante effetto dell'OMS formale sulla natura del movimento e le forme di partecipazione al suo interno. Per analizzare questo fenomeno, riteniamo utile integrare le contribuzioni della TMR con altri due approcci: il modello delle organizzazioni relazionate con i movimenti sociali di H. Kriesi e l'enfasi sulla dimensione emozionale - in particolare della struttura delle opportunità emozionali- di un filone di studi più recente e legato alla prospettiva culturalista.
6.2.1.2. IL MODELLO DI KRIESI: LA TRAIETTORIA DELL'OMS
L'approccio sviluppato da H. Kriesi44 ci aiuta a situare nello spazio le dinamiche e le dimensioni dell'azione collettiva in relazione con le forme organizzative e il coinvolgimento militante a partire da due variabili. La prima ha a che fare con il grado di partecipazione dei membri del movimento sociale (dall'attivismo più militante all'assenza di coinvolgimento al di là del semplice pagamento di una quota), mentre la seconda variabile tenta di individuare l'orientamento dell'azione della sua organizzazione (che può rivolgersi maggiormente all'interazione con le autorità pubbliche o, al contrario, ai propri aderenti tramite la prestazione di beni e servizi). Andando oltre la semplice definizione delle diverse forme organizzative all'interno dei quattro quadranti, ciò che ci sembra particolarmente interessante a proposito del modello di H. Kriesi è la possibilità di tracciare delle traiettorie. Un'organizzazione può infatti evolversi in differenti direzioni all'interno di questo schema: un movimento sociale in passato prettamente extraparlamentare, radicale ed informale può infatti trasformarsi in un gruppo di pressione o partito politico tramite un processo di istituzionalizzazione.45 L'investigazione svolta tramite le interviste informali e l'osservazione partecipante ci hanno invece portati ad intravedere una traiettoria differente per quanto riguarda l'OMS della CIC. Questa componente organizzativa - all'interno della più ampia IMS del MRI - ha avuto a nostro parere l'effetto di innescare un processo di commercializzazione (ossia lo spostamento dal quadrante in basso a destra a quello in alto a sinistra) di una parte del MS. Nonostante la dichiarazione di voler usare questa forma legale solo in maniera strumentale abbiamo notato una sua importante influenza, in particolare nello spingere verso un processo di formalizzazione e burocratizzazione. Ricevere una sorta di salario in cambio del lavoro svolto all'interno delle commissioni della CIC ha portato sempre più a vedere la prestazione di servizi come il fine stesso del movimento, perdendone di vista l'aspetto prettamente rivoluzionario.
L'adozione di questo statuto ha in qualche modo introdotto una distinzione tra “i funzionari” - ossia chi lavora all'interno del Sistema Pubblico Cooperativo con sede a Barcellona in cambio di una compensazione economica - e le altre componenti locali della IMS, all'interno delle quali i soci autonomi producono beni reali per tentare di soddisfare le loro necessità in maniera alternativa alla logica capitalistica. A livello delle forme di partecipazione il processo di commercializzazione dell'OMS ha portato ad un progressivo distaccamento da forme di partecipazione politica più peculiari dei movimenti di protesta - ad esempio manifestazioni e volantinaggi - a favore di attività per lo sviluppo economico e sociale al proprio interno.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.2.1.3. LA OMS COME STRUTTURA DELLE OPPORTUNITA' EMOZIONALI
A partire dalle contribuzioni delle prospettive costruttivista e culturalista all'analisi dei movimenti sociali, si è sviluppato nel tempo un inedito filone di studi sull'importanza del ruolo delle emozioni all'interno di essi.46 Natalia Ruiz-Junco individua quattro concetti fondamentali maggiormente applicati per lo studio delle dinamiche emozionali all'interno dei movimenti sociali: lavoro emozionale, framing emozionale, culture emozionali e struttura delle opportunità emozionali.47 Non avendo il tempo di soffermarci sugli altri, sottolineiamo la rilevanza dell'interazione tra gli ultimi due concetti nelle differenze riscontrate durante le osservazioni partecipanti all'interno delle assemblee delle diverse componenti organizzative del MRI. L'analisi delle opportunità emozionali ha le sue radici nel già citato approccio delle opportunità politiche, il quale evidenzia l'influenza delle strutture e del contesto istituzionale sugli esiti di un movimento sociale. Sottolineando la componente emozionale di questo effetto, Nancy Whittier spiega il nuovo punto di vista sostenendo che: “le istituzioni all'interno delle quali opera il movimento sociale portano con sé le loro aspettative emozionali, permettendo e gratificando alcune manifestazioni affettive e rendendone altre inutili o incomprensibili”.48 Le opportunità emozionali si relazionano inoltre con le culture emozionali in due modalità: da un lato, i movimenti sociali devono decidere come rispondere alle circostanze mutevoli all'interno del proprio contesto, per cui le strutture di opportunità emozionali influenzano i loro discorsi relativi alle emozioni, che sono parte integrante della propria cultura emozionale; dall'altro, le opportunità emozionali possono creare le circostanze per l'emergere di particolari culture emozionali. Guenther individua questo fenomeno all'interno di uno studio su due movimenti femministi nella Germania dell'Est: i risultati di quest'ultimo mostrano come le organizzazioni sostenute economicamente dallo Stato sono caratterizzate da una “struttura delle opportunità emozionali che incoraggia un repertorio emozionale professionale”49, mentre quelle prive dei finanziamenti governativi hanno una struttura che conduce ad “una cultura emozionale vivace, per il mantenimento e la conservazione del coinvolgimento dei membri”50. In analogia con le conclusioni di Guenther, possiamo sostenere che la OMS della CIC - la cui forma legale ha comportato in certa misura una burocratizzazione e commercializzazione di questa parte di movimento - conforma una struttura delle opportunità emozionali che implica un repertorio emozionale maggiormente informale e professionale. Dall'altro lato, le componenti organizzative locali come le EcoReti si caratterizzano per una struttura che sostiene relazioni informali e di amicizia tra i membri, fomentando la emozioni più intense e vivaci all'interno del movimento.
6.2.2. IL “PERCHE'” DEL FATTORE ORGANIZZATIVO NEL MRI
6.2.2.1. MRI E TEORIA DEI NUOVI MOVIMENTI SOCIALI (TNMS)
Mentre nello stesso periodo autori nordamericani stavano gettando le basi per la TMR, in Europa si andava formando - grazie alle contribuzioni di Touraine, Melucci, Offe, Kriesi, Klandermas e Koopmans51 - una prospettiva differente, chiamata dei “Nuovi Movimenti Sociali” (NMS). Se da un lato la TMR si preoccupa del “come”, dall'altro gli autori della TNMS ricercano - secondo Melucci - il “perché” della formazione dei movimenti sociali in condizioni socio-storiche concrete.52 Inoltre, un'altra differenza tra i due approcci si può individuare nel loro campo di applicabilità, in quanto mentre la TMR ricerca strumenti analitici esplicativi di qualsiasi movimento sociale nella storia di una società, la TNMS ha come oggetto di studio un tipo specifico di movimenti, ossia quelli sorti al termine della Seconda Guerra Mondiale, ed in particolare a partire dagli anni Sessanta. Si tratta di una nuova “famiglia” (configurazione storica di movimenti che, al di là dei differenti obbiettivi, condivide una certa cosmovisione, caratteri organizzativi e occasionalmente campagne congiunte)53, che si aggiunge ai contromovimenti (“pro-vita”, anti-ecologisti..), movimenti nazionalisti a base etnica ed al tradizionale movimento operaio. La famiglia emergente comprende i movimenti pacifisti e antimilitaristi, ecologisti, femministi, terzomondisti, di difesa dei diritti umani e civili delle minoranze (ad esempio omosessuali ed antirazzisti) ed il movimento alternativo urbano (inclusi squatters o okupas). La formazione di questi movimenti sarebbe dovuta, secondo gli autori che adottano la prospettiva dei NMS, a un cambiamento delle condizioni strutturali e delle relative contraddizioni dovute alla trasformazione della società capitalista postindustriale. Così come le tensioni strutturali delle società del XVIII e XIX secolo XIX videro la formazione del movimento borghese e nel XX secolo darono la vita al movimento operaio, forme di protesta differenti si esplicitano nella contemporaneità a partire da nuove fratture sociali. Di conseguenza, la TNMS mira a analizzare le caratteristiche dell'ordine sociale tramite la spiegazione delle moderne forme di azione collettiva. Per passare rapidamente alla parte più rilevante per il nostro caso di studio, delineiamo - a partire dal riassunto di J. Casquette54 - quali sono i principali caratteri che la TNMS attribuisce ai NMS, e che li contraddistinguerebbero dalle altre famiglie:
1. Primazia della ricerca dell'aspetto dell'identità: I NMS si sviluppano a partire da conflitti le cui origini non sono tanto economiche e politiche, ma culturali e simboliche, riguardanti il senso d'appartenenza a un gruppo sociale differente (identità collettiva) ed il modo in cui essa ridefinisce l'identità individuale.
2. Mobilizzazione senza riferimento specifico alle classi: I NMS non mobilitano militanti e simpatizzanti in base alla loro posizione nella struttura sociale, nonostante si possa riscontrare una prevalenza di appartenenti alla classe media al loro interno.
3. Carattere difensivo: Mentre il movimento operaio ricercava il superamento della società capitalista, i NMS sostengono rivendicazioni più limitate.
4. Politicizzazione della vita quotidiana: In maniera strettamente collegata alla ricerca di identità collettiva e al carattere difensivo, i NMS politicizzano la vita quotidiana piuttosto che affrontare direttamente le autorità per ottenere garanzie e redistribuzioni come faceva il movimento operaio. Si propongono inoltre una serie di problemi provenienti da aspetti personali della vita quotidiana, come ad esempio la sessualità.
5. Profezia organizzativa o forme di azione autoriflessiva: La forma organizzativa e le pratiche dei NMS esemplificano i valori che il movimento vorrebbe vedere realizzati a livello macrosociale. Il movimento diventa quindi non solo uno strumento per raggiungere obbiettivi politici, ma un fine di per sé. Si parla di carattere profetico in quanto i NMS tentano di trasmettere al resto della società l'idea che le loro proposte organizzative non sono solo possibili, ma reali e visibili nel funzionamento quotidiano di attori sociali concreti.
6. Mezzi non convenzionali di partecipazione: Altro punto di rottura con il movimento operaio sarebbe il distanziamento deliberato dai canali istituzionali di partecipazione politica (elettorale e parlamentare) ed il ricorso al loro posto a forme non convenzionali di partecipazione.
7. Radicalismo autolimitato: I NMS possono essere interpretati come progetti per la difesa e l'approfondimento democratico della società civile. Questi movimenti rispetterebbero quindi l'integrità del sistema politico- economico.
8. Orientamento “libertario di sinistra”: Gli autori della TNMS individuano una cultura politica comune ai NMS, caratterizzata da un lato da aspetti del socialismo tradizionale (sfiducia nel mercato, l'investimento privato e l'etica del successo, sostenitori della redistribuzione egualitaria) e dall'altro da tratti del pensiero libertario (rifiuto delle autorità burocratiche, principi di autonomia e democrazia partecipativa).
Molti autori hanno in seguito sottolineato le debolezze della TNMS, evidenziando come molti di questi caratteri siano riscontrabili in movimenti ed organizzazioni del XIX secolo, ed in particolare che essi siano condivisi da tutti i movimenti nella loro fase iniziale (precedente all'istituzionalizzazione)55. Senza soffermarci su questo dibattito tentiamo di applicare la TNMS al caso del MRI, andando a vedere quali aspetti esso condivide o non condivide con i NMS, in particolare per quanto riguarda il fattore organizzativo.
Dal punto di vista della primazia dei temi identitari su quelli economico-politici, la TNMS si rivela utile nel sottolineare l'importanza dell'identità collettiva. Essa, a nostro parere, si compone all'interno del MRI di vincoli identitari differenti a seconda della posizione dell'individuo all'interno della rete territoriale. In altre parole, un membro di una commissione con sede a Barcellona sentirà un forte senso di appartenenza alla CIC, lavorando a stretto contatto con i suoi colleghi e partecipando a riunioni inter-commissione ed Assemblee Permanenti. All'estremo opposto, un socio autonomo che realizza un'attività utilizzando la copertura legale della CIC sarà probabilmente molto meno aggiornato sulla vita della Cooperativa, avendo tuttavia relazioni sociali più solide con il NAL o la EcoRete più vicini e sentendosi più parte di esse che non della CIC in generale. D'altra parte, possiamo sostenere che la TNMS si riveli nel nostro caso di minore rilevanza nel sottovalutare i temi economico-politici. L'emergenza di valori post-materialisti nei NMS - avente come base l'opulenza della classe media nel loro contesto storico - è stata compensata negli ultimi anni da un ritorno di temi prettamente materiali, anche a causa della crisi economica. Ad esempio, il MRI pone come suo obbiettivo primario coprire le necessità primarie dei suoi membri (e assicurarne l'integrazione, anche dal punto di vista lavorativo), in quanto non soddisfatte dal sistema capitalista e dalle distorsioni dei mercati. 56 Passando all'aspetto della politicizzazione della vita quotidiana, possiamo sostenere che nel MRI esso viene rispecchiato in buona misura. Dotandosi di uno statuto legale di cooperativa la CIC offre ai propri membri l'opzione di partecipare non solo tramite l'attivismo, ma anche tramite l'apporto di lavoro (in commissioni così come in progetti produttivi) che viene ricompensato (compensazioni nel primo caso, benefici dell'attività nel secondo). Questo, insieme alla possibilità di usufruire dei servizi del Sistema Pubblico Cooperativo, dovrebbe contribuire a coinvolgere sempre più aspetti della vita di un membro attivo. Egli potrà partecipare ad un'Assemblea, comunicare con i propri amici tramite il social network offerto dalla piattaforma online della CIC, lavorare in un progetto produttivo e fare la spesa tramite il “rebost” locale. L'idea stessa di creare una “società parallela” si basa sul fatto che chi ne fa parte inizi a spendere una porzione sempre maggiore della propria vita all'interno del movimento, utilizzandone i servizi e condividendo i valori che ne orientano le scelte quotidiane. Continuando con l'analisi, possiamo dire che sia la mancanza di un riferimento di classe che l'utilizzo di mezzi non convenzionali di partecipazione politica sono rilevanti per quanto riguarda il caso del MRI. Per quanto riguarda il primo aspetto, la CIC proclama nel proprio statuto di essere rivolta alla difesa di “persone o collettivi, con difficoltà particolari d'integrazione o sottoposti a qualsiasi tipo di esclusione sociale o limitazione di diritti sociali”57, definendo quindi la propria base sociale di riferimento senza utilizzare termini identitari di classe e dichiarando nei propri principi di essere una “Cooperativa inclusiva i enxarxadora per a tota la societat”58. Parlando del secondo aspetto, la partecipazione politica del MRI avviene fondamentalmente tramite la disobbedienza civile (in particolare economica) e più in generale l'azione diretta. Secondo J. Casquette, le caratteristiche definitorie della disobbedienza civile sono: atto pubblico, nonviolento e cosciente che rompe una legge giudicata ingiusta59. Le forme di azione del movimento si sono caratterizzate per la prevalenza di questa strategia sin dal suo inizio (grazie alla disobbedienza finanziaria e l'espropriazione bancaria di Eric Duran), a scapito di altri mezzi non convenzionali molto più comuni, come ad esempio le manifestazioni. Ciò è dovuto fondamentalmente agli obbiettivi del movimento, i quali non mirano tanto alla rivendicazione o alla denuncia, quanto alla costruzione di un'alternativa sistemica tramite la disobbedienza, in alcuni casi chiamata appunto “politica dell'esempio”60 (nei principi della CIC troviamo la volontà di condividere le proprie pratiche con tutta la società)61. Si tratta di forme di azione diretta derivate dal rifiuto, a partire dalle proprie basi ideologiche, di qualsiasi partecipazione convenzionale tramite gli organi decisionali istituzionalizzati. La stessa decisione di formarsi in quanto Cooperativa proviene dalla volontà di agire direttamente ad un livello che non sia quello delle pressioni ai partiti politici o alle istituzioni rappresentative in generale. Di fatto, l'azione diretta è sempre stata la pratica preferita da movimenti ispirati al pensiero anarchico62: questo ci rimanda al carattere “libertario di sinistra” della cultura politica dei NMS. L'aspetto ideologico dei NMS viene rispecchiato nel caso del MRI, esplicitandosi in altre due analogie oltre a quella dell'azione diretta: in prima istanza, esso condivide il principio anarchico fondamentale di sovranità individuale e negazione dell'autorità come criterio strutturante dell'organizzazione sociale (esplicitato nell'assemblearismo, nella presa di decisioni per consenso e nella struttura a frattale, la quale nega qualsiasi gerarchia organizzativa); in secondo luogo, l'auto-realizzazione dell'individuo a cui ambisce una delle prime frasi dello statuto della CIC63 rimanda ad una componente etica comune alla tradizione anarchica. Si tratta - successivamente alla soddisfazione delle necessità basiche - di ricercare il miglioramento della qualità della vita verso valori post-materialisti, basati sulla semplicità volontaria ed il suo effetto educativo. Inoltre il progresso, in contrapposizione con la tradizione marxista, non viene inteso come incremento della produzione economica materiale, ma come avanzamento verso l'abolizione dell'autorità, della disuguaglianza e dello sfruttamento economico.64 Negli obbiettivi generali della CIC, a proposito della trasformazione sociale, si afferma esplicitamente la volontà di liberarsi dal materialismo65, mentre dall'altro lato l'anti-produttivismo e l'anti-consumismo intrinseci alle posizioni ecologiste espresse dal movimento - così come la sua fede nell'economia solidaria - possono rimandare alla semplicità di vita della tradizione anarchica.66 Per quanto riguarda i caratteri di difesa e di radicalismo autolimitato dei NMS, possiamo sostenere una loro applicabilità parziale nel caso del MRI. Per quanto effettivamente la CIC si costituisca per difendere individui o collettivi esclusi dal sistema capitalista e creare un marco di partecipazione economica e politica, gli obbiettivi del movimento, in particolare quando si parla di “società parallela”, sono volti ad una trasformazione sistemica che sfida direttamente le istituzioni politico-economiche egemoniche. Le pratiche del MRI non costituiscono tanto un approfondimento democratico quanto un tentativo rivoluzionario basato su valori radicali libertari. Il fatto che la filosofia della Rivoluzione Integrale si distanzi dall'idea di sovversione rapida e violenta delle istituzioni dominanti per proporre una trasformazione nel lungo periodo, nonviolenta e al margine del sistema egemonico, non significa che essa cessi di essere rivoluzionaria. Al contrario, essa si inserisce a pieno titolo nell'ideologia libertaria: Paul Goodman, uno dei massimi pensatori dell'anarchismo contemporaneo, scrive infatti che:
una società libera non può essere realizzata sostituendo un 'ordine nuovo' a quello vecchio, ma piuttosto con l'ampliamento delle sfere d'azione libere, fino a che esse vengano a costituire il fondamento della intera vita sociale67.
Per quanto riguarda l'analisi dei fattori organizzativi, la TNMS si rivela altamente proficua per lo studio del MRI: in particolare, se la TMR ci ha aiutato nell'osservare il “come” dell'organizzazione del movimento, la TNMS può spiegare in buona misura il “perché” della sua struttura. La “profezia organizzativa” riscontrata dagli autori della TNMS nelle nuove forme di azione collettiva si esplicita in buona misura anche nella Rete Territoriale (RT), in quanto essa rappresenta una realizzazione pratica dei valori della Rivoluzione Integrale e dell'anarchismo, volta alla dimostrazione dell'esistenza di alternative concrete al sistema criticato. La struttura a frattale si inserisce nella tradizione organizzativa anarchica per la sua forma reticolare, in opposizione alla forma piramidale delle organizzazioni autoritarie. Utilizzando le parole di Colin Ward:
I pensatori classici anarchici immaginarono l'intera organizzazione sociale come un insieme di gruppi locali simili: la comune quale nucleo territoriale (non una diramazione dello Stato, bensì la libera associazione di tutti i membri interessati, che può essere un'entità cooperativa, professionale, o semplicemente un'unione provvisoria di più persone unite da una necessità comune) e il sindacato, o consiglio operaio, quale unità produttiva. Queste unità si aggregherebbero non come pietre di una piramide, dove lo strato più basso deve sopportare il peso maggiore, ma come le maglie di una rete, una rete di gruppi autonomi.68
Al di là delle forme storiche di comune e sindacato la RT, tramite l'interazione orizzontale di processi collettivi, pubblici ed autonomi, rispecchia intrinsecamente la teoria organizzativa reticolare e federale della tradizione anarchica. D'altra parte, ognuno degli elementi della RT è volto alla realizzazione dei principi della Rivoluzione Integrale. In particolare, il Sistema Pubblico Cooperativo, tramite la creazione di servizi volti a coprire le necessità di qualsiasi socio che ne abbia bisogno, realizza l'interesse per il bene comune, i valori di cooperazione e solidarietà, di equità e giustizia sociale, di uguaglianza nella diversità e supporto mutuo. L'inclusività e la condivisione con la società si manifestano nell'attività del Nodo Informazione, che si occupa dell'estensione della rete e della sensibilizzazione al suo interno ed esterno. L'ecologismo si esplicita invece nei requisiti di sostenibilità ambientale posti ai progetti produttivi, oltre che nelle EcoReti in qualità di unità economiche bio-regionali. I progetti produttivi e tutte le opportunità generate dal concetto di auto-occupazione cercano di offrire strumenti organizzativi per l'auto-realizzazione dell'individuo, tentando di dare la possibilità di esprimere le proprie capacità ed interessi in maniera svincolata dalle norme sociali del sistema egemonico. L'Assemblea Permanente, assieme alle assemblee di ogni componente della RT (ogni ER o NAL ne possiede una), mettono in pratica i valori dell'assemblearismo, dell'autogestione e dell'autonomia.
Di fatto, nonostante le peculiarità funzionali di ogni elemento organizzativo, i principi hanno il medesimo ruolo strutturante all'interno di ognuna di essi grazie alla forma organizzativa generale che, per la sua struttura a frattale, si caratterizza per una composizione (anche valoriale) invariante al cambiamento di scala.
7. CONSIDERAZIONI FINALI
Mentre questo studio viene concluso il MRI vive, dopo 5 anni di attività, una fase particolarmente delicata, aggravata da un importante deficit economico. Il processo di commercializzazione e burocratizzazione riguardante l'OMS più strutturata (la CIC) - con le relative opportunità emozionali che portano a repertori più formali - individuata all'interno dell'analisi delle conseguenze del fattore organizzativo sul movimento denota un conflitto con i principi stessi della Rivoluzione Integrale. L'importante componente anarchico-libertaria dell'ideologia del movimento rifiuta in maniera intrinseca un tipo di organizzazione formalizzata e burocratica in cui il lavoro sia separato tra “chi pensa” e “chi lavora”. La dipendenza dalla compensazione economica per una stessa attività ripetuta ogni giorno in una commissione della cooperativa non può coesistere con i principi di auto-realizzazione individuale e di superamento del materialismo. Tuttavia, a nostro avviso possono essere individuati tre fattori fondamentali a favore di uno sviluppo positivo di questo conflitto. In prima istanza, se la nozione di “profezia organizzativa” della TNMS è effettivamente applicabile al caso del MRI come emerso da questo studio, il movimento adotterà le misure necessarie per riformarsi lungo linee più conformi ai propri principi. Secondo, l'ideologia stessa del movimento e dei suoi membri impedisce derive burocratiche: possiamo ritenere altamente improbabile che un tipo di organizzazione anarchica - come abbiamo visto, intrinsecamente reticolare ed orizzontale - permetta la formazione di un centro decisionale ad un livello differente dal resto delle sue componenti. Infine, la struttura a frattale del MRI si caratterizza per i principi di libertà ed autonomia dei suoi nodi, per cui in caso la CIC non riuscisse a riformarsi o fallisse a causa del deficit economico, le EcoReti e i Nuclei d'Autogestione Locale potrebbero decidere di staccarsi da essa, creare un'altra Cooperativa Integrale o inventare altre forme di coordinamento. Di fatto, il conflitto tra la forma e i relativi repertori emozionali caratterizzanti la CIC a causa dei processi descritti sopra è già stato individuato come problematico da parte del movimento. Come riscontrato durante le osservazioni partecipanti i membri della CIC, ed in maniera ancora più radicale quelli delle EcoReti ed i Soci Autonomi, ritengono necessaria una riforma ed un cambiamento all'interno del movimento. Di fatto, le ultime due giornate assembleari della CIC - giugno e luglio 2015 - erano dedicate rispettivamente alla revisione dei principi e al conseguente cambiamento delle strategie economiche.
8. CONCLUSIONI
All'interno di questo studio abbiamo tentato di analizzare il Movimento per la Rivoluzione Integrale (MRI) in Catalogna tramite la strategia di ricerca del caso di studio. Più in particolare, abbiamo inizialmente delineato i caratteri del MRI tramite un breve excursus sulla sua storia e i suoi principi, riconosciuto la possibilità di farlo rientrare nella definizione di movimento sociale per passare in seguito ad una sua comparazione con altre tipologie di movimenti in espansione nella contemporaneità. Grazie ad essa abbiamo potuto riscontrare: le analogie del MRI con la corrente più radicale del Movimento Cooperativista; la condivisione con i Movimenti Urbani dei caratteri per lo più derivanti dall'introduzione di tematiche prodotte dalla globalizzazione; infine, l'affinità con il Movimento di Transizione, seppure sottolineando una maggiore radicalità ideologica ed il prevalere di elementi politico-economici all'interno MRI.
La seconda parte dell'elaborato è stata dedicata invece ad un approfondimento sulla componente organizzativa del MRI, utilizzando le contribuzioni teoriche di alcuni filoni di studio ritenuti particolarmente pertinenti. Per analizzare come il MRI e la sua organizzazione si sono evoluti nel tempo siamo stati aiutati dalla Teoria della Mobilitazione delle Risorse (TMR), dal modello di H. Kriesi e dalla prospettiva emozionale. Tramite la TMR abbiamo potuto soffermarci sulle modalità in cui il movimento mobilita le sue risorse, sulla differenziazione tra Organizzazione e Industria del movimento (OMS / IMS), le relazioni tra OMS ed altre entità sociali, il ruolo delle tecnologie nell'attività dell'OMS e la distinzione tra OMS formale e reale. In seguito, il modello di H. Kriesi ci ha permesso di delineare la traiettoria dell'OMS più strutturata all'interno del MRI (la Cooperativa Integrale) verso un processo di commercializzazione e burocratizzazione, mostrando in questo modo le conseguenze della OMS formale adottata del movimento. Rimanendo in questa ottica, l'approccio emozionale ai movimenti sociali sviluppato a partire dalla prospettiva culturalista e costruttivista ci è servito ad individuare le differenti strutture delle opportunità emozionali - con i relativi repertori emozionali e culture emozionali - riscontrate tramite le osservazioni partecipanti all'interno di assemblee di due differenti OMS del MRI (Cooperativa Integrale ed EcoRete). Per quanto riguarda la spiegazione del “perché” della formazione dei MRI e del suo fattore organizzativo abbiamo utilizzato invece la Teoria dei Nuovi Movimenti Sociali (TNMS). In particolare, sono stati individuati i caratteri esplicativi dei NMS condivisi dal MRI, evidenziando come l'infrastruttura del movimento sia originata direttamente a partire dalla sua ideologia e si configuri in questo modo per un tentativo pratico di dimostrare l'esistenza di alternative concrete al sistema criticato.
Infine, sono state presentate alcune considerazioni finali a proposito del conflitto tra il carattere ed i repertori emozionali formali assunti dalla CIC tramite il processo di commercializzazione e l'ideologia del movimento. A partire dalla teoria della “profezia organizzativa”, dall'ideologia intrinsecamente contraria alla burocrazia, dalla libertà di cui godono i nodi della struttura a frattale e dal fatto che il movimento abbia già individuato questo conflitto come problematico siamo stati spinti però ad adottare una posizione ottimistica sulle possibilità che questo conflitto abbia un esito positivo.
9. APPENDICE: ALLEGATI (diagrammi elaborati dalla CIC)
- DIAGRAMMA 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 7
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- DIAGRAMMA 8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- MAPPA 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
- D. A. Snow and D. Trom, “The case study and the study of social movements” in: B. Klandermans, S. Staggenborg, “Methods of Social Movement Research”, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002
- CIC, “Principis Generals”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/4777/, ultima cons. 10/06/2015
- “Invito a un incontro Internazionale per la creazione del Blocco per la Rivoluzione Integrale”, https://integrarevolucio.net/wp-content/uploads/2013/02/BRI-ita-1.1.pdf, ultima cons. 10/07/2015
- E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006
- Coord. Coopera que és la pera, “Fer el salt: Cooperativisme i Economia Solidària”, Barcellona, Comú, El Grillo Libertario, 2012
- M. Martì i Costa e J. Bonet i Martì, “Movimientos urbanos hoy: heterogeneidad, fragmentacion y glocalizacion”, in: “La red en la ciudad, anuario de movimientos sociales 2008”, Barcellona, Icaria, 2008
- Roig21, https://www.facebook.com/roig21, ultima cons. 15/07/2015
- Masoveria Urbana M.U.L.A., https://masoveriaurbana.wordpress.com/, ultima cons. 15/07/2015
- Juan Del Río, “Guia del Movimiento de Transicion, como transformar tu vidaen la ciudad”, Madrid, Catarata, 2015
- CIC, “Documents bàsics i textos informatius”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/4770/, ultima cons. 14/07/2015
- WikiCIC, “Curs de Capacitació primavera 2014»,https://wiki.cooperativa.cat/index.php?title=Curs_de_Capacitaci %C3%B3_primavera_2014, ultima cons. 14/07/2015
- Treccani, s.v. “Frattale”, http://www.treccani.it/enciclopedia/frattale/, ultima cons. 15/07/2015
- WikiCic, “Curs de Capacitació primavera 2014», MODUL 4: “Xarxa territorial”, https://wiki.cooperativa.cat/index.php?title=M %C3%92DUL_4:_Xarxa_territorial, ultima cons. 12/06/2015
- J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998
- WikiCIC, “Curs de Capacitació primavera 2014», MODUL 2: La protecció de l'activitat autogestionària davant l'Estat i la banca, https://wiki.cooperativa.cat/index.php?title=M%C3%92DUL_2:_La_protecci %C3%B3_de_l%27activitat_autogestion%C3%A0ria_davant_l %27Estat_i_la_banca., ultima cons. 15/07/2015
- Jeff Goodwin, James M. Jasper, Francesca Polletta, “Passionate Politics: Emotions and Social Movements”, Chicago, University of Chicago Press, 2001
- N. Ruiz-Junco, “Feeling Social Movements: Theoretical Contributions to Social Movement Research on Emotions”, American University, Sociology Compass 7/1: 45-5, 2013
- “ESTATUTS SOCIALS DE LA XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES SCCL”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/2568/, ultima cons. 15/06/2015
- C. Ward, “Anarchia come organizzazione”, 2. ed, Manocalzati, elèuthera, 2013
[...]
1 D. A. Snow and D. Trom, “The case study and the study of social movements” in: B. Klandermans, S. Staggenborg, “Methods of Social Movement Research”, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002, p. 151
2 D'ora in poi, utilizzeremo MRI intendendo il Movimento per la Rivoluzione Integrale all'interno della regione Catalana.
3 CIC, “Principis Generals”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/4777/, ultima cons. 10/06/2015
4 “Invito a un incontro Internazionale per la creazione del Blocco per la Rivoluzione Integrale”,
https://integrarevolucio.net/wp-content/uploads/2013/02/BRI-ita-1.1.pdf, ultima cons. 10/07/2015
5 E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p.31
6 In: E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p.31
7 Tutta la parte iniziale, fino a questo punto, ossia l'excursus sulla storia e le caratteristiche del movimento cooperativista, sono tratte dall'opera con licenza Creative Commons: Coord. Coopera que és la pera, “Fer el salt: Cooperativisme i Economia Solidària”, Barcellona, Comú, El Grillo Libertario, 2012
8 M. Martì i Costa e J. Bonet i Martì, “Movimientos urbanos hoy: heterogeneidad, fragmentacion y glocalizacion”, in: “La red en la ciudad, anuario de movimientos sociales 2008”, Barcellona, Icaria, 2008
9 Ibidem, p.39
10 Cfr. Roig21, https://www.facebook.com/roig21; Masoveria Urbana M.U.L.A., https://masoveriaurbana.wordpress.com/; ultima cons. 15/07/2015
11 Juan Del Río, “Guia del Movimiento de Transicion, como transformar tu vida en la ciudad”, Madrid, Catarata, 2015
12 Momento in cui la capacità di estrazione di energia fossile raggiunge il suo punto massimo a livello storico e che è seguito da un declino; questo successe nel 2006, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia.
13 “Resilienza” è un termine mutuato dall'ecologia, indicante la capacità di un sistema di reagire e adattarsi a cambiamenti prodotti da forze esterne conservando la sua stessa funzione, struttura e identità.
14 Juan Del Río, “Guia del Movimiento de Transicion, como transformar tu vida en la ciudad”, Madrid, Catarata, 2015, pp. 66-67
15 Juan Del Río, “Guia del Movimiento de Transicion, como transformar tu vida en la ciudad”, Madrid, Catarata, 2015, p.58
16 Juan Del Río, “Guia del Movimiento de Transicion, como transformar tu vida en la ciudad”, Madrid, Catarata, 2015, p.234
17 Ciò non preclude che, in quanto autonomo ed indipendente, un progetto o un nucleo del MRI possa avere relazioni anche collaborative con le istituzioni rappresentative locali (parliamo infatti della tendenza ideologica generale).
18 Juan Del Río, “Guia del Movimiento de Transicion, como transformar tu vida en la ciudad”, Madrid, Catarata, 2015, p.59
19 CIC, “Documents bàsics i textos informatius”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/4770/, ultima cons. 14/07/2015
20 WikiCIC, “Curs de Capacitació primavera 2014», https://wiki.cooperativa.cat/index.php? title=Curs_de_Capacitaci%C3%B3_primavera_2014, ultima cons. 14/07/2015
21 La Central d'Abastiment Catalana (CAC) si occupa di assicurare una coordinazione nella fornitura di beni alimentari biologici e sostenibili, processati e non, ai vari “rebostos” (dispense) dei progetti locali. In questo modo si cerca di rafforzare le sinergie tra produttori e consumatori, così consolidando il sistema economico generale della CIC.
22 CTiT (Ciència, Tècnica i Tecnologia)
23 Letteralmente: “dispensa”, ossia un insieme di prodotti acquistati in maniera collettiva a produttori parte della CIC o esterni (mantenendo normalmente criteri ecologici e di piccola produzione a chilometro zero).
24 “Negozio”, solitamente di abiti usati, in cui si possono liberamente portare a casa i capi che interessano, oltre che eventualmente lasciarne se si vuole. Si tratta di un'iniziativa già comune in molti centri sociali autogestiti e volta alla demonetarizzazione delle relazioni economiche oltre che al riuso in funzione anti- consumistica.
25 Punto di riferimento della Rivoluzione Integrale e della CIC nel centro di Barcellona, nonché sede delle commissioni della cooperativa.
26 “Carovana autosufficiente”, si occupa della diffusione itinerante di attività educative o promozionanti la CIC in fiere o altri eventi pubblici.
27 Dal punto di vista delle forme di partecipazione all'interno del MRI quella del socio auto-occupato è sicuramente una delle più interessanti, in particolare in quanto opportunità che in un contesto di crisi e disoccupazione unisce possibilità economiche ad una conversione politica.
28 Treccani, s.v. “Frattale”, http://www.treccani.it/enciclopedia/frattale/, ultima cons. 15/07/2015
29 WikiCic, “Curs de Capacitació primavera 2014», MODUL 4: “Xarxa territorial”, https://wiki.cooperativa.cat/index.php?title=M%C3%92DUL_4:_Xarxa_territorial, ultima cons. 12/06/2015
30 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.61
31 Ibidem
32 E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p.89
33 Jenkins in: J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.61
34 Ibidem, p. 62
35 Ibidem
36 Cfr. Comparazione tra MRI e Movimento Cooperativista (Cap. 5.1.)
37 E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p.94
38 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.70
39 Ibidem
40 Ibidem, p.71
41 Ibidem, pp.72-73
42 Cfr. Cap. 6.1.3.
43 WikiCIC, “Curs de Capacitació primavera 2014», MODUL 2: La protecció de l'activitat autogestionària davant l'Estat i la banca, https://wiki.cooperativa.cat/index.php?title=M%C3%92DUL_2:_La_protecci %C3%B3_de_l%27activitat_autogestion%C3%A0ria_davant_l%27Estat_i_la_banca., ultima cons. 15/07/2015
44 In: E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p.54
45 E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p.54
46 Cfr. Jeff Goodwin, James M. Jasper, Francesca Polletta, “Passionate Politics: Emotions and Social Movements”, Chicago, University of Chicago Press, 2001
47 N. Ruiz-Junco, “Feeling Social Movements: Theoretical Contributions to Social Movement Research on Emotions”, American University, Sociology Compass 7/1: 45-5, 2013, p. 46
48 In: N. Ruiz-Junco, “Feeling Social Movements: Theoretical Contributions to Social Movement Research on Emotions”, American University, Sociology Compass 7/1: 45-5, 2013, p. 50
49 In: N. Ruiz-Junco, “Feeling Social Movements: Theoretical Contributions to Social Movement Research on Emotions”, American University, Sociology Compass 7/1: 45-5, 2013, p. 51
50 Ibidem
51 E. Neveu, “Sociología de los Movimientos Sociales”, Barcelona, Hacer, 2006, p107; J. Casquette aggiunge anche Cohen, Kitschelt, Habermas, Inglehart ed Eder alla lista, in: J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.101
52 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.99
53 Della Porta e Rucht in: J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.100
54 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.120-121
55 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.121
56 Ricordiamo comunque che la CIC pone tra i suoi principi la liberazione dal materialismo (Cfr. Cap 3)
57 “ESTATUTS SOCIALS DE LA XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES SCCL”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/2568/, ultima cons. 15/06/2015
58 CIC, “Principis Generals”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/4777/, ultima cons. 10/06/2015
59 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.112-113
60 Ibidem, p.111
61 Cfr. Cap. 3
62 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.115
63 ESTATUTS SOCIALS DE LA XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES SCCL”, https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pages/view/2568/, ultima cons. 15/06/2015
64 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p.115
65 Cfr. Cap 3
66 J. Casquette, “Política, cultura y movimientos sociales”, Bilbao, Bakeaz, 1998, p. 115
67 In: C. Ward, “Anarchia come organizzazione”, 2. ed, Manocalzati, elèuthera, 2013, p. 14
Domande frequenti
Che cos'è l'obiettivo di questo documento?
L'obiettivo di questo documento è analizzare la forma organizzativa dei movimenti sociali, nello specifico la struttura a frattale, tramite lo studio di caso del Movimento per la Rivoluzione Integrale (MRI) in Catalogna. Il documento mira a comprendere la dimensione organizzativa del movimento in modo qualitativo.
Qual è la metodologia utilizzata in questo studio?
Lo studio utilizza la metodologia del caso di studio, concentrandosi sul MRI in Catalogna. Vengono utilizzate diverse tecniche, tra cui l'analisi dei materiali del movimento e l'osservazione partecipante, per analizzare il fattore organizzativo.
Cos'è la Rivoluzione Integrale (RI)?
La Rivoluzione Integrale è un processo per la costruzione di una nuova società autogestita, basata sull'autonomia e l'abolizione delle forme di dominazione vigenti, come lo Stato e il capitalismo. Si realizza tramite Cooperative Integrali e altre componenti di una rete territoriale.
Il MRI è considerato un movimento sociale?
Sì, il MRI è considerato un movimento sociale in quanto rispetta i criteri di azione collettiva: i protagonisti agiscono in maniera congiunta ed intenzionale per affermare un progetto esplicito, seguendo una logica rivendicativa e aspirando a un ordine di vita radicale.
Come si compara il MRI con altri movimenti sociali?
Il MRI condivide affinità con la corrente più radicale del Movimento Cooperativista, principi comuni con i Movimenti Urbani (soprattutto quelli derivanti dalla globalizzazione), e affinità con il Movimento di Transizione, pur mostrando una maggiore radicalità ideologica e una prevalenza di elementi politico-economici.
Qual è la forma organizzativa del MRI?
La forma organizzativa del MRI è una rete territoriale che connette progetti eterogenei ma ideologicamente affini. Si distinguono processi collettivi (Cooperative Integrali, EcoReti, Nuclei di Autogestione Locale) e processi autonomi/pubblici (Progetti di Servizi Comuni, Progetti Autonomi d'Iniziativa Collettivizzata, Progetti Autonomi).
Cos'è una struttura a frattale nel contesto del MRI?
La struttura a frattale indica che i processi costituenti la Rete Territoriale, al di là delle proprie funzioni specifiche, assumono una forma condivisa derivante dai principi della Rivoluzione Integrale (organizzazione assembleare, democrazia diretta, ecologismo, ecc.). Ogni componente della RT presenta gli stessi caratteri, conservando la propria autonomia e libertà in una relazione orizzontale con le altre.
Quali sono le spiegazioni teoriche per la forma organizzativa del MRI?
Il documento utilizza diverse teorie per spiegare la forma organizzativa del MRI, tra cui la Teoria della Mobilitazione delle Risorse (TMR), il modello di H. Kriesi e la Teoria dei Nuovi Movimenti Sociali (TNMS). Queste teorie aiutano a comprendere come il movimento mobilita le risorse, come si è evoluta la sua organizzazione e perché ha adottato determinate strutture.
Quali sono le considerazioni finali riguardo al futuro del MRI?
Il documento evidenzia un conflitto tra la commercializzazione/burocratizzazione della Cooperativa Integrale (CIC) e i principi del MRI. Tuttavia, si individuano fattori che potrebbero portare a uno sviluppo positivo del conflitto, tra cui la "profezia organizzativa", l'ideologia libertaria e la struttura a frattale del movimento.
Cosa sono le EcoReti (ER)?
Le EcoReti sono reti di autogestione bio-regionale con l'obiettivo di promuovere scambi, sia con moneta sociale che con altre forme non monetarie, per la formazione di un mercato sociale che aiuti lo sviluppo di progetti autogestiti.
Cosa sono i Nuclei di Autogestione Locale (NAL)?
I Nuclei di Autogestione Locale sono spazi d'interazione basati nella prossimità, nei quali iniziative collettive e progetti autonomi interagiscono con un alto livello di fiducia.
Cosa sono i Progetti di Servizi Comuni?
I Progetti di Servizi Comuni sono iniziative strategiche per garantire il soddisfacimento delle necessità che il sistema vuole coprire. Normalmente si tratta di progetti complessi che sono difficilmente sviluppabili in maniera autonoma.
- Citar trabajo
- Francesco Facchini (Autor), 2015, Organizzare l'Azione Collettiva, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353359