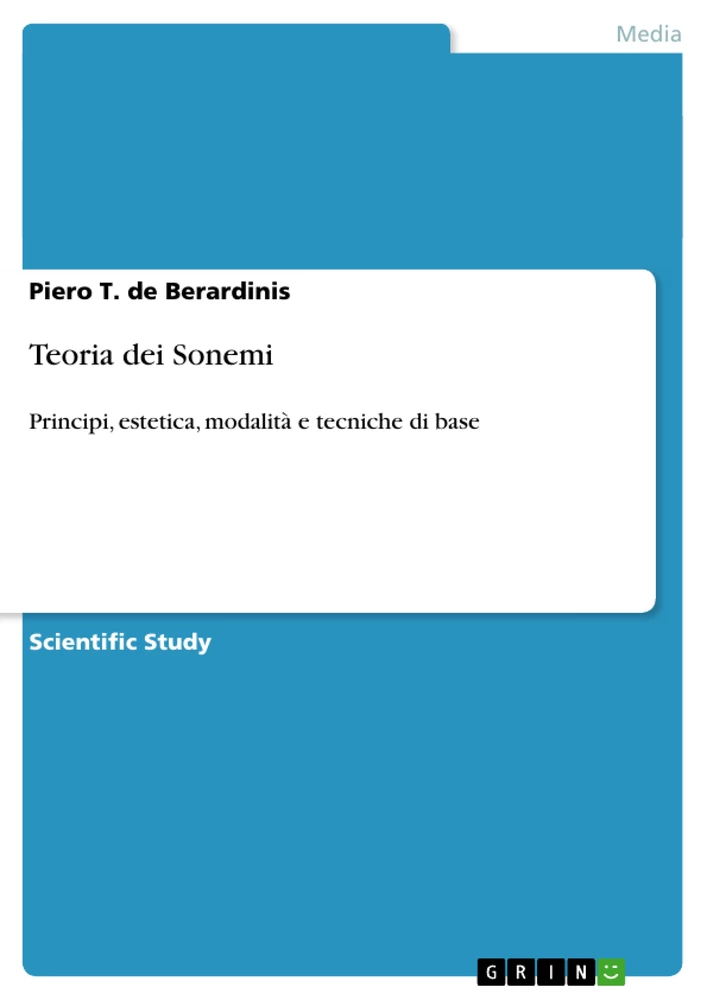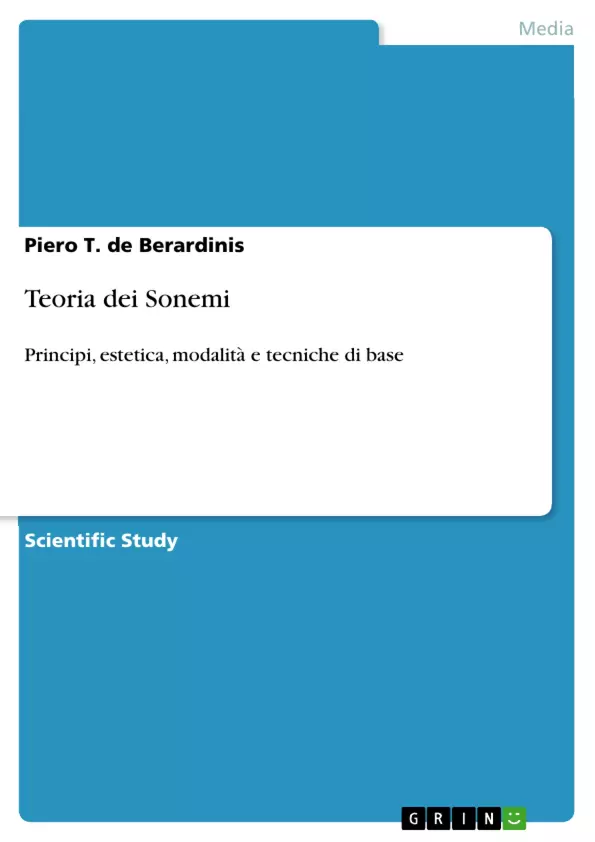Oggetto di studio della dissertazione è l'analisi e la definizione di una originale metodologia compositiva, denominata teoria dei Sonemi, nella quale vengono introdotti concetti e tecniche mutuati dall'integralismo di Hanslick nell'ottica dell'ermeneutica di Pareyson e della scuola fenomenologica di Husserl, in generale, e di Alfred Schütz in particolare. L'evoluzione del linguaggio musicale, nell'indipendenza dal sistema tonale, pur nella conformità e coerenza storica, porta alla definizione di nuovi linguaggi espressivi fortemente correlati al background culturale soggettivo, sulla base di un comune codice semantico, solidamente strutturato, introducendo il concetto di originale musicale (opera unica) da sequenze generative primarie (sonemi).
Vengono quindi esaminati il rapporto tra arti e arte musicale nella sua valenza simbolica, le origini storiche, il processo evolutivo, le correlazioni contestuali, le tecniche paradigmatiche di base e i criteri di generazione strutturale con alcuni esempi operativi e la descrizione dello strumento informatico, in logica open-source con funzioni CMAC (Composizione Musicale Assistita dal Computer), ad essa finalizzato.
Inhaltsverzeichnis (Indice dei contenuti)
- Premessa
- Introduzione
- PARTE PRIMA
- Capitolo I: L'elemento neutro nell'arte musicale
- Capitolo II: L'Integralismo musicale di Hanslick
- Capitolo III: Principi di estetica fenomenologica: Alfred Schütz
- Capitolo IV: L'approccio ermeneutico di Pareyson
- Capitolo V: Sinossi concettuale
- PARTE SECONDA
- Capitolo VI: Esperienze nell'assoluto
- Capitolo VII: Astrattismo e arte
- Capitolo VIII: Linguaggi integrali
- Capitolo IX: Linguaggi complessi
- Capitolo X: Linguaggi simbolici
- Capitolo XI: Linguaggi astratti
- Capitolo XII: Linguaggi assoluti
- Capitolo XIII: Sonemi
- PARTE TERZA
- Capitolo XIV: L'originale musicale
- PARTE QUARTA
- Capitolo XV: Tecniche CMAC: OpenMusic e MusicXII
- Bibliografia
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Obiettivi e temi principali)
Questa tesi si propone di analizzare e definire una metodologia compositiva originale, la "teoria dei Sonemi", integrando concetti e tecniche dell'integralismo di Hanslick con l'ermeneutica di Pareyson e la fenomenologia di Husserl e Schütz. Si esamina l'evoluzione del linguaggio musicale post-tonale, il rapporto tra arti e musica nella sua valenza simbolica, e le tecniche di generazione strutturale dei sonemi.
- Analisi della teoria dei Sonemi come metodologia compositiva originale.
- Integrazione di concetti dell'integralismo di Hanslick, dell'ermeneutica di Pareyson e della fenomenologia.
- Esame dell'evoluzione del linguaggio musicale e del suo rapporto con il background culturale soggettivo.
- Studio del concetto di "originale musicale" e delle sequenze generative primarie (sonemi).
- Descrizione delle tecniche CMAC (Composizione Musicale Assistita dal Computer) per la realizzazione dei sonemi.
Zusammenfassung der Kapitel (Riepilogo dei capitoli)
Capitolo I: L'elemento neutro nell'arte musicale: Questo capitolo analizza la natura del contesto comunicativo in ambito musicale, esplorando il concetto di "musica" come "forma simbolica" che necessita di interpretazione. Si introduce l'idea di un "elemento neutro" integrato da elementi poietici, estesici e soggettivi come base del processo creativo musicale. L'importanza di questo capitolo risiede nel porre le basi teoriche per la comprensione del linguaggio musicale come processo interpretativo, anziché un semplice sistema di regole.
Capitolo II: L'Integralismo musicale di Hanslick: Questo capitolo si concentra sul pensiero di Eduard Hanslick e sul suo integralismo musicale. Viene approfondita la concezione della musica come pura forma, indipendente da significati extra-musicali, analizzando l'impatto di questa teoria sulla composizione e sulla comprensione dell'arte musicale. L'analisi critica del pensiero di Hanslick fornisce una prospettiva fondamentale per comprendere il punto di partenza della ricerca e le sue implicazioni sulla teoria dei Sonemi.
Capitolo III: Principi di estetica fenomenologica: Alfred Schütz: Il capitolo approfondisce i principi dell'estetica fenomenologica di Alfred Schütz, focalizzandosi sulla sua rilevanza per la comprensione del processo creativo e recettivo musicale. L'analisi si concentra sull'esperienza soggettiva dell'ascolto e sulla costruzione del significato nella musica, elementi cruciali per la successiva elaborazione della teoria dei Sonemi. L'importanza di questo capitolo risiede nell'introduzione della prospettiva fenomenologica, che considera il ruolo fondamentale dell'esperienza soggettiva nella comprensione dell'arte.
Capitolo IV: L'approccio ermeneutico di Pareyson: Questo capitolo esplora l'approccio ermeneutico di Luigi Pareyson e la sua applicazione alla musica. Si analizza il ruolo dell'interpretazione nella comprensione dell'opera musicale e il rapporto tra opera d'arte e interprete. L'integrazione dell'ermeneutica pareysoniana nella tesi offre un ulteriore strumento interpretativo per la comprensione e la generazione dei sonemi, sottolineando la natura interpretativa intrinseca alla musica.
Capitolo V: Sinossi concettuale: Questo capitolo offre una sintesi dei concetti chiave discussi nei capitoli precedenti, preparando il terreno per la presentazione della teoria dei Sonemi nei capitoli successivi. Serve da ponte tra la parte teorica e la parte pratica della tesi, integrando le diverse prospettive filosofiche ed estetiche in un quadro concettuale unitario.
Capitolo VI: Esperienze nell'assoluto: Questo capitolo approfondisce il concetto di esperienza musicale "nell'assoluto", esplorando la dimensione trascendente dell'arte musicale e la sua capacità di generare emozioni e significati al di là del linguaggio e della rappresentazione. Questo concetto è fondamentale per comprendere la natura dei sonemi, che mirano a creare un'esperienza musicale intensa e priva di riferimenti extra-musicali diretti.
Capitolo VII: Astrattismo e arte: Questo capitolo esamina il rapporto tra astrattismo e arte musicale, analizzando le forme di espressione astratta nella musica e le loro implicazioni compositive. L'analisi dell'astrattismo fornisce un contesto importante per la comprensione della natura dei sonemi, che, nella loro forma pura, possono essere considerati elementi astratti di base della composizione musicale.
Capitolo VIII: Linguaggi integrali: Questo capitolo si focalizza su concetti di linguaggi integrali nella musica, esplorando diverse tipologie di sistemi compositivi e le loro relazioni con la teoria dei Sonemi. L'analisi dei diversi "linguaggi" prepara il terreno per l'introduzione del linguaggio unico e specifico generato dai sonemi.
Capitolo IX: Linguaggi complessi, Capitolo X: Linguaggi simbolici, Capitolo XI: Linguaggi astratti, Capitolo XII: Linguaggi assoluti: Questi capitoli analizzano diverse tipologie di linguaggi musicali, preparando il terreno per una comprensione più approfondita dei sonemi e del loro potenziale espressivo. L'analisi di queste diverse forme linguistiche evidenzia la complessità e la ricchezza del linguaggio musicale e il ruolo dei sonemi come elementi di base per la costruzione di nuove forme espressive.
Capitolo XIII: Sonemi: Questo capitolo definisce e descrive nel dettaglio il concetto centrale della tesi: i sonemi. Si analizzano le loro caratteristiche, le loro funzioni e le modalità di generazione e utilizzo nella composizione musicale. Questo capitolo rappresenta il culmine della parte teorica della tesi, presentando la struttura e la funzionalità dei sonemi come elementi base della nuova metodologia compositiva.
Capitolo XIV: L'originale musicale: Questo capitolo esplora il concetto di "originale musicale", inteso come opera unica e irripetibile generata attraverso la manipolazione dei sonemi. Si analizzano le implicazioni di questo concetto sulla creazione musicale e il suo significato nel contesto della teoria dei Sonemi. Questo capitolo si concentra sull'aspetto creativo e innovativo della tesi.
Capitolo XV: Tecniche CMAC: OpenMusic e MusicXII: Questo capitolo descrive le tecniche e gli strumenti informatici utilizzati per la realizzazione pratica della teoria dei Sonemi, focalizzandosi su software open-source come OpenMusic e MusicXII. L'analisi degli strumenti tecnologici completa la tesi, mostrando l'applicazione pratica della teoria elaborata.
Schlüsselwörter (Parole chiave)
Teoria dei Sonemi, integralismo musicale, Hanslick, ermeneutica, Pareyson, fenomenologia, Schütz, linguaggio musicale, composizione musicale, originale musicale, CMAC, OpenMusic, MusicXII, astrattismo, linguaggio simbolico.
Domande Frequenti: Teoria dei Sonemi
Che cos'è la "Teoria dei Sonemi"?
La "Teoria dei Sonemi" è una metodologia compositiva originale presentata in questa tesi. Essa integra concetti e tecniche dell'integralismo musicale di Hanslick, dell'ermeneutica di Pareyson e della fenomenologia di Husserl e Schütz per analizzare e definire un nuovo approccio alla creazione musicale.
Quali sono gli obiettivi principali della tesi?
La tesi si propone di analizzare la Teoria dei Sonemi, integrando diverse prospettive filosofiche ed estetiche. Si esamina l'evoluzione del linguaggio musicale post-tonale, il rapporto tra arti e musica nella sua valenza simbolica, e le tecniche di generazione strutturale dei sonemi. Si descrivono anche le tecniche CMAC (Composizione Musicale Assistita dal Computer) per la realizzazione pratica dei sonemi.
Quali autori e teorie sono analizzate nella tesi?
La tesi analizza approfonditamente il pensiero di Eduard Hanslick (integralismo musicale), Luigi Pareyson (ermeneutica) e Alfred Schütz (fenomenologia). Queste teorie forniscono il quadro concettuale per la comprensione e lo sviluppo della Teoria dei Sonemi.
Cosa sono i "Sonemi"?
I Sonemi sono il concetto centrale della tesi. Sono definiti come elementi astratti di base della composizione musicale, generati attraverso processi specifici e utilizzati per creare un'esperienza musicale intensa, spesso priva di riferimenti extra-musicali diretti. Il Capitolo XIII offre una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche e funzionalità.
Che ruolo gioca l'informatica nella Teoria dei Sonemi?
La tesi esplora l'utilizzo di tecniche CMAC (Composizione Musicale Assistita dal Computer) per la realizzazione pratica dei Sonemi. Vengono analizzati software specifici come OpenMusic e MusicXII, mostrando l'applicazione pratica della teoria elaborata.
Quali sono i diversi tipi di linguaggi musicali analizzati?
La tesi analizza diversi linguaggi musicali, tra cui linguaggi integrali, complessi, simbolici, astratti e assoluti. Questa analisi prepara il terreno per una comprensione più approfondita dei sonemi e del loro potenziale espressivo nel contesto di questi diversi linguaggi.
Che cosa si intende per "originale musicale" nel contesto della tesi?
L'"originale musicale" è inteso come un'opera unica e irripetibile, generata attraverso la manipolazione dei sonemi. Questo concetto sottolinea l'aspetto creativo e innovativo della Teoria dei Sonemi e il suo impatto sulla composizione musicale.
Quali sono le parole chiave associate alla tesi?
Le parole chiave principali sono: Teoria dei Sonemi, integralismo musicale, Hanslick, ermeneutica, Pareyson, fenomenologia, Schütz, linguaggio musicale, composizione musicale, originale musicale, CMAC, OpenMusic, MusicXII, astrattismo, linguaggio simbolico.
Come è strutturata la tesi?
La tesi è divisa in quattro parti principali, ciascuna composta da diversi capitoli. La prima parte presenta le basi teoriche, la seconda approfondisce concetti chiave come l'astrattismo e i diversi linguaggi musicali, la terza si concentra sull'"originale musicale" e la quarta descrive le tecniche CMAC utilizzate. Un indice dettagliato dei contenuti è disponibile all'inizio del documento.
- Citation du texte
- Dr. Piero T. de Berardinis (Auteur), 2009, Teoria dei Sonemi, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125326