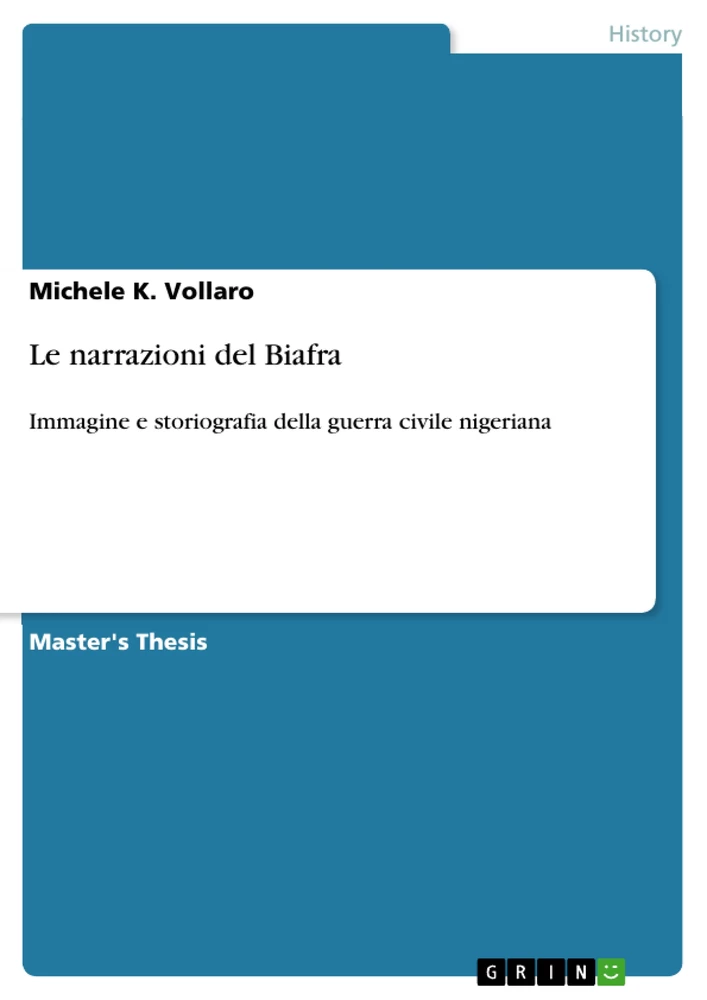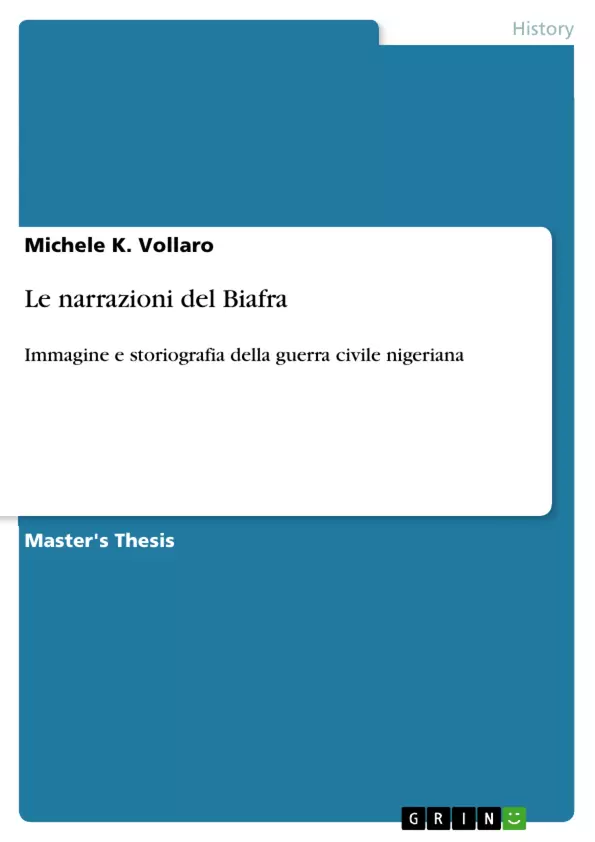Nella tesi di laurea si studia il discorso sul Biafra e la guerra civile nigeriana, intendendo per discorso un certo linguaggio, le istituzioni e la configurazione dei poteri che lo alimentano. Lo scopo è cercare di capire come sia stato interpretato il conflitto e quale sia l'immagine che ne è stata costruita.
Gli eventi della guerra del Biafra compongono una serie di questioni in un solo momento: l’impatto dell’imperialismo, le conseguenze della decolonizzazione, le difficoltà legate alla nascita di una nazione e i processi legati a quella categoria storica chiamata ‘appartenenza etnica’. Ancora, il ruolo dei mezzi d’informazione e la mobilitazione internazionale ‘umanitaria’ a favore dei profughi.
Oggetto principale di questa tesi è osservare come gli eventi della guerra del Biafra siano stati narrati al lettore e allo spettatore occidentale, per valutare come tale costruzione accompagni da allora in poi qualsiasi impressione sulla realtà politica dell’Africa sub-sahariana. Dopo un accenno alla genealogia del sentimento di appartenenza nazionale e alla relatività delle appartenenze etniche nel continente africano prima e dopo le indipendenze, quando si formano continuamente nuove identità regionali e di frontiera che scompaginano schemi e categorie elaborati in epoca coloniale, e una nota introduttiva sugli eventi della guerra civile nigeriana, si analizzeranno le riflessioni degli studiosi dell’accademia, ma anche di operatori dell’informazione e di altri testimoni, per sollevare il problema delle ‘pagine bianche della storiografia’ sulla guerra del Biafra e verificare se, piuttosto che bianche, siano state invece, volontariamente dimenticate dalla memoria collettiva e tralasciate nella discussione pubblica, perché talvolta può risultare più facile – e conveniente – riproporre uno stereotipo abituale che riorientare il senso comune su ciò che è accaduto. Dall’altro lato, inoltre, si vuole comprendere come la guerra civile nigeriana sia stata interpretata dalla storiografia, dai protagonisti e dai nigeriani in particolare, per verificare se e come un evento traumatico della recente storia nazionale sia stato utilizzato ai fini della costruzione di un sentimento di appartenenza comune e della comprensione delle rispettive identità.
Inhaltsverzeichnis (Indice)
:- Introduzione
- I. Il Biafra
- II. La nazione nigeriana
- III. Un nuovo mondo' si presenta agli occhi dell'occidente
- Capitolo 1. Su etnia e nazione in Africa
- I. Il dibattito sull'etnicità e i processi di costruzione identitaria
- II. Etnie e nazionalismo in Nigeria
- Capitolo 2. Sintesi storica
- I. Modelli coloniali in Africa
- II. Dal colonialismo al neo-colonialismo
- III. Verso l'indipendenza
- IV. Il pensiero politico nazionalista
- V. Nasce lo Stato indipendente
- VI. Le crisi elettorali del 1964 e 1965
- VII. Il \"golpe dei cinque maggiori” e il contro-golpe di luglio 1966
- VIII. La crisi istituzionale
- IX. L'ultima occasione: l'incontro di Aburi
- X. Nasce la Repubblica indipendente del Biafra
- XI. Il ruolo e gli interessi delle potenze straniere nella crisi del Biafra
- XII. La guerra civile
- XIII. La comunità internazionale durante la guerra
- Capitolo 3. Le narrazioni del conflitto
- I. Gli \"spettatori\" stranieri
- II. La guerra vista dal “di dentro”
- III. La guerra come tema letterario
- IV. Biafra e guerra civile oggetto della storiografia accademica
- Capitolo 4. Il ruolo dei media nell'internazionalizzazione del conflitto
- Capitolo 5. \"Io c'ero\", testimonianze e memoriali
- I. Da un punto di vista nazionale, nigeriano e biafrano
- II. Da un punto di vista straniero
- III. Dall'Italia in Biafra
- Capitolo 6. La riflessione storiografica
- I. Le diverse ottiche assunte dagli studiosi
- II. La guerra del Biafra alla luce del ruolo della comunità internazionale
- III. La guerra e l'economia: il fattore \"petrolio”
- IV. La fame e la carovana degli aiuti umanitari
- V. Guerra e pace, l'impatto sociale e le conseguenze del Biafra
- VI. Biafra, guerra civile e questione nazionale
- Capitolo 7. La rappresentazione letteraria del conflitto
- Capitolo 8. L'africanistica in Italia e gli studi italiani sul Biafra
- Il ruolo dell'etnicità e del nazionalismo in Africa
- Le narrazioni della guerra del Biafra e le loro implicazioni
- L'impatto dei media e della propaganda sull'opinione pubblica internazionale
- Il ruolo della comunità internazionale durante la guerra
- Le conseguenze sociali ed economiche della guerra civile
- **Introduzione**: Questo capitolo fornisce una panoramica della guerra del Biafra, ponendo l'accento sul disastro umanitario e sulla sua rappresentazione nei media. Introduce anche il contesto storico del conflitto, in particolare l'emergere del panafricanismo e della negritudine.
- **Capitolo 1: Su etnia e nazione in Africa**: Questo capitolo esamina il ruolo dell'etnicità e del nazionalismo nei processi di costruzione identitaria in Africa, concentrandosi sul contesto nigeriano.
- **Capitolo 2: Sintesi storica**: Questo capitolo fornisce una sintesi storica degli eventi che hanno portato alla guerra del Biafra, dal colonialismo al neo-colonialismo, alla crisi politica e alla secessione.
- **Capitolo 3: Le narrazioni del conflitto**: Questo capitolo analizza le diverse narrazioni della guerra del Biafra, comprese quelle degli "spettatori" stranieri, dei testimoni diretti e della letteratura sul conflitto.
- **Capitolo 4: Il ruolo dei media nell'internazionalizzazione del conflitto**: Questo capitolo esamina l'impatto dei media sulla percezione internazionale della guerra, valutando la corrispondenza tra il racconto mediatico, l'opinione pubblica e la politica dei governi.
- **Capitolo 5: "Io c'ero", testimonianze e memoriali**: Questo capitolo analizza i memoriali di chi ha partecipato alla guerra, sia come protagonisti che come osservatori, da un punto di vista nazionale e internazionale.
- **Capitolo 6: La riflessione storiografica**: Questo capitolo esamina le diverse interpretazioni storiche della guerra del Biafra, concentrandosi sul ruolo della comunità internazionale, l'economia, l'impatto sociale e la questione nazionale.
- **Capitolo 7: La rappresentazione letteraria del conflitto**: Questo capitolo analizza come la tragedia del popolo biafrano è stata interpretata e utilizzata nella produzione artistica.
- **Capitolo 8: L'africanistica in Italia e gli studi italiani sul Biafra**: Questo capitolo esamina il contributo dell'africanistica italiana alla comprensione della guerra del Biafra.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Obiettivi e temi principali)
: Questa tesi si propone di esaminare come la guerra del Biafra è stata narrata, dopo aver fornito un contesto storico degli eventi e delle condizioni che hanno portato alla crisi nigeriana. L'obiettivo è comprendere le interpretazioni degli studiosi, confrontando le narrazioni storiche con quelle giornalistiche, memorialistiche e artistiche. Il lavoro indaga sulle fonti mediatiche e memorialistiche in relazione alle analisi critiche degli studiosi. I temi principali della tesi includono:Zusammenfassung der Kapitel (Sommario dei capitoli)
:Schlüsselwörter (Parole chiave)
: La tesi si concentra sui temi della guerra civile nigeriana, del Biafra, del ruolo dell'etnicità e del nazionalismo, della narrazione e dell'interpretazione storica, dell'impatto dei media, della propaganda e della memoria. Altri concetti chiave includono il panafricanismo, la negritudine, le potenze straniere, la crisi umanitaria, il ruolo della comunità internazionale e l'impatto sociale ed economico del conflitto.- Citar trabajo
- Michele K. Vollaro (Autor), 2011, Le narrazioni del Biafra, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193374