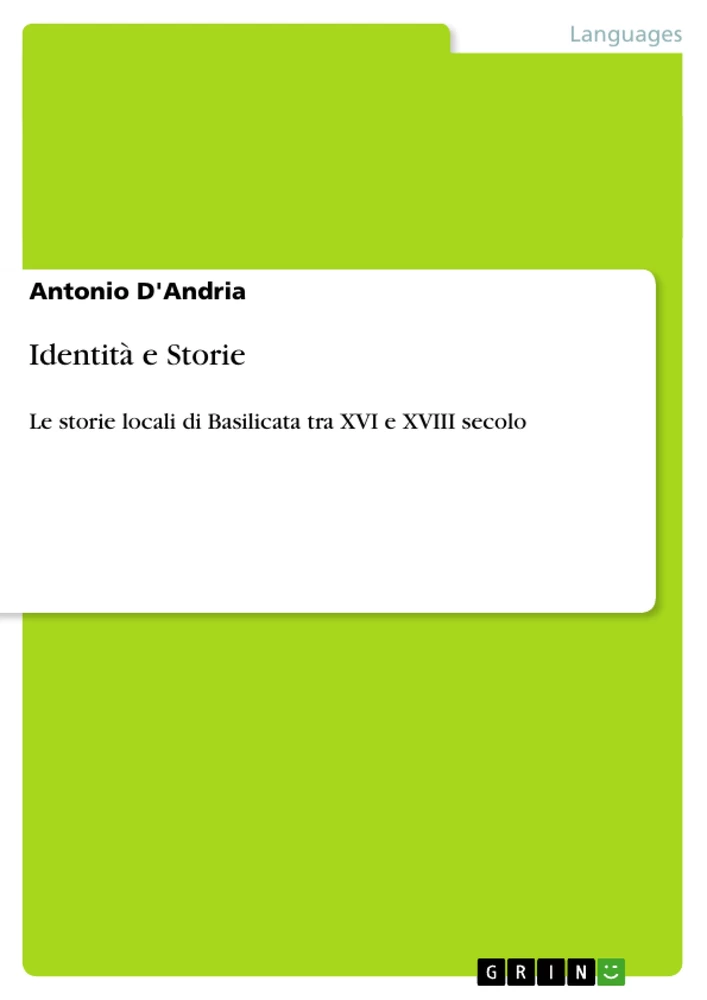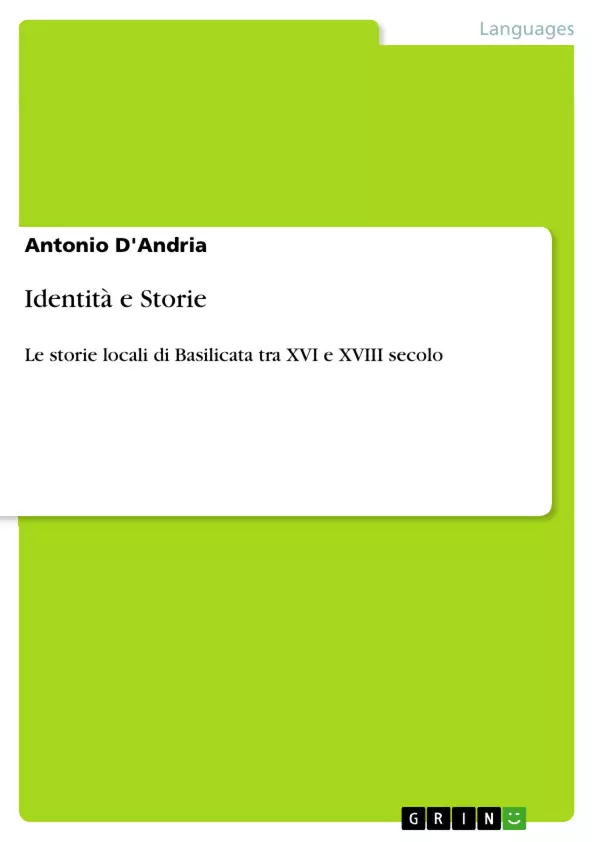This volume offers a survey about a case study in local italian modern historiography, Indeed, historians of Basilicata between XVIth and XVIIIth century, if we look ate their work with scientific criteria, are likely to appear inconsistent and obvious examples of dilettantism, with cuts, misunderstandings of the sources, insertion of authorities invented or nonexistent, failure to find primary sources or lack of verification of those availables. All this entries, however, do not concern exclusively one or more historians in particular: it is, more than anything else, a relief advanced by scholars at the whole historiography of the Kingdom of Naples of the modern age.
However, these obvious flaws were offset by a constant attention to insert the mosaic of sources in a continuous narrative, or at least chronologically uniform, designed to leave no gray areas in the "biography" of the community, by "patriotic" intention to the old memories with constant use of humanistic scholarship, not to mention the numerous references to deserving nobles who take charge of preserving and restoring precious relics of the past, and finally, by a principle that recurs several times in the course of the thriving southern historiographical production and which was inaugurated by the leader of the southern baroque historiography, Giovanni Antonio Summonte, in his History of the City and Kingdom of Naples, the greater value of the authorities closest to the facts narrated.
And, above all, in these historic remained, alive and constant concern of the "mirror of power," that is, the need for self-representation for use by the central government, emphasizing, therefore, the hand on the titles of antiquity and nobility that Naples itself had offered.
Indice
1. Metodi, meriti, contesti
2. Il caso della Basilicata
3. La Basilicata tra descrittori ed eruditi
4. Il “caso Cenna”
5. Provenienze professionali, ricezione ed uso dell’antico
Appendice
Abbreviazioni
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Metodi, meriti, contesti
Ampio spazio è stato dedicato, negli studi più recenti, alla questione della rappresentazione e dell’autorappresentazione delle comunità del Regno di Napoli, divisa tra “letteratura” – quella della storiografia locale – e “visibile parlare” – quello delle dimore signorili. Si tratta, in effetti, di un altalenante equilibrio tra modalità comunicative visibili a tutti e modalità di comunicazione verso l’esterno.
Nel caso delle dimore signorili, ciò che si intendeva mostrare era, tra l’altro, la forma urbis o, quantomeno, la forma che nelle intenzioni dei poteri locali si voleva mostrare alla comunità, laddove, nel caso delle storie cittadine, il rapporto comunicativo non si limitava alla comunità, ma all’autorappresentazione esterna, quella che si potrebbe definire come una sorta di forma mentis, verso la Capitale, ovviamente basata su strumenti, per così dire, più “metodologici”, utilizzati dai diversi storici per ottenerla, nell’ottica, sempre, di un costante riferimento alla cultura ed all’immagine di sé che la comunità aveva.
In quest’ottica, ponendo più insistita attenzione alle funzioni cittadine, si è evidenziata, negli ultimi anni, la necessità di uno studio della percezione di sé all’interno e verso Napoli per le realtà urbane del Mezzogiorno d’Italia di media e piccola dimensione. Solo negli ultimi anni si è andata sempre più robustamente affermando una fruttuosa produzione anche rispetto a percorsi relativi a realtà urbane con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, ma con incisive funzioni, a livello politico-istituzionale e socio-culturale.
Con la sua frammentazione in città medie e piccole, ogni provincia del Regno mostrava un carattere di microsistema chiuso, in cui anche le opere storiografiche, pur nel consueto uso dei topoi eruditi e mitologici, miravano al fine pragmatico di "protezione" della tradizionale costituzione, in una rigida chiusura verso gli interscambi politici con Napoli e con le altre città. Si evidenziarono realtà articolate, marginali dal punto di vista politico, tenacemente legate all'autolegittimazione, ma d'altro canto indagate da storici di influenza e formazione politica o teologica, quindi provenienti dai due poli fondamentali di Napoli e Roma e saldamente formatisi alla scuola degli studia humanitatis.
Chiaramente, sarebbe antistorico pretendere dagli storici locali dei secoli xvi-xviii un metodo moderno, fondato su un esame approfondito delle fonti primarie, oltre ad un’analisi ctica delle opere dei predecessori: sotto questo aspetto, gli storici locali procedevano in modo dilettantesco, il più delle volte per incapacità effettiva o per impossibilità di accedere ai dati d’archivio.
Del resto, molte opere, se esaminate con tali criteri, rischiano di apparire inconsistenti ed evidenti esempi di questo dilettantismo, con tagli, voluti o dovuti a fraintendimento delle fonti, inserimento di autorità inventate o inesistenti, mancata ricerca di fonti primarie o scarsa verifica di quelle reperibili. Tutte annotazioni che non riguardano in maniera esclusiva uno o più storici in particolare: si tratta, più che altro, di rilievi avanzati dagli studiosi all’indirizzo di tutta la storiografia del Regno d’età moderna.
Tuttavia, queste evidenti pecche furono compensate da una costante attenzione ad inserire il mosaico delle fonti in una narrazione continua, o quantomeno cronologicamente uniforme, atta a non lasciare zone d’ombra nella “biografia” della comunità; da un’intenzione “patriottica” verso le antiche memorie, con uso costante dell’erudizione umanistica, senza tralasciare i numerosi riferimenti a meritevoli patrizi che si facessero carico di custodire e restaurare preziose reliquie del passato; infine, da un principio che ricorre più volte nel corso della fiorente produzione storiografica meridionale e che era stato inaugurato dal caposcuola della storiografia barocca meridionale, Giovanni Antonio Summonte, nella sua Historia della Città, e Regno di Napoli, quello della maggiore valenza delle autorità più vicine ai fatti narrati[1] .
E, soprattutto, in questi storici permaneva, viva e costante, la preoccupazione dello “specchio del potere”, ossia la necessità di autorappresentazione ad uso del potere centrale, calcando, dunque, la mano sui titoli di antichità e nobiltà che Napoli stessa aveva offerto alla Corona spagnola con l’archeologia di Summonte, origine e fonte di questa tendenza.
In tale direzione, proprio esaminando le fondamentali archeologie cittadine, va riformulata, per il Regno di Napoli e la sua vasta produzione storiografica l’affermazione secondo la quale la cultura del nostro Rinascimento fosse essenzialmente latina, che ogni genere letterario di derivazione classica non risalisse all’originale greco, ma si fosse sviluppato in modo più o meno stabile grazie alla mediazione di Roma[2] . Tuttavia, questa semplificazione appare oggi, ad un esame approfondito della circolazione dei classici nell’intera penisola, appunto come una riduzione dell’Umanesimo e del Rinascimento ad una sorta di “secondo medioevo”, in cui la dipendenza dalla mediazione latina degli originali greci non cambiava assolutamente se non a livello quantitativo, poiché sembrerebbe che i letterati rinascimentali, pur conoscendo le opere greche, non se ne servissero se non tramite le loro rielaborazioni latine. Questo è in parte vero nel caso dei numerosi volgarizzamenti, soprattutto dagli storici greci, operati nel corso del Quattrocento e del primo Cinquecento, che ebbero, tuttavia, il merito di far circolare in una più larga fascia d’utenza temi e forme espositive altrimenti confinate ai letterati o agli eruditi. Con la mediazione latina, dunque, generi e temi greci, quindi le fontes originali, si diffusero come patrimonio comune dell’ élite culturale e nobiliare italiana. Naturale, dunque, che una citazione da un classico, anche se non esplicitata, fosse avvertita come tale dal lettore colto ma anche dal pubblico con un bagaglio di nozioni risalenti a questa fondamentale mediazione dei volgarizzamenti.
Piuttosto evidente, inoltre, è l’apparente passività verso le numerose fonti a disposizione, in quanto spesso si tagliavano i testi cui si attingeva, alterandone il senso, ci si ripeteva con evidenti contraddizioni tra una sezione e l'altra e, ben più grave, si inventavano le fonti che vanno a confermare quanto si sta narrando. Esempi di queste manchevolezze sono facilmente reperibili nel caposcuola della “nuova” storiografia del Regno, Giovanni Antonio Summonte, fin dalle prime pagine dell'archeologia della sua Historia, come quando parlava di Virgilio console di Napoli ed autore, come tale, della “grotta di Posillipo”[3] . La leggenda di un Virgilio console e mago illustre era d’origine medievale[4] , com’è noto, e venne accolta passivamente dal Summonte come fonte fededegna, così come l’affermazione, egualmente leggendaria, secondo la quale l’imperatore Tiberio «propose in Senato che Cristo fusse riverito, come Iddio»[5] . Pure e semplici tradizioni nate da incomprensioni popolari dei testi, dunque, volontà medievali di “provvidenzializzare” figure importanti nella storia di Roma vennero, altresì, passivamente recepite dagli epigoni di Summonte ed inserite nella narrazione come eventi reali.
Dunque, si potrebbe certamente parlare di storici “dilettanti” per tutta la storiografia del Regno di Napoli in età moderna. Ma fu altresì un pregio evidente della storiografia locale aver mantenuto il principio summontiano dell’utilizzo di una fonte cui rifarsi in maniera massiccia per la sezione di volta in volta prescelta. Così, spesso, Summonte aveva posto a fondamento ed a proemio di una data sezione la versione di un determinato autore che citava esplicitamente come autorità guida per il periodo che sta trattando. Il criterio di scelta era dato soprattutto dalla vicinanza della fonte in questione agli eventi narrati o, nel caso di contemporanei, al fatto che l’opera prescelta fosse ormai di fatto un “classico” nel suo genere, per autorevolezza o diffusione tra il pubblico.
La notevole produzione storiografica del Regno di Napoli lungo l’età moderna solleva, allo stato, numerose questioni[6] . Attraverso il tentativo di costruzione dell’identità comunitaria, gli storiografi cercarono di evidenziare, grazie agli strumenti ‘metodologici’ e alle informazioni derivanti dall’antico, una relazione di nessi con l’identità della «nazione napoletana». La prospettiva totalizzante della storia sacra e i diversi generi della storiografia, nonostante un’apparente separazione, si univano nella ricerca di una memoria comune, quella dei caratteri politici, civili, persino morali delle città del Mezzogiorno d’Italia.
La «pluralizzazione della memoria»[7] attraverso i fondatori umani, gli eroi mitici, i santi patroni cercava, nell’ambito della differenziazione sociale e politica dell’età moderna, una traccia comune tramite la riscoperta delle origini antiche (classiche e bibliche), grazie ad uno spazio comune di comunicazione quale quello aperto dall’uso della stampa. Un percorso fecondo di suggestioni, ancora da esplorare per ricostruire la varietà, nell’unità «nazionale» del Regno, della costruzione del sentimento politico identitario lungo il ciclo della modernità:
in questa letteratura si afferma anche un nuovo linguaggio politico che affonda le sue radici nei miti e nelle metafore degli autori classici; un linguaggio solo apparentemente vecchio, ma che in realtà è soggetto ad una rapida rivoluzione semantica e ad un continuo cambiamento tra le parole e le cose. […] L’analisi filologica demolisce i tasselli di un quadro del mondo costruito sulla base comune della lingua adamitica, si comincia cioè a promuovere una riflessione articolata sulla politica. S’istituisce tra lingua e politica un nesso su cui si radicano gli elementi fondativi del discorso politico moderno[8] .
2. Il caso della Basilicata
La storiografia locale, dunque, può essere considerata come complesso prodotto della circolazione di modelli culturali e politici imperniati sul carattere della discussione e dell’identità. Il mito e le sue innumerevoli varianti, infatti, la narrazione delle glorie classiche rispecchiavano, nella coscienza cittadina, i punti più reconditi, i caratteri originari della comunità. Ricostruire minutamente la figura di Partenope o, ad esempio, per vari centri della Capitanata, far derivare le proprie origini da Diomede o ancora, spingendosi più in alto nella cronologia, nel peculiare caso siciliano, risalire alla fondazione noachica voleva indicare una coscienza morale di quello che era il fondamento della vita associata in una determinata comunità, che veniva nobilitata dall’antichità del fondatore e portava nel proprio codice genetico virtù civili e sociali già presenti nella figura dell’ecista e poi rispecchiate negli eventi e nelle glorie locali d’età classica. Furono queste le basi della “mitologia cittadina” delle storie locali tra Seicento e Settecento[9] , un microcosmo ricco di generi e di personalità variegate, espressione del radicamento sul territorio di gruppi dirigenti locali e della loro cultura. Il che, del resto, emerge anche solo considerando la notevole quantità dei prodotti storiografici espressi da ciascuna provincia del Regno:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafico 1. Produzione storiografica nelle province del Regno di Napoli tra xvii e xviii secolo[10] .
Nel più generale contesto del Regno, un esempio notevole di generi e problemi derivanti dalla scrittura di storia nei variegati contesti locali può essere rappresentato dalla produzione storiografica in Basilicata.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafico 2. Produzione storiografica di Basilicata tra xvi e xviii secolo.
In primo luogo, tale produzione, piuttosto notevole, come risulta dal grafico 2, impone alcuni problemi di metodo. Non risulta, infatti, produttivo esaminare le storie locali di Basilicata solo secondo la tradizionale trattazione diacronica[11] , che rischia di appiattire generi, problemi e questioni legate alla provenienza socio-culturale dei diversi storici, nonché obiettivi e metodi adottati dalla storiografia nei diversi centri della provincia, del resto peculiare anche per l’intreccio, sul versante istituzionale, di Università, Feudo e Chiesa che, spesso in concorrenza tra loro, furono i tre fondamentali livelli che di fatto esprimevano l’amministrazione del potere locale[12] , tramite conflitti, ma anche forti intrecci. Un connotato, questo, che, in alcuni centri, tra i quali Matera, Venosa, Potenza assunse dimensioni e forme di esercizio concreto ancora più particolari e alquanto significativi rispetto al contesto circostante.
In tale orizzonte, dunque, senza prescindere dai quadri sistemici e dalla necessaria comparazione con altre realtà finitime, la storiografia di Basilicata appare meglio inquadrata nel più generale contesto del Regno di Napoli allorquando si vadano ad esaminarne le questioni più attinenti a quanto finora si è detto.
Le domande, in questa sede, da porsi nell’analisi delle storie locali basilicatesi, dunque, sono almeno due:
a. Come e in che misura la scrittura di storia sia andata diversificandosi sul territorio di Basilicata, in rapporto a contesti socio-economico-istituzionali quali la Chiesa, il potere feudale e il governo dell’Università.
b. Quali fossero le modalità di ricezione ed uso dell’antico nella costruzione dell’immagine della comunità, a livello di riutilizzo retorico-comunicativo ed a livello simbolico.
I centri più rappresentati e le tipologie storiografiche
Alcuni esempi possono chiarire in che rapporto le storie locali di Basilicata andassero a contribuire al dibattito politico sul territorio, come espressione di gruppi dirigenti direttamente impegnati nella sua gestione. Matera, Venosa, Pisticci, Potenza, tra gli altri, risultano evidenti espressioni dei rapporti delle élites locali con i relativi perni del sistema di potere: Chiesa, Feudalità, Università.
i. Matera
Quello materano risulta sicuramente il più evidente caso di storiografia mirata ad una diretta e autorappresentativa percezione politica dei gruppi dirigenti locali. Nella città, infatti, gli esponenti del patriziato urbano furono sempre attivamente partecipi della complessa dinamica sociale che, nella città dei Sassi, coinvolse nobili e popolo fin dal Cinquecento[13] . I patrizi, tesi a limitare in ogni modo l’accesso alle massime cariche cittadine da parte della borghesia professionale - che mirava al seggio dei nobili ex privilegio -, si interessarono in prima persona a rappresentare la città stretta intorno al governo nobiliare, onde meglio consolidare, soprattutto dopo l’elevazione della città a sede di Regia Udienza[14] , il proprio ruolo politico. Notevole, quindi, quest’uso della storia per rafforzare un’identità cetuale, del resto poco rilevata in altri centri della provincia, come nel caso, a fine Settecento, delle Notizie sulla Città e cittadini di Matera di Arcangelo Copeti[15] .
Ulteriore stimolo alla storiografia cittadina materana fu la solida presenza della Chiesa, che rappresentava uno degli anelli istituzionali più forti, sia sul piano politico, che su quello economico. Già alla fine del xvi secolo, Matera aveva cercato di ottenere che la diocesi di Acerenza le fosse suffraganea, essendo già dal Duecento sede arcivescovile di dignità pari ad essa - pur se la città bradanica continuava ad essere centro amministrativo della metropolia ed all’arcivescovo acheruntino era concesso il privilegio di decidere le variazioni di numero del collegio dei canonici delle città suffraganee, di effettuare periodicamente visite pastorali e di indire concili provinciali[16] -. La rivalità tra le due sedi era acuita dal fatto che il vescovo avesse la possibilità di trascorrere il periodo estivo nella sede di Acerenza e quello invernale nella sede di Matera, dove il clima era più mite[17] . Numerose polemiche erano seguite nel Seicento quando i materani chiesero che Acerenza fosse dichiarata suffraganea di Matera, portando, nel 1624 e nel 1627, il napoletano Fabrizio Antinori a celebrare un sinodo (il primo della diocesi) a Miglionico[18] , il 4 novembre 1624, significativamente spostando la riunione nel centro del Materano e non, come il De Rossi, a Matera, probabilmente per frenare le polemiche sulle prerogative delle due Chiese. Certo è che la vita delle diocesi di Matera e Acerenza fu caratterizzata da una costante contrapposizione tra i due capitoli, in relazione alle prerogative spettanti ad Acerenza come unica sede per la residenza dell’arcivescovo e come unica beneficiaria del titolo di arcidiocesi, oltre che in merito alla giurisdizione delle «terre di Basso», vale a dire dei centri della diocesi collocati geograficamente nella parte bassa della diocesi stessa. Tale contrasto è ampiamente documentato da lettere, memoriali, copie di sentenze in entrambi gli archivi diocesani, che coprono un arco cronologico dal 1588 al xx secolo.
Espressione di tali intrecci derivanti dalla solida, congiunta, presenza della maggiori famiglie cittadine nella proficua gestione del governo della città e del Capitolo cattedrale[19] , furono la Cronica de la Città di Matera del patrizio Eustachio Verricelli (1596) e la Cronaca di Matera di Gianfrancesco De Blasiis (1635); nel Settecento, la Cronologia istorica della Città di Matera tradotta da varie scritture antiche di Domenico Appio (1704), appartenente ad una delle famiglie che vivevano more nobilium, nonché la Cronaca di Matera sino al 1711 con appendice di notizie appartenenti alla Città di Matera raccolte da diversi autori del canonico Donato Venusio (1711).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
La Cronologia della Città di Matera di Gianfrancesco De Blasiis.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
La Cronaca di Matera di Donato Venusio.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Le Memorie Storiche di Francesco Paolo Volpe
ii. Venosa
Se Matera espresse la propria ricerca di un rafforzamento identitario marcando una netta distinzione tra nobiltà e popolo, in un’ottica in cui anche la storia ecclesiastica della città diveniva strumento di avallo dei privilegi economico-istituzionali del patriziato, tale ricerca ricorse anche nella produzione venosina che, sebbene meno marcata, evidenzia la vitalità della città a cavaliere tra Cinquecento e Seicento, alla ricerca, questa volta, di una netta distinzione dal potere ecclesiastico, data dalla politica di una città essenzialmente feudale.
L’accorta politica di potenza dei Gesualdo, infatti, sostanzialmente autonomi dai dettami controriformisti, aveva avviato un processo di ristrutturazione di Venosa su basi culturali decisamente laiche[20] , uno dei cui prodotti di maggior rilievo storiografico fu l’ibrida descrizione, a metà, appunto, tra descriptio urbis e storia cittadina, del primicerio Achille Cappellano[21] . A partire dal 1590, dopo l’uxoricidio commesso da Carlo, figlio di Fabrizio Gesualdo, contro la moglie Maria, la politica della famiglia aveva subito una battuta d’arresto, ripresa solo nel 1612, quando Emanuele Gesualdo, figlio di Carlo, avrebbe rifondato l’Accademia dei Piacevoli, creata dal nonno, con il nome di Accademia dei Rinascenti, con la collaborazione dell’erudito Giacomo Cenna, che a tale iniziativa avrebbe significativamente dedicato l’ultima, cospicua sezione della sua Cronaca [22] . Sennonché, l’estinzione della famiglia, nel 1613, portò, a Venosa, ad un passaggio feudale dai Gesualdo ai Ludovisi, decisamente poco inclini a proseguire la politica dei loro predecessori[23] , lasciando campo libero alla grandeur ecclesiastica del vescovo Andrea Perbenedetti che, nell’ambito di una politica di riappropriazione simbolica e materiale del territorio, commissionò allo stesso Cenna una storia di Venosa[24] .
Una ripresa d’attenzione per Venosa si ebbe, nella seconda metà del xviii secolo, in concomitanza con l’interesse antiquario per le province che aveva già dato i suoi frutti nell’ampia messe di studi dedicati a Saponara e alle iscrizioni dell’antica Grumentum: non è un caso che le caratteristiche “cittadine” della storiografia venosina assumessero carattere spiccatamente antiquario, con le poderose monografie del Cimaglia e del Lupoli[25] . Il primo, nelle sue Antiquitates Venusinae in tre libri, si occupò essenzialmente di ricostruire fondazione, territorio e magistrature dell’antica città romana (libro i), vicende storiche, riti e monumenti romani (libro ii) e, infine, le vicende della città tra età imperiale e medioevo (libro iii), implicitamente seguendo il modello di legittimazione giuridico-storica dell’autonomia del governo cittadino estendendo l’antico anche alle vicende medievali. Il secondo, nel suo Iter Venusinum, riprese la forma para-storiografica della lettera-itinerario erudito[26] aggiungendo al modello di Cimaglia anche dissertazioni altrettanto impostate sul recupero identitario tra antichità ed età medievale. In tale filone si situò anche, all’inizio degli anni Novanta del Settecento, la Storia Grumentina di Francesco Saverio Roselli[27] , tuttavia ben più interessante, ai fini della ricostruzione dei contesti e degli assetti urbanistici della Saponara tardo-settecentesca, descritta nella breve sezione finale dell’opera.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
La Storia Grumentina di Francesco Saverio Roselli.
iii. Pisticci
Relativamente al centro ionico di Pisticci, un primo esempio di storiografia cittadina, seppure in nuce, è rappresentato dal Liber Niger Pisticii, compilato nel 1567 dal dottore in utroque jure Andrea Marzio[28] . Pur limitato ad una raccolta di documenti, il Liber Niger appare espressione di una volontà autonomista contro il potere feudale dei Sanseverino, che si limitarono a governare ‘da lontano’ i propri, estesissimi, feudi e ad imporre tasse e la presenza del proprio rappresentante in seno al locale governo cittadino[29] . Infatti, nonostante una topica pagina di dichiarazione di fedeltà al sovrano, in cui fondazione della città e carattere fidelistico si congiungevano, il Liber venne compilato per dimostrare, attraverso la puntigliosa ricostruzione di statuti, privilegi e grazie concessi alla città, nonché attraverso un’embrionale ‘cronotassi dei sindaci’, l’autonomia e la continuità del governo cittadino nei rapporti con il potere dominante. In tale ambito, assai più interessante risulta la Memoria del notaio pisticcese Paolo D'Avenia[30] , una cronaca cittadina d’impianto annalistico. L’autore, di orientamento moderato e conservatore, compose la propria cronaca sulle vicende di Pisticci durante e dopo le gravissime crisi che colpirono il Regno e la Basilicata nel secondo Seicento: la grande rivolta del 1647-48[31] , la peste del 1656, la carestia del 1673-74 e, in particolare per Pisticci, un moto popolare del 1677. Una visuale privilegiata, questa, per comprendere dinamiche socio-politiche dei centri di Basilicata tra Cinque e Seicento e i riflessi degli eventi generali sulla periferia del Viceregno.
[...]
[1] Cfr., ad esempio, G. A. Summonte, Historia della Città, e Regno di Napoli, Napoli 1748, t. II, iii 1, p. 234.
[2] E. Howald, La cultura dell’età antica, Milano, Garzanti, 1967, p. 117; G. Pasquali, Pagine stravaganti, Firenze, Le Lettere, 1994, ii, pp. 341-370.
[3] G. A. Summonte, Historia della Città, e Regno di Napoli, Napoli, Gessari, 1748, t. II, ii 1, p. 11.
[4] A partire, ovviamente, dalla Cronica di Partenope, che era qui fonte principale di Summonte, che ne riprendeva i primi 57 capitoli. Cfr. anche, in ambito del tutto diverso, B. Aliprandi, Aliprandina o «Cronica di Mantua», in RIS 2, xxiv, 1910, p. 13. Sul tema medievale della sapienza “magica” di Virgilio nel Medioevo, cfr. il fondamentale studio di D. Comparetti, Virgilio nel Medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1940, in special modo parte ii, cap. ix.
[5] G. A. Summonte, Historia…, cit., t. II, i 1, p. 12. Il tema di Tiberio conscio della divinità di Cristo era strettamente legato alla leggenda apocrifa della morte di Pilato: cfr. l’anonima Mors Pilati qui Iesum condemnavit, in C. Tischendorf, Evangelia apochrypha, Leipzig, H. Mendelssohn, 1876.
[6] Sulla ridefinizione del ruolo della storiografia locale, cfr. A. Musi, Introduzione, in Id. (a cura di), Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno, Napoli, ESI, 1991, p. 9.
[7] A. Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 52-53.
[8] G. Cirillo, “Generi” contaminati..., cit., p. 200.
[9] A. Musi, Storie “nazionali” e storie locali, cit., pp. 20-21.
[10] Nostra elaborazione dal cd-Rom Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2006, prodotto scientifico del programma interuniversitario (Cofin 2001) Le storie locali dei Regni di Napoli e Sicilia nei secoli xvi e xviii, coordinato dal prof. Antonio Lerra, al quale hanno partecipato il Dipartimento di Scienze storiche, linguistiche e antropologiche dell'Università degli Studi della Basilicata (responsabile scientifico prof. Antonio Lerra), il Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni Giuridiche e Politiche nella Società moderna e contemporanea dell'Università degli Studi di Salerno (responsabile scientifico prof. Aurelio Musi) ed il Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell'Università degli Studi di Teramo (responsabile scientifico prof. Francesco Benigno). Si avverte che i dati dai grafici seguenti provengono dalla stessa fonte.
[11] Tale modello è rappresentato da T. Pedio, Storia della storiografia lucana, Venosa, Osanna, 1984, che pure ha avuto il merito di aver richiamato (l’edizione originale è del 1964) l’attenzione sulla complessiva produzione storiografica nella Basilicata, nell’articolazione dei diversi centri basilicatesi. Nel presente lavoro, che è solo parte di un percorso di studio e di ricerca più ampio, l’arco temporale considerato è compreso tra il tardo xvi secolo e l’età napoleonica, con riferimenti, quindi, anche a centri come Vietri e Saponara, che non rientravano nella provincia di Basilicata.
[12] R. Giura Longo , La Basilicata dal xiii al xviii secolo, in Storia del Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vi, Le province del Mezzogiorno, Napoli, Edizioni del Sole, 1987, p. 384.
[13] M. Morano, Fazioni civiche e lotte sociali a Matera nel xvi secolo, in A. Musi (a cura di), Le città del Mezzogiorno in età moderna, Napoli, ESI, 2000, pp. 270 ss.
[14] Cfr. G. Intorcia, I problemi del governo provinciale: l’Udienza di Basilicata nel Seicento, in «ASPN», cii (1984), pp. 152 ss.; T. Pedio, La R. Udienza Provinciale di Basilicata dalla sua istituzione alla scelta della sua sede a Matera (1642-1663), in «BSB», vii (1991), n. 7, pp. 249 ss.
[15] A. Copeti, Notizie della città e di cittadini di Matera, ms., 1780, conservato nel Museo «D. Ridola», Matera (Notizie della città e di cittadini di Matera, a cura di Mauro Padula e Domenico Passarelli, Matera, BMG, 1982).
[16] C. D. Fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche dal tardo antico al tardo Medioevo, in Storia della Basilicata, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, 2. Il Medioevo, a cura di C. D. Fonseca, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 286-288.
[17] Ivi, pp. 286-287.
[18] G. M. Viscardi, I sinodi, in Storia della Basilicata, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, 3. L’Età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 261.
[19] Si consideri solo che, ancora nel xviii secolo, i due terzi dell’agro materano erano controllati dalla Chiesa. Cfr. R. Giura Longo, Clero e borghesia nella campagna meridionale, Matera, Basilicata, 1967, pp. 183-184.
[20] A. Capano, Venosa e i suoi feudatari. Note storiche, in «Radici. Rivista Lucana di Storia e Cultura del Vulture», ii (1990), n. 6, pp. 139-159.
[21] Discrittione della città di Venosa, sito et qualità di essa (28 Febbraio 1584), ms., conservato nella Biblioteca Casanatense, Roma (a cura di R. Nigro, Venosa, Osanna, 19852).
[22] G. Cenna, Cronaca Venosina (tra il 1614 e il 1640), a cura di G. Pinto, Trani, Vecchi, 1902. Cfr. F. Tateo, La cultura letteraria, in Storia della Basilicata, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, 2. Il Medioevo, cit., pp. 991-992.
[23] Cfr. R. Colapietra, Profilo storico dei principali centri urbani, in Storia della Basilicata, a cura di G. De Rosa e A. Cestaro, 3. L’Età moderna, cit., pp. 38-40.
[24] Su alcuni aspetti della Cronaca del Cenna, cfr. A. D’Andria, «Dell’antiquità e nobiltà di Venosa». Intorno alla Cronaca Venosina di Giacomo Cenna, in «BSB», xxiv (2008), n. 24, pp. 209-222.
[25] N. M. Cimaglia, Antiquitates Venusinae. Tribus libris explicatae. Asculanensium antiquitates et Dauniae Apuliaeque veteris geographia, Napoli, Josephi Raymundi, 1757; M. A. Lupoli, Iter Venusinum vetustis monumentis illustratum. Accedunt varii argumenti dissertationes, Neapoli, apud Simonios, 1793 (Iter Venusinum, trad. di N. Pasquale e M. Gallo, Venosa, Appia2, 1992).
[26] Già in G. Castelli, Epistula Jacobi Castelli Neapolitani ad eruditissimum virum Io: Bernardinum Tafuri, in A. Calogerà, Raccolta di Opuscoli scientifici, e storici, Venezia, appresso Cristoforo Zane, 1735, xii, pp. 507-525 che, in forma di itinerario, forniva circostanziati ragguagli su storia e usi di diverse comunità della bassa Val d’Agri e del Lagonegrese.
[27] F. S. Roselli, Storia Grumentina, s.l., s.e., 1790.
[28] A. Martii, Libro Negro della Terra di Pisticci, a cura di C. Spani, Roma, Luigi Spani, 1988.
[29] Cfr. R. Giura Longo, La Basilicata.. ., cit., pp. 353-356.
[30] P. D’Avenia, La caduta e la rovina della Terra di Pisticcio nostra Patria e nuova edificazione di essa (1677), in N. Jeno de' Coronei (a cura di), Sinodo Materese del 1578, Roma, Tip. D. De Falco, 1880, pp. 108-123.
Domande frequenti
Di cosa tratta questo documento?
Questo documento presenta un'anteprima di un'opera che analizza la storiografia locale nel Regno di Napoli, con particolare attenzione alla Basilicata, durante l'età moderna (XVI-XVIII secolo). Esplora i metodi, i meriti, i contesti e le figure chiave coinvolte nella scrittura di storia locale, nonché le modalità di ricezione e uso dell'antico nella costruzione dell'identità comunitaria.
Quali sono i principali temi trattati?
I principali temi trattati includono:
- Metodi e limiti della storiografia locale del XVI-XVIII secolo
- Il ruolo della storiografia locale nella costruzione dell'identità comunitaria
- L'influenza del potere centrale (Napoli) e della cultura umanistica sulla storiografia locale
- L'importanza della ricezione e dell'uso dell'antico (classico e biblico) nella costruzione dell'immagine della comunità
- L'intreccio tra Chiesa, Feudo e Università nell'amministrazione del potere locale in Basilicata
Qual è il focus sulla Basilicata?
Il documento si concentra sulla Basilicata come caso di studio per analizzare la storiografia locale nel Regno di Napoli. Esamina la produzione storiografica di diversi centri della Basilicata (Matera, Venosa, Pisticci, Potenza, ecc.) e come questa riflette i rapporti delle élite locali con i relativi perni del sistema di potere (Chiesa, Feudalità, Università). In particolare vengono citate le storie locali della Basilicata con dei grafici che esplicitano il numero di storie locali scritte tra il XVI e XVIII secolo.
Quali sono alcuni esempi specifici menzionati?
Il documento cita diverse opere e figure chiave, tra cui:
- Giovanni Antonio Summonte e la sua Historia della Città, e Regno di Napoli
- Le Croniche di Matera di Eustachio Verricelli, Gianfrancesco De Blasiis, Domenico Appio e Donato Venusio
- La descrizione di Venosa di Achille Cappellano
- La Cronaca Venosina di Giacomo Cenna
- Le opere antiquarie di Nicola Maria Cimaglia e Marco Antonio Lupoli su Venosa
- Il Liber Niger Pisticii di Andrea Marzio e la Memoria di Paolo D'Avenia su Pisticci
Qual è il significato della "forma urbis" e della "forma mentis"?
La "forma urbis" si riferisce alla rappresentazione visibile della città, in particolare attraverso le dimore signorili, che mirava a mostrare la forma desiderata della città alla comunità. La "forma mentis" si riferisce all'autorappresentazione esterna della comunità, una sorta di immagine che la comunità voleva proiettare verso la capitale (Napoli), basata su strumenti metodologici utilizzati dagli storici locali.
Qual è il ruolo della "mitologia cittadina"?
La "mitologia cittadina" si riferisce alla narrazione delle glorie classiche e dei miti fondativi che rispecchiavano, nella coscienza cittadina, i punti più reconditi e i caratteri originari della comunità. Ricostruire la figura di Partenope o far derivare le proprie origini da Diomede serviva a nobilitare la comunità e a sottolineare le virtù civili e sociali presenti fin dalla fondazione.
Cosa si intende per "pluralizzazione della memoria"?
"Pluralizzazione della memoria" si riferisce al processo attraverso il quale i fondatori umani, gli eroi mitici e i santi patroni cercavano, nell'ambito della differenziazione sociale e politica dell'età moderna, una traccia comune tramite la riscoperta delle origini antiche (classiche e bibliche), grazie ad uno spazio comune di comunicazione quale quello aperto dall'uso della stampa.
- Citar trabajo
- Antonio D'Andria (Autor), 2012, Identità e Storie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202322