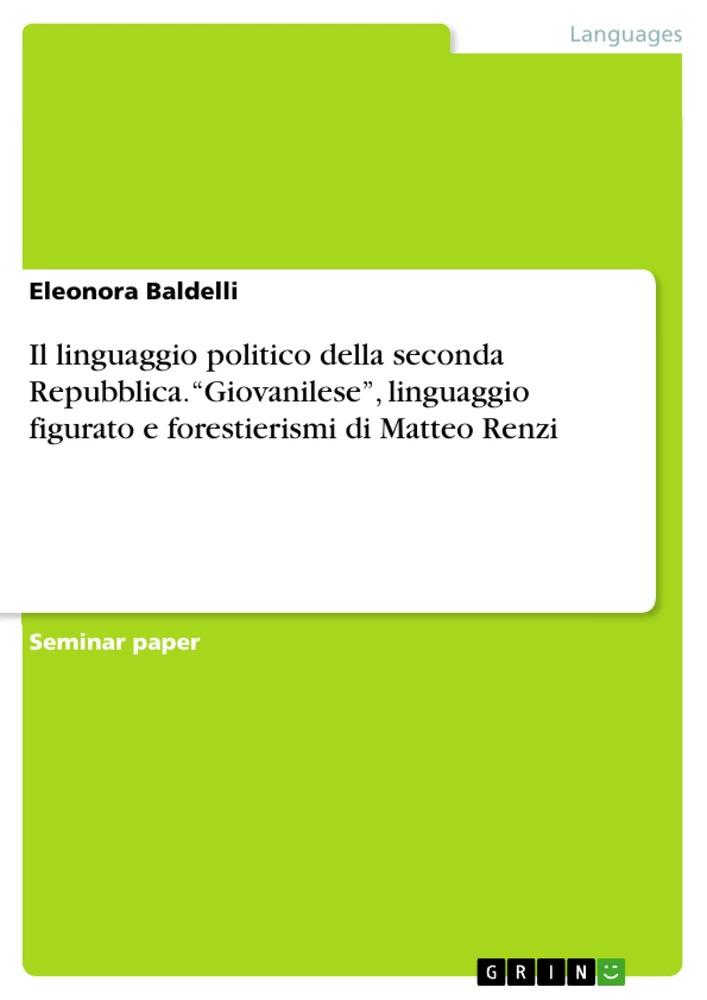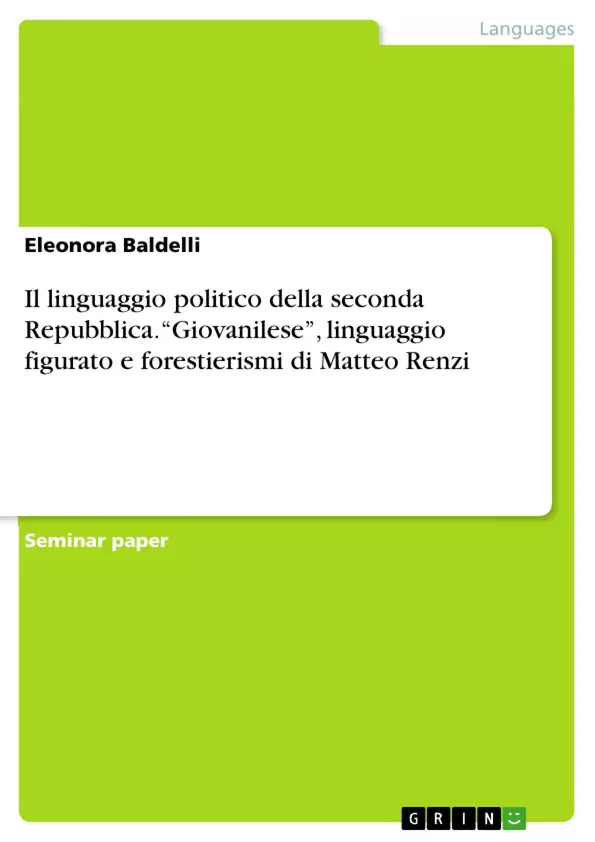Dopo aver definito l’espressione "lingue speciali" e averne illustrato le caratteristiche principali, in questo lavoro verranno analizzati i vari aspetti del politichese, con uno sguardo generale sul linguaggio politico dall’epoca fascista all’ascesa di Berlusconi fino ad arrivare ai giorni nostri, soffermandosi sul linguaggio usato da Matteo Renzi nei suoi discorsi politici.
Ne saranno analizzati in particolare alcuni aspetti, come l’utilizzo di un registro basso e popolare, la frequenza di anglicismi e giovanilismi, le metafore estratte dal mondo Scout e il linguaggio utilizzato su Internet. Successivamente questi elementi verranno confrontati con il politichese della prima e della seconda Repubblica per metterne in luce le eventuali somiglianze e differenze.
Si concluderà infine cercando di stabilire se, alla luce di queste ricerche, sia ancora possibile parlare di politichese o se il nuovo modo di fare politica porti inevitabilmente al cambiamento del registro linguistico.
Inhaltsverzeichnis (Indice)
- Introduzione
- Lingue speciali
- Il politichese
- Linguaggio politico della prima e della seconda Repubblica
- Matteo Renzi. Brevi cenni biografici
- Analisi della lingua di Renzi
- Il lessico
- La sintassi
- Il campo semantico dello scoutismo
- I giochi di parole
- I forestierismi
- I giovanilismi
- Conclusioni
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Obiettivi e Temi Principali)
Questo lavoro si propone di analizzare il linguaggio politico contemporaneo, confrontandolo con quello della Prima Repubblica, per verificare se il concetto di "politichese" sia ancora attuale. L'analisi si focalizza sul linguaggio di Matteo Renzi, esaminando l'utilizzo di specifici elementi linguistici.
- Evoluzione del linguaggio politico italiano dalla Prima alla Seconda Repubblica
- Analisi del "politichese" e la sua trasformazione
- Caratteristiche linguistiche del discorso politico di Matteo Renzi
- Influenza dei mass media sul linguaggio politico
- Confronto tra il linguaggio di Renzi e quello dei politici delle precedenti generazioni
Zusammenfassung der Kapitel (Riepilogo dei Capitoli)
Introduzione: Questo capitolo introduce il tema dell'analisi del linguaggio politico contemporaneo, partendo da un articolo di Luca Serianni che evidenzia la perdita di marcatezza ideologica nel discorso politico attuale e il conseguente tentativo di evitare il politichese tradizionale. Si discute della trasformazione del rapporto tra politico e cittadini, con l'avvento di un linguaggio più semplice e diretto, a partire dalla "discesa in campo" di Berlusconi. Il lavoro si propone di analizzare gli aspetti del politichese, soffermandosi sul linguaggio di Matteo Renzi, confrontandolo con quello della Prima Repubblica.
Lingue speciali: Il capitolo definisce il concetto di "lingua speciale" secondo Cortelazzo, evidenziando le sue caratteristiche lessicali e morfosintattiche. Si analizza la monosemia del lessico specialistico, i metodi di formazione delle nuove parole e la riduzione dei tempi verbali. Si discute inoltre dello scambio continuo tra lingua comune e lingue speciali, con l'influenza dei mass media.
Il politichese: Questo capitolo introduce il termine "politichese" e le sue caratteristiche principali, descrivendolo come un sottocodice della lingua italiana utilizzato nel linguaggio della politica, spesso criptico e incomprensibile. Si analizzano le strategie retoriche impiegate nel discorso politico per convincere e persuadere, sottolineando l'importanza dei canali di comunicazione e l'influenza dei mass media.
Linguaggio politico della prima e della seconda Repubblica: Il capitolo traccia un confronto tra il linguaggio politico della Prima e della Seconda Repubblica. Si analizza il linguaggio persuasivo di Mussolini nel Ventennio fascista, caratterizzato da slogan enfatici e una sintassi semplificata, e si confrontano gli stili di De Gasperi e Togliatti nel periodo post-fascista, evidenziando le differenze tra un linguaggio misurato e sobrio e uno più polemico.
Schlüsselwörter (Parole chiave)
Linguaggio politico, politichese, Prima Repubblica, Seconda Repubblica, Matteo Renzi, analisi del discorso, neologismi, giovanilismi, forestierismi, mass media, comunicazione politica.
Domande frequenti sull'analisi del linguaggio politico di Matteo Renzi
Quali sono gli argomenti trattati nel testo?
Il testo analizza il linguaggio politico contemporaneo, focalizzandosi sul linguaggio di Matteo Renzi e confrontandolo con quello della Prima Repubblica. Esplora l'evoluzione del "politichese", le caratteristiche linguistiche del discorso di Renzi (lessico, sintassi, uso di neologismi, forestierismi e giovanilismi), l'influenza dei media e il cambiamento nel rapporto tra politici e cittadini.
Quali sono le sezioni principali del testo?
Il testo è strutturato in diverse sezioni: Introduzione, Lingue speciali, Il politichese, Linguaggio politico della prima e della seconda Repubblica, Matteo Renzi: Brevi cenni biografici, Analisi della lingua di Renzi (con sottosezioni sul lessico, la sintassi, il campo semantico dello scoutismo, giochi di parole, forestierismi e giovanilismi), e Conclusioni. Include inoltre un indice, gli obiettivi e i temi principali, un riepilogo dei capitoli e le parole chiave.
Come viene definito il "politichese" nel testo?
Il "politichese" è descritto come un sottocodice della lingua italiana utilizzato in ambito politico, spesso caratterizzato da vaghezza, ambiguità e incomprensibilità. Il testo analizza la sua evoluzione dalla Prima alla Seconda Repubblica e come le strategie retoriche vengono impiegate per persuadere l'elettorato.
In che modo il linguaggio di Matteo Renzi viene analizzato?
L'analisi del linguaggio di Renzi si concentra su diversi aspetti: il lessico utilizzato (inclusi neologismi, forestierismi e giovanilismi), la struttura sintattica delle sue frasi, l'eventuale utilizzo di giochi di parole e il suo stile comunicativo generale. Viene inoltre considerato il contesto del suo discorso e l'influenza dei mass media.
Quali sono le differenze tra il linguaggio politico della Prima e della Seconda Repubblica?
Il testo confronta il linguaggio politico delle due Repubbliche, evidenziando le differenze stilistiche e retoriche. Si analizzano gli stili di leader politici di diverse epoche, evidenziando l'evoluzione del linguaggio politico in relazione ai cambiamenti sociali e tecnologici, in particolare l'impatto dei mass media.
Quali sono le parole chiave del testo?
Le parole chiave includono: linguaggio politico, politichese, Prima Repubblica, Seconda Repubblica, Matteo Renzi, analisi del discorso, neologismi, giovanilismi, forestierismi, mass media, comunicazione politica.
A chi è rivolto questo testo?
Il testo è rivolto ad un pubblico accademico interessato all'analisi del linguaggio politico, alla linguistica e alla comunicazione politica. L'approccio è strutturato e professionale, adatto per ricerche accademiche e analisi approfondite.
Qual è lo scopo principale dell'analisi?
Lo scopo principale è analizzare l'evoluzione del linguaggio politico italiano, verificando l'attualità del concetto di "politichese" e studiando come esso si manifesta nel discorso di un politico contemporaneo come Matteo Renzi. Si cerca di comprendere come il linguaggio politico si adatta ai cambiamenti nella società e nei media.
- Citar trabajo
- Eleonora Baldelli (Autor), 2015, Il linguaggio politico della seconda Repubblica. “Giovanilese”, linguaggio figurato e forestierismi di Matteo Renzi, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306064