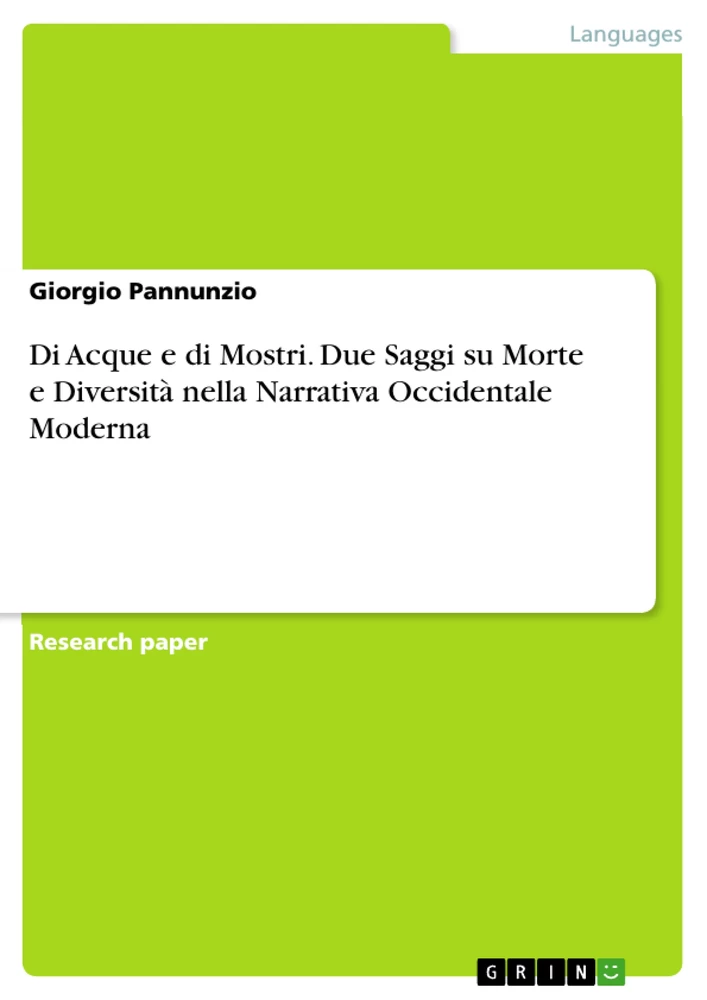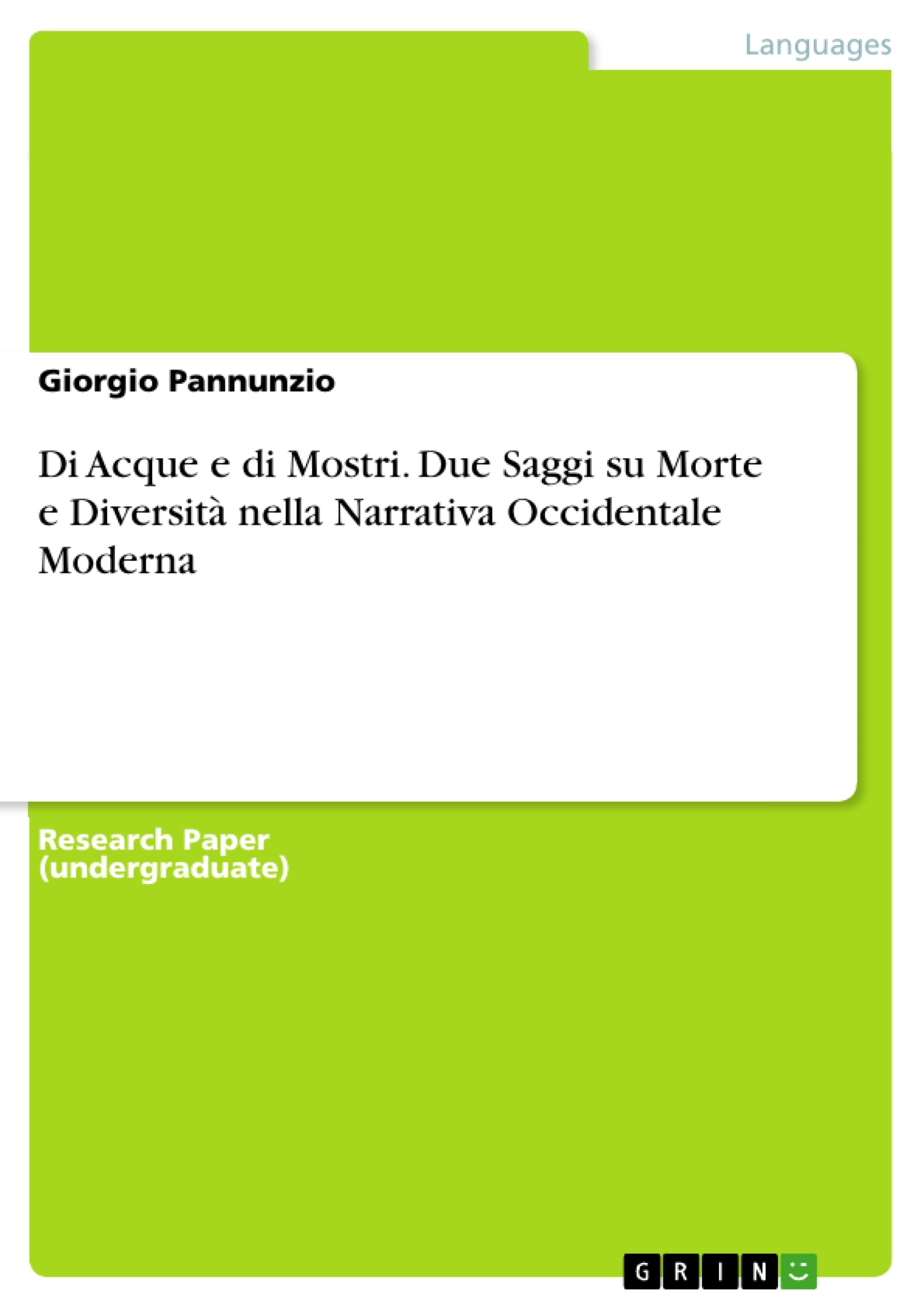Questi due saggi, ora accorpati in un unico volume, sono stati scritti con l’intenzione di porre in evidenza quali siano i confini entro cui si delinea il paradigma della diversità all’interno delle vicende esistenziali dell’uomo moderno. Il primo rappresenta la descrizione di un sintagma retorico, quello attinente alla topica dei bambini annegati all’interno di taluni romanzi ottocenteschi e novecenteschi. Il secondo si occupa di un elemento di diversità stavolta non soltanto psicologico e antropologico (la perdita precoce quale inaccettabile “vulnus” all’equilibrio di chi la subisce), ma decisamente fisico, trattando della ricezione della mostruosità nello stesso ambito letterario “fin de siécle” e nella prima parte del secolo XX. Entrambi gli escerti sono corredati da numerosi testi (ove possibile in lingua originale).
Inhaltsverzeichnis
- Di incomprensioni vere e d'annegamenti parodici
- Bambini in acque profonde: il motivo dell'annegamento dei fanciulli in alcuni testi narrativi occidentali d'epoca contemporanea
- Una premessa militaresca:il caso di Erno Nemecsek
- Una donna tra i fanciulli
- Il dialettico annegamento di Ombretta
- L'adulterio magico e il duplice figlio
- I pentimenti del pacifista e le lacrime dei giornali (ossia d'annegamenti controversi)
- Un borgataro tra Masters e la Valsolda
- E in finale approdo...
- Bambini in acque profonde: il motivo dell'annegamento dei fanciulli in alcuni testi narrativi occidentali d'epoca contemporanea
- Il mostro e la folla. Qualche esempio di deformità e falsa accettazione nella cultura europea tra '800 e 900
- Premesse e comparazioni
- Il fakiro multiforme e la bella addormentata
- L'elefantiasi degli autori moderni (e post... )
- Un rituale di fine e una violazione d'inizio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem Motiv des Ertrinkens von Kindern in der modernen westlichen Literatur. Der Autor untersucht die literarische Tradition dieses Themas und analysiert, wie es in verschiedenen Werken verwendet wird, um verschiedene Themen und Konzepte zu erforschen.
- Die Darstellung von Tod und Verlust in der Literatur
- Die Rolle der Kindheit in der Gesellschaft und in der Literatur
- Die Verwendung von Wasser als Symbol in der Literatur
- Die Bedeutung von Krieg und Gewalt in der Literatur
- Die Konfrontation mit dem Unbekannten und der Andersartigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Essays konzentriert sich auf die Figur des Erno Nemecsek aus Ferenc Molnárs „Die Jungen der Pál-Straße“. Der Autor argumentiert, dass die Figur des Nemecsek eine symbolische Bedeutung für die Zeit des Ersten Weltkriegs hat und die Ideale des Nationalismus und der Kriegsführung widerspiegelt.
Das zweite Kapitel analysiert den Roman „Die Jungen der Pál-Straße“ in Bezug auf das Motiv des Ertrinkens von Kindern. Der Autor untersucht die verschiedenen Bedeutungen des Wassers in der Geschichte und argumentiert, dass es als Symbol für die Unschuld, die Gefahr und die Unberechenbarkeit des Lebens verwendet wird.
Im dritten Kapitel analysiert der Autor den Roman „Die Jungen der Pál-Straße“ in Bezug auf die Figur des Erno Nemecsek. Er argumentiert, dass die Figur des Nemecsek eine symbolische Bedeutung für die Zeit des Ersten Weltkriegs hat und die Ideale des Nationalismus und der Kriegsführung widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Essays sind: Ertrinken, Kindheit, Tod, Verlust, Wasser, Krieg, Gewalt, Symbolismus, Literatur, Moderne, Westliche Literatur, Ferenc Molnár, „Die Jungen der Pál-Straße“.
Häufig gestellte Fragen
Womit beschäftigen sich die zwei Essays in diesem Werk?
Die Essays untersuchen das Paradigma der Diversität, den Tod und die "Mostruosità" (Monstrosität) in der modernen westlichen Erzählliteratur.
Welche Rolle spielt das Motiv des Ertrinkens von Kindern?
Das Ertrinken wird als rhetorisches Syntagma und Symbol für den Verlust von Unschuld und die Unberechenbarkeit des Lebens analysiert.
Wer ist Erno Nemecsek und warum ist er wichtig?
Nemecsek ist eine Figur aus Ferenc Molnárs „Die Jungen der Pál-Straße“; er symbolisiert Ideale des Nationalismus und die Opferbereitschaft zur Zeit des Ersten Weltkriegs.
Was wird im zweiten Essay unter Monstrosität verstanden?
Es geht um physische Deformität und deren Wahrnehmung sowie "falsche Akzeptanz" in der europäischen Kultur zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert.
Welche literarische Epoche wird schwerpunktmäßig untersucht?
Der Fokus liegt auf der Literatur des "Fin de Siècle" und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
- Citar trabajo
- Giorgio Pannunzio (Autor), 2015, Di Acque e di Mostri. Due Saggi su Morte e Diversità nella Narrativa Occidentale Moderna, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306534