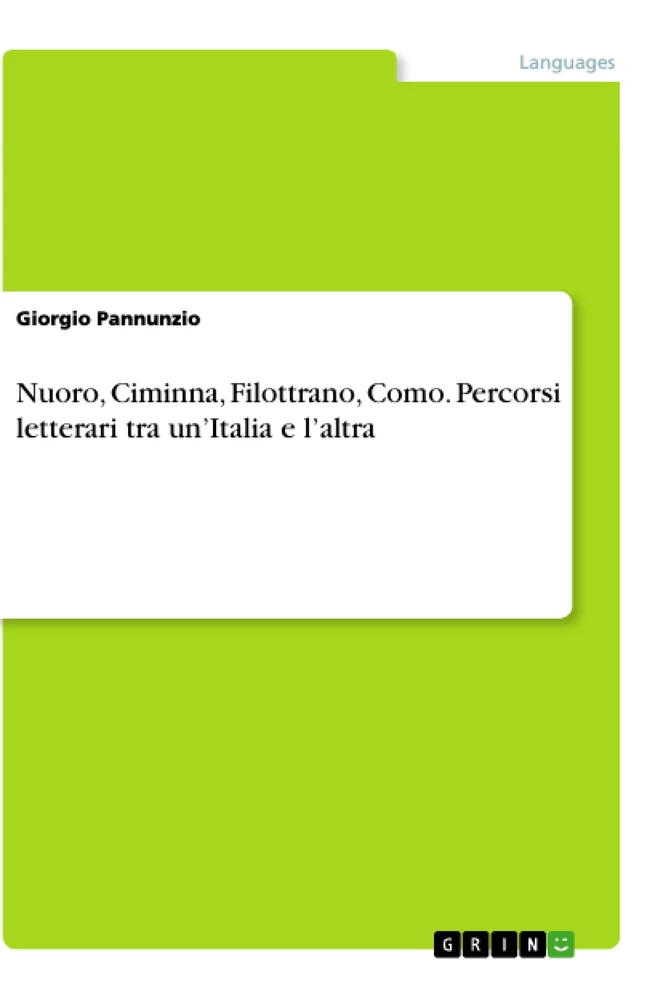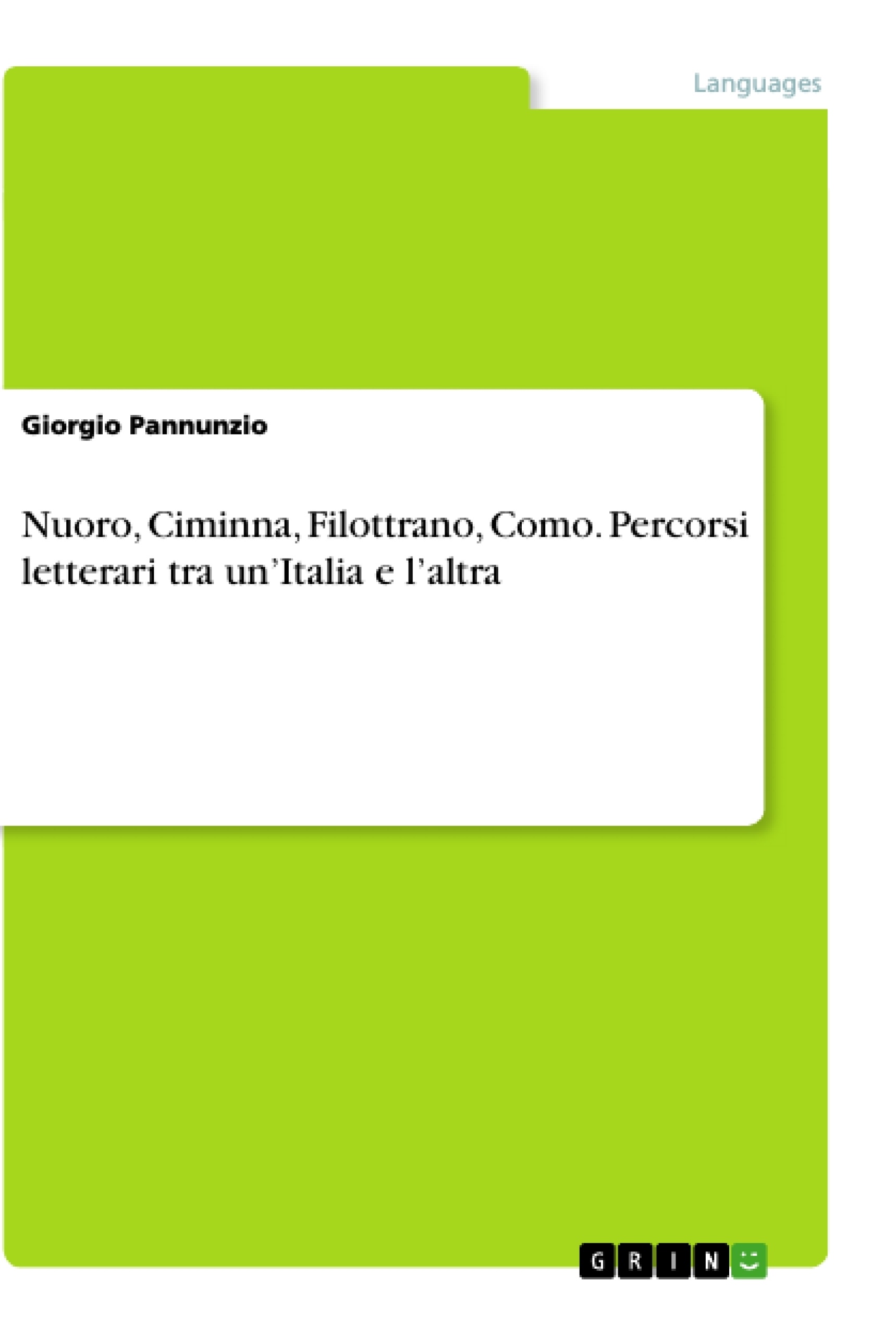I saggi inseriti all’interno del volume di Giorgio Pannunzio, due di essi inediti (e un terzo rielaborato pesantemente rispetto all’originale) vogliono individuare un sentiero che si proponga di mediare tra il versante critico più propriamente afferente il dato storico-geografico e una visione (semasiologica e più vicina al modello delle letterature comparate) che ne approfondisca i contorni. In altre parole, se i confini della ricerca sono ascrivibili al modello che si potrebbe definire localistico, il territorio centrale su cui la ricerca medesima si svolge è certamente più complesso e più fecondo di spunti e di ispirazioni. Così, se da un lato troviamo un interessante intervento sulla dimensione tipologica delle descrizioni di briganti in ambito siciliano, dall’altro possiamo spaziare sulla problematica della tentazione carnale nei romanzi deleddiani d’ambiente agreste, con un’estroflessione – tutta giocata, appunto, tra dato regionalistico (Ancona) e evento storico (la teologia medievale) – dove i dati ermeneutici di partenza sono aggrovigliati tra di loro in modo tale da rendere indistinguibile il diverso dipanarsi dei vari percorsi d’approfondimento. Il testo di Pannunzio, concluso da una gustosa frecciatina al variegato mondo delle recensioni letterarie lombarde, si propone dunque come un viaggio all’interno delle varie zone in cui l’Italia è proverbialmente divisa, quasi che per l’autore teatino il Nord e il Sud, nonché il Centro e le Isole – come elementi geografici e letterari assieme – possano riflettere le "diverse italie" di Italo Calvino, spesso rimaste del tutto "inedite per la letteratura", com’egli ebbe a definirle in un contesto socio-culturale ormai del tutto remoto
Inhaltsverzeichnis
- MARIELLA MARCELLO. PRETI TENTATI E AFFLIZIONI AMOROSE IN GRAZIA DELEDDA.
- TESTO DELEDDA
- TESTO MANZONI
- TESTO D'ANNUNZIO
- TESTO DELEDDA
- TESTO DELEDDA
- TESTO MANZONI
- UN BRIGANTE GENTILUOMO A CIMINNA: QUALCHE APPUNTO D'ESEGESI COMPARATA
- TESTO DUMAS
- TESTO SALGARI
- Come distruggere un poeta e vivere (entrambi) felici: il caso di Fernando Valcamonica
- TESTO VALCAMONICA
- TESTO TORTI
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert die Thematik der Versuchung durch den Teufel in der europäischen Literatur am Beispiel des Werkes von Grazia Deledda. Es werden die zentralen Elemente der literarischen Behandlung dieses Themas in Deleddas Werken, insbesondere die Figuren von Elias Portolu und Don Paulo in ihren jeweiligen Romanen, beleuchtet. Der Text untersucht die Verbindung dieser Figuren zu ähnlichen Figuren in anderen europäischen Literaturwerken, insbesondere zu Amaro in Eça de Queiros' "Der Mönch von Farinha", und untersucht die verschiedenen Aspekte der Versuchung und des Strebens nach Heiligkeit in Deleddas Werken.
- Die Darstellung der Versuchung durch den Teufel in der Literatur
- Analyse der Figuren von Elias Portolu und Don Paulo in Deleddas Werken
- Vergleich mit ähnlichen Figuren in anderen europäischen Literaturen
- Die Bedeutung der Heiligkeit und des Strebens danach in Deleddas Werken
- Die Verbindung von regionalen Themen und religiösen Motiven
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der Versuchung durch den Teufel in der europäischen Literatur einführt und auf Deleddas Behandlung dieses Themas fokussiert. Der Schwerpunkt liegt auf zwei Figuren, Elias Portolu und Don Paulo, deren Lebenswege durch die Versuchung, die Sehnsucht nach Heiligkeit und die Beziehung zu Frauen geprägt sind. Der Text vergleicht die Figur von Elias Portolu mit Amaro in Eça de Queiros' Werk und zeigt Parallelen in ihren Lebensgeschichten und den Konflikten, die sie durchleben. Der Text betrachtet auch die Figur von Don Paulo und die Rolle der Mutter in seinen inneren Kämpfen und seinen Entscheidungen. Der Text beleuchtet auch die religiösen und gesellschaftlichen Aspekte des Themas, insbesondere die Bedeutung von Heiligkeit und die Rolle der Kirche in der Lebenswelt der Figuren. Der Text befasst sich mit der Frage, wie Deledda die Versuchung und das Streben nach Heiligkeit in ihren Romanen darstellt, und untersucht die sprachlichen und literarischen Mittel, die sie einsetzt, um diese Themen zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Versuchung, Teufel, Heiligkeit, Literatur, Deledda, Elias Portolu, Don Paulo, Amaro, Europa, Italien, Religion, Gesellschaft, Kirche, Roman, Literaturanalyse, Figuren, Charakter, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Thema der Versuchung in Grazia Deleddas Werk behandelt?
Deledda stellt die inneren Kämpfe von Figuren wie Elias Portolu und Don Paulo dar, die zwischen religiöser Berufung und menschlichem Verlangen stehen.
Wer ist Elias Portolu?
Eine zentrale Figur in Deleddas Roman, die nach der Rückkehr aus dem Gefängnis mit der Versuchung und dem Streben nach Heiligkeit ringt.
Welche Parallelen gibt es zwischen Deledda und anderen europäischen Autoren?
Der Text vergleicht ihre Figuren mit denen von Eça de Queiros, um die universelle literarische Behandlung von Sünde und Erlösung aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die sardische Landschaft in den Romanen?
Die agreste (ländliche) Umgebung dient oft als Spiegel für die archaischen und tiefreligiösen Konflikte der Protagonisten.
Was bedeutet "Heiligkeit" in diesem literarischen Kontext?
Heiligkeit wird als ein oft unerreichbares Ideal dargestellt, das im Kontrast zur menschlichen Schwäche und gesellschaftlichen Zwängen steht.
- Citar trabajo
- Giorgio Pannunzio (Autor), 2019, Nuoro, Ciminna, Filottrano, Como. Percorsi letterari tra un’Italia e l’altra, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503599